di Gioacchino Toni
 Nel suo recente libro Sociologia del rischio (2017), come abbiamo visto [su Carmilla], David Le Breton, docente di Sociologia e Antropologia presso l’Università di Strasburgo, si è concentrato sul ruolo del rischio e della paura nella vita degli individui in una contemporaneità caratterizzata dall’insicurezza sociale. Secondo lo studioso sarebbe la voglia di vivere a dominare quei comportamenti a rischio, soprattutto giovanili, che si manifestano come un’interrogazione dolorosa del senso della vita. Sarebbe proprio la sensazione d’impotenza provata di fronte a un ambiente circostante vissuto come immodificabile a determinare il ricorso a pratiche pericolose per l’incolumità personale.
Nel suo recente libro Sociologia del rischio (2017), come abbiamo visto [su Carmilla], David Le Breton, docente di Sociologia e Antropologia presso l’Università di Strasburgo, si è concentrato sul ruolo del rischio e della paura nella vita degli individui in una contemporaneità caratterizzata dall’insicurezza sociale. Secondo lo studioso sarebbe la voglia di vivere a dominare quei comportamenti a rischio, soprattutto giovanili, che si manifestano come un’interrogazione dolorosa del senso della vita. Sarebbe proprio la sensazione d’impotenza provata di fronte a un ambiente circostante vissuto come immodificabile a determinare il ricorso a pratiche pericolose per l’incolumità personale.
Se ad essere indagato dal recente volume è il rischio deliberatamente scelto come via di fuga da un contesto vissuto dall’individuo come ostile, è però da tempo che lo studioso analizza le modalità con cui gli esseri umani tentano di rispondere al malessere che li affligge. Incisioni, scorticature, scarificazioni, bruciature, escoriazioni, lacerazioni…, le lesioni corporali autoinflitte da uomini e, soprattutto, donne sono al centro di La Peau et la Trace. Sur les blessures de soi, saggio uscito in Francia nel 2003, poi tradotto e pubblicato in italiano nel 2005 da Meltemi, dunque riproposto dal medesimo editore nel 2016. La pelle e la traccia. Le ferite del sé rappresenta un importante studio condotto da David Le Breton sulle lesioni corporali autoinflitte deliberatamente dagli individui, principalmente in età adolescenziale, nel contesto della società contemporanea occidentale.
Secondo lo studioso l’epidermide è diventata la superficie d’iscrizione del malessere di tanti individui che modificano il proprio corpo spesso perché non riescono ad incidere sull’ambiente circostante. Tali ferite corporali non sarebbero un indice di follia, ma una forma di lotta, per quanto particolare, contro il male di vivere contemporaneo. L’alterazione del corpo sembrerebbe rispondere a un bisogno di ridefinizione di sé in una situazione dolorosa: un tentativo di andare oltre il socialmente consentito per provare qualcosa di forte nel corso di una vita normale percepita come inadeguata e insufficiente.
Aggredendosi e/o facendosi sanguinare, l’individuo infrange la sacralità sociale del corpo dando vita a un gioco simbolico con la morte e, come accade per i comportamenti a rischio, pur su un altro piano, le ferite inflitte al corpo si rivelano un mezzo estremo di lotta contro la sofferenza, oltre che di ri-costruzione identitaria. Ne La pelle e la traccia Le Breton non intende analizzare pratiche derivanti da una volontà dissimulata di morire, ma al contrario da una volontà di vivere.
È ovvio che si tratta di un percorso ambivalente – la ricerca di sé conduce lungo strade tortuose. Per partorire il sé, a volte, è necessario rischiare di perdersi – non per scelta, ma per necessità interiore: la sofferenza o la mancanza di essere erodono il rapporto con l’esistenza, separandola da noi. Nei comportamenti analizzati in questo libro si gioca d’astuzia con la morte o il dolore, per riuscire a produrre un senso di cui fare uso personalmente – e ri-mettersi al mondo […] Quando l’esistenza non si presenta più sotto gli auspici del senso e del valore, l’individuo dispone ancora di un’ultima risorsa: sottrarre spazi poco frequentati al rischio di perire. Gettandosi contro il mondo, lacerandosi o bruciandosi la pelle, egli cerca in realtà una garanzia per se stesso – mette alla prova la sua esistenza, il suo valore personale. Se non ha più dinanzi a sé il percorso del senso, tracciato in modo chiaro, è necessario che si confronti col mondo mediante l’invenzione di riti intimi – quasi di contrabbando. Sacrificando una piccola parte di sé nel dolore, nel sangue, l’individuo si sforza di salvare l’essenziale; infliggendosi un dolore controllato, lotta contro una sofferenza infinitamente più intensa (pp. 9-10).
Nella sezione intitolata “L’incisione nella carne: tracce e dolori per esistere”, l’autore ragiona anche sui motivi che determinano un ricorso maggiore alle lesioni corporali autoinflitte da parte femminile e tende a ricondurre ciò a una maggiore interiorizzazione della sofferenza da parte delle donne rispetto agli uomini che invece tendono a tradurla in aggressività rivolta contro l’esterno. Se la donna assume su di sé lo sconforto, l’uomo, invece, sembrerebbe più incline a proiettarsi contro il mondo in ossequio all’obbligo di condotte “virili” a cui è stato educato. Interiorizzando la propria disperazione, la donna sarebbe indotta
a mettere in luce più spesso una fragilità che va di pari passo coi criteri di seduzione che le vengono imposti. Che si pieghi dinanzi al dolore, è nell’ordine naturale delle cose. Ma rivolgendo la sua sofferenza – cioè la sofferenza che è nella vita – contro la propria pelle, la donna rifiuta anche il modello della seduzione – un modello che la soffoca e fa del suo aspetto il principale criterio di valutazione di ciò che è, laddove l’uomo viene di preferenza giudicato in base alle azioni che compie. Per queste ragioni, la donna afferma di essere sempre “a fior di pelle”; e a volte, quando ne ha abbastanza, cancella la pelle con gesti carichi di rabbia (pp. 32-33).
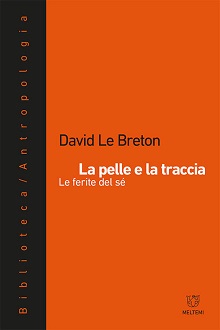 Non è pertanto un caso che artiste come Gina Pane e Orlan nell’attentare al proprio corpo suscitino maggiore fastidio e resistenza sociale rispetto ad artisti uomini. «Queste artiste, del resto, si fanno interpreti di un’analisi politica del proprio corpo e dei pesanti vincoli sociali che le tengono rinchiuse nella loro condizione: possibile che una donna, di cui si dice che deve essere fragile, dolce, latrice di vita ecc., sia in grado di far scorrere il proprio stesso sangue o di “rovinare” il proprio corpo?» (p. 33).
Non è pertanto un caso che artiste come Gina Pane e Orlan nell’attentare al proprio corpo suscitino maggiore fastidio e resistenza sociale rispetto ad artisti uomini. «Queste artiste, del resto, si fanno interpreti di un’analisi politica del proprio corpo e dei pesanti vincoli sociali che le tengono rinchiuse nella loro condizione: possibile che una donna, di cui si dice che deve essere fragile, dolce, latrice di vita ecc., sia in grado di far scorrere il proprio stesso sangue o di “rovinare” il proprio corpo?» (p. 33).
In generale l’attentato nei confronti del proprio corpo avviene in solitudine e risponde frequentemente all’insufficienza del vivere. «Esistere non basta più: bisogna sentirsi esistere. Per porre fine allo sgretolamento di sé e all’inconsistenza dell’immagine del corpo, ci vuole un sovraccarico di sensazioni […] Quando si perde ogni contatto con l’ambiente circostante, quando ci si sente insignificanti, non c’è davvero più altra via di scelta: esisto perché mi sento, e il dolore lo attesta» (p. 57). Certo, il significato della lesione corporale è molteplice; il gesto può derivare anche da un’intenzione espiatoria o di purificazione.
Nel libro, oltre che al contesto adolescenziale, viene prestata particolare attenzione anche alle ferite corporali intenzionali praticate dagli individui durante lo stato di reclusione – “Lesioni corporali deliberatamente inflitte in situazione carceraria” – e nell’ambito artistico – “Intaccare se stessi: dalla body art alle performance”.
La sezione finale del volume – “La parte del fuoco: un’antropologia dei limiti” – è invece dedicata all’incisione come forma di lotta contro la sofferenza e, in generale, alle ferite autoinflitte all’interno di un’epoca segnata dalla negazione sociale della morte, epoca in cui il morire e la morte hanno smesso di far parte dell’ordine simbolico. «Oggi la morte è vista come un non-luogo, l’antitesi di un’esistenza divenuta positività pura, in grado di fissare, di eternare il tempo – mentre la morte è un processo insostenibile di dissipazione e decadimento» p. 154). Riconquistando il controllo sul proprio corpo attraverso azioni su di esso, l’individuo sollecita
un’istanza metafisica che possa fargli ritrovare la legittimità di esistere, ma affrontando necessariamente il rischio di perdersi: si tratta di fabbricare l’identità con il dolore o la morte, riprendendosi l’iniziativa sotto forma di una sfida o di un passaggio all’atto […] Poiché la società ha fallito nel suo compito di orientamento simbolico, il soggetto interroga un’istanza al di là di essa: il suo è un ignoto rito oracolare, un rito intimo che offre risposte radicali alle domande sul valore dell’esistenza. Ma consultare l’oracolo ha il suo prezzo. Fabbricando il sacro a uso personale, suscitando una forma di trascendenza attraverso il dolore o il rischio di morte l’individuo cerca in realtà di ridefinire se stesso. Il sacrificio di una parte di sé lo strappa al quotidiano, e in particolare alla routine della sua sofferenza; all’improvviso il soggetto è proiettato altrove, su un altro scenario esistenziale che tuttavia lui stesso ha reso possibile giocando la parte del fuoco. In questo caso il sacrificio non è uno scambio interessato con gli dei, perché ignora ciò che vuole ottenere; si impone all’individuo e al suo corpo che tenta di difendersene, ma è anche una forza che agisce – perché restaura un senso di identità ormai a pezzi. La sua espressione è un dolore liberamente accolto: è la traccia sulla pelle ma voluta, traccia che riassume in sé una sofferenza più vasta consentendo all’individuo di circoscriverla e superarla. L’incisione è insomma una risposta inconscia ma potente al senso di caos che minaccia di trascinar via ogni cosa. Attraverso la ferita, l’individuo paga in anticipo il prezzo del suo sollievo. Questa temibile formula del sacrificio ha in sé un paradosso: si origina e termina nell’individuo, destinatario ultimo della ricerca il cui fine è dare nuovo slancio all’esistenza. Ma si tratta di un processo che non è cosciente di sé […] Attentando al proprio corpo, l’individuo offre la parte per il tutto senza davvero sapere a chi si sta rivolgendo, e anzi addirittura ignorando il fine ultimo del suo gesto. Privandosi di una parte di sé, ponendo anche solo per un attimo l’accento sul dolore ma poi riprendendo in mano il controllo – e dunque cessando di essere in balia della corrente senza fine del male di vivere – chi sacrifica è in grado di ricevere in cambio il sollievo o quantomeno un momento di tregua – se non addirittura, chissà, un’epoca di totale remissione della sua disperazione (pp. 151-152).
Linee di fuga: serie completa



