di Davide Grasso (qui il suo blog)
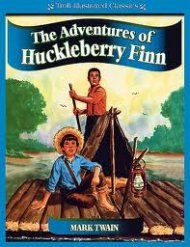 “Le persone che in questa narrazione cercassero di trovare dei fini saranno perseguite legalmente; quelle che cercassero di trovarvi una morale saranno esiliate; quelle che cercassero di trovarvi una trama saranno giustiziate”
“Le persone che in questa narrazione cercassero di trovare dei fini saranno perseguite legalmente; quelle che cercassero di trovarvi una morale saranno esiliate; quelle che cercassero di trovarvi una trama saranno giustiziate”
Mark Twain
Quando migliaia di egiziani, sui ponti del Nilo, impedirono l’avanzata della polizia a costo di fermare le autoblindo con le loro stesse carni, mi trovavo di fronte a un altro fiume, il Mississippi. Ero a New Orleans, e avevo appena visto le immagini mosse e confuse della CNN, dove mezzibusti e inviati si alternavano a donne arabe e immagini di strade buie, quartieri poco illuminati, dove si diceva che i saccheggi dilagassero e le persone si affrontassero con i bastoni e i coltelli in mano, divisi tra avversari e sostenitori del presidente, o tra proprietari di negozi e saccheggiatori. Comparve sugli schermi Hillary Clinton, in diretta, oltre i titoli delle breaking news che scorrevano sotto lo schermo: imbarazzata, l’espressione vagamente spaventata, invitò gli egiziani ad astenersi dalla violenza. Mi stupì si potesse pensare che quelle persone volessero comportarsi secondo le indicazioni del segretario di Stato, proprio nel momento in cui smettevano di dare ascolto alle loro autorità (verso lo Stato del segretario, peraltro, da sempre compiacenti). Il monito statunitense era rivolto a una popolazione, questa volta, non a un governo; sarebbe rimasto inascoltato.
La vista del Mississippi, quel giorno, mi fece pensare a un romanzo che stavo leggendo, Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain, ambientato proprio lungo quel fiume; fu scritto sullo sfondo del profondo ottocento nordamericano, negli States selvaggi che circondavano le sue rive. È la storia di un ragazzino, Huck, che decide di fuggire dal padre violento, su una zattera. Pensava di essere una canaglia, uno zoticone, un bambino riuscito male, buono più per il Diavolo che per Gesù, perché non era mai stato in grado di accontentare le richieste delle persone che avevano cercato di educarlo. Prima che il padre lo rapisse di nuovo, per portarlo nella capanna da cui sarebbe fuggito, un giudice lo aveva affidato alla vedova Douglas e a sua sorella, miss Watson: le due donne lo avevano obbligato per mesi a pregare e a leggere la Bibbia, a tenere la schiena dritta, a non stiracchiarsi e a non allungare i piedi sulla sedia, e questo per “vivere in modo da andare a finire nel Posto Bello”. Lui, però, preferiva non andarci, pensava, pur di non stare in un posto dove c’erano anche loro. Ora affondava la pagaia nel fiume, rifugiandosi nella natura grande e orrenda di cui, pur sconvolto da mille paure, imparava ad apprezzare più di prima il carattere grandioso e sereno, l’apertura verso l’ignoto e i larghi spazi.
Leggere quel racconto fu per me come trovare nell’opera di qualcun altro — esperienza frequente — l’esposizione perfetta di un pensiero che avevo coltivato da sempre. È incredibile la dolcezza con cui l’autore riesce a trasmettere un messaggio apparentemente semplice, eppure difficile da trasporre in parole o immagini. Durante una sosta sulla terraferma, il bambino si era imbattuto nello schiavo della vedova in fuga, mentre questi tentava di raggiungere gli stati abolizionisti del nord, e lo aveva imbarcato sulla zattera. Aveva compiuto questo gesto non senza esitazioni e rimorsi, perché consapevole di agire in modo sbagliato: sapeva, come tutti, che i neri erano esseri inferiori ai bianchi, e che le leggi proibivano di sottrarre la proprietà altrui; lui stava facendo anche di peggio, ponendo le basi per l’annullamento alla radice di quella proprietà. Per agire nel modo giusto avrebbe dovuto rispettare la legge e la morale da tutti condivisa, ma ignorò la sua coscienza acerba per egoismo; preferì, al suo immaturo senso del dovere, la costruzione di un’amicizia, il vantaggio di avere compagnia nei grandi e colpevoli silenzi che facevano da cornice alla sua fuga, nell’impenetrabilità delle nebbie e delle paludi che in essa lo terrorizzavano. Come accade tipicamente ai bambini, fu al tempo stesso indulgente e spietato con sé stesso: divorato dal desiderio di fare ciò che più gli piaceva e perseguitato dal rimorso per aver commesso qualcosa di proibito.
Come molte altre volte nel libro, avrebbe superato il senso di colpa con un fatalismo masochista e oscuro: era uno zoticone e una canaglia, una faccia da schiaffi; lo sapeva per le botte che aveva preso, e per la sua incapacità a smettere di stiracchiarsi o sbadigliare durante le lezioni di miss Watson, o di allungare i piedi sulla sedia, di pensare male di Dio. Si considerava dannato, irrecuperabile; cucinato alla perfezione per il Posto Brutto, non per quello Bello. Come spesso accade, il pensiero sofferente dell’ineluttabilità dei propri comportamenti serve anche a spalancare le porte ai propri piaceri. I suoi stati d’animo ignoravano, eppure spalancavano l’abisso che si apre a chi scopre, con l’esperienza o con il pensiero, la gravità crudele del compito che s’impone a chi possiede una morale che sia cosciente del potere della trasformazione. Per affermare il bene — la libertà dello schiavo, la liberazione dalle violenze del padre — occorre commettere il male: la fuga, l’evasione, l’infrazione della legge, molte altre cose forse; la contraddizione di ciò che tutti considerano giusto, scontato, magari eterno. Tutti: padri e vedove, giudici e padroni, folli e banditi; bambine candide e pastori generosi, madri pietose e cow-boy; i mille personaggi, fiabeschi e veritieri a un tempo, che i due fuggiaschi incontrarono, e da cui dovettero difendersi, durante tutto il lungo viaggio.
Il male di ieri è bene oggi, e il bene di oggi sarà male domani. Verità banale, da cui nessuno trae le fondamentali conseguenze; e non intorno al rapporto tra mezzi e fini, giacché qui sono soltanto i fini a imporre i loro valori contrastanti, in tempi diversi. Ai primi di gennaio avevo incontrato una mia amica a Manhattan, Jelena. Parlammo della Tunisia: Mohamed Bouazizi era morto e la sommossa iniziata in dicembre era diventata qualcosa di più grande. Per lei, una volta terminata la mobilitazione, le autorità avrebbero pulito le strade e tutto sarebbe tornato come prima. Gli eventi in corso potevano anche condurre alle dimissioni dell’odiato presidente, o a una riforma dello stato, ma questo non avrebbe cambiato il destino penoso di quelle persone, né la brutalità dei rapporti politici, là o altrove. Tentai di contrapporre a questo disincanto una visione che consideravo realistica, e che rendesse maggiore giustizia ai cambiamenti di cui il mondo è sempre stato capace. Far parte di un movimento cambia l’esistenza, perché cambia la percezione, prima ancora che del mondo, di sé stessi. Costruire una zattera di nascosto, contro l’avviso del padre, della vedova e del giudice, spalanca orizzonti; farci salire uno schiavo in fuga muta l’equilibrio tra sé e la terraferma. I ragazzi scesi in strada l’8 gennaio, a Tunisi, avevano sfidato un sistema di leggi e valori che andava oltre il loro paese.
Avevo visitato la Tunisia dieci anni prima; gli uscieri degli alberghi mi chiedevano l’elemosina, e in ogni negozio appariva la foto del presidente, scelto dal mio paese per un’altra popolazione, subìto dagli sconosciuti che incrociavo per strada. Era stato installato dalle democrazie occidentali, in particolare dall’Italia, nel 1987, con un colpo di stato pilotato dal Sismi. Vedevo per la prima volta una dittatura, dall’interno, e parlai a un ragazzo che, seduto sul suo calesse, dichiarò sprezzante di non credere in Dio. Ora, di fronte al Mississippi, pensavo alle acque del mio continente, dall’altra parte del mondo: le acque del Sud, dove tante volte mi ero bagnato, attraversate da migliaia di ragazzi come lui, e forse da lui stesso, che salpavano su imbarcazioni pericolose come zattere, abbandonando la terraferma verso la Sicilia, l’Italia e l’Europa, di cui avevano smontato il burattino, sconfitto il presidente. Gran parte degli egiziani, in quelle ore, al cuore dell’equilibrio più delicato, si mostrava pronta a mettere in discussione l’ordinamento del paese, la sua struttura interna, le sue relazioni esterne. Per cosa accettare abusi, disoccupazione, corruzione? Per essere la stampella di Israele?
Quando il segretario di stato apparve in TV, il 28 gennaio, sembrava una povera, grande miss Watson, preoccupata che il mondo prendesse il largo su una zattera, e di doverlo bombardare da cima a fondo per riportarlo a riva. Otto anni prima gli iracheni avevano aspettato i bombardamenti sulle loro teste come un bambino attende le botte del padre violento, ogni volta che torna a casa. Ho coltivato, dopo i bombardamenti su Baghdad, l’ammirazione per i resistenti iracheni, che si sono mostrati folli abbastanza da apparire indistruttibili, più tenaci del dogma stesso della loro sconfitta. Gli egiziani hanno iniziato, mi sembra, una guerra nuova e diversa da quella che là si è combattuta: anch’essa globale, asimettrica, non dichiarata e permanente; anch’essa iniziata di fatto, anche se da una popolazione e non da uno stato, a nome di tutto il mondo. La novità è che questa guerra, contrariamente a quella, è stata in grado, in un anno, di devastare ogni certezza sul secolo; e questa incertezza conserva memoria dei ponti del Nilo in due diversi modi, con due diversi sguardi.
Il primo sguardo è quello dalla terraferma, da cui quei ponti appaiono l’adeguamento, pur conflittuale e complesso, di una parte del mondo all’orologio dell’altra parte, una conciliazione più che uno squarcio. Ma il secondo sguardo proviene dal letto del fiume. Per esso i ponti sono un delitto che chiama nuovi delitti, da estendere in ogni paese perché il mondo intero segua, in un modo o nell’altro, il destino del Cairo. Visti dal fiume i ponti non sono il bene, ma il male dell’oggi, che è necessario trasformare in un bene diverso da quello della sua narrazione presente. Sono ciò che deve permettere di pensare il presente a partire dalla sua negazione, di vedere la terra dai suoi corsi d’acqua: è uno sguardo che scompagina la trama, non la conclude; offende la morale corrente, non le si inchina; nega alla radice le finalità del diritto contemporaneo, non le invera. Triste è lo sguardo di chi si compiace della conquista perenne delle verità per cui si era combattuto ieri; sempre urgente, invece, quello per cui l’esistenza appare un susseguirsi continuo di rive e di zattere, sulle quali occorre ogni volta produrre un male nuovo, che si commetta con sufficiente entusiasmo. Poco importa se, nell’economia generale della storia, non esisterà mai un bene abbastanza durevole da poter essere, di questo male, il fine. Su questo fiume si tende la mano per egoismo. È il Mississippi che abbiamo scelto.



