di Gioacchino Toni
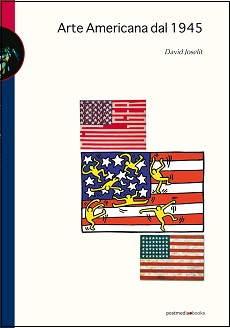 «Di fatto, dalla seconda guerra mondiale in poi la storia dell’arte americana può essere descritta come una successione di strategie volte ad ampliare [la] sfera pubblica commercializzata, sia moltiplicando i tipi di manifestazioni visive realizzabili al suo interno che diversificando i soggetti che sono autorizzati a realizzarle» David Joselit
«Di fatto, dalla seconda guerra mondiale in poi la storia dell’arte americana può essere descritta come una successione di strategie volte ad ampliare [la] sfera pubblica commercializzata, sia moltiplicando i tipi di manifestazioni visive realizzabili al suo interno che diversificando i soggetti che sono autorizzati a realizzarle» David Joselit
Negli anni Quaranta del Novecento gli approcci artistici di ordine concettuale sembrano rivelarsi inadatti ad un momento storico segnato non solo dagli orrori della guerra, dal ricorso all’atomica e dai campi di sterminio, ma anche da una percezione del futuro nel segno dell’incertezza in un panorama avviatosi al clima paralizzante e da caccia alle streghe della guerra fredda.
«Noi percepivamo la crisi morale di un mondo che era un campo di battaglia, di un mondo che era devastato dalla tremenda distruzione di una guerra mondiale incombente […] Era impossibile disegnare come prima – fiori, nudi sdraiati, suonatori di violoncello». Così l’artista nordamericano Barnett Newman ha sintetizzato il clima dell’immediato dopoguerra e non solo negli Stati Uniti.
All’interno di tale contesto è innegabile che vi siano state alcune poetiche artistiche che, più di altre, hanno saputo cogliere ed esprimere la sensazione diffusa di angoscia e lo hanno fatto concentrandosi sul rapporto tra individuo, spazio e materia, dunque riproponendo, in ultima analisi, la questione dell’identità dell’essere umano, ora vissuta però come problema di relazione con il cosmo nel suo essere spazio e materia. Si sta parlando di quella stagione “Informale”, per ricorrere al termine con cui viene solitamente indicata in ambito europeo, caratterizzante la scena internazionale a partire dagli anni Quaranta pur nelle inevitabile e profonde differenze locali.
Si tratta di una stagione che abbraccia l’arco temporale di un ventennio a cavallo della metà del Novecento che prende il via con le esperienze di artisti come Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Arshile Gorky, Jackson Pollock, Alberto Burri, Lucio Fontana e che ha il suo corrispettivo nipponico nel Gruppo Gutai composto da Jiro Yoshihara, Sadamasa Motonaga, Kazuo Shiraga, Shozo Shimamoto e Atsuko Tanaka. Una stagione che giunge, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, a divenire un vero e proprio fenomeno di moda perdendo parte del potenziale espresso ai suoi albori.
È a partire dalle peculiarità specifiche dell’Espressionismo astratto nordamericano che lo studioso David Joselit nel suo American Art Since 1945, uscito in lingua inglese la prima volta nel 2003, propone un’analisi della scena artistica statunitense che dal primo dopoguerra giunge fino ai giorni nostri. Nel volume, recentemente tradotto in italiano da Maria Antonella Bergamin – David Joselit, Arte Americana dal 1945 (Postmedia books 2021) –, lo studioso, non accontentandosi delle letture più convenzionali del contesto artistico nordamericano, tendenti forse eccessivamente ad insistere sul ruolo esercitato dalle avanguardie storiche europee sulle neoavanguardie americane, ha inteso concentrarsi piuttosto sulle trasformazioni sociali ed estetiche che hanno caratterizzato il dopoguerra statunitense, trasformazioni che si paleseranno compiutamente nel corso degli anni Sessanta.
Tre sono le dinamiche interrelate su cui Joselit si è concentra: «il consolidamento di una sfera pubblica radicata nel consumo e nei mass media come la televisione e Internet; la manifestazione dell’identità personale come piattaforma prioritaria per la formulazione di rivendicazioni politiche negli Stati Uniti; e il passaggio degli oggetti artistici dai media tradizionali come la pittura e la scultura ai media “informativi” come il testo, la fotografia, gli oggetti ready-made e il video» (p. 9).
 Secondo lo studioso l’arte nordamericana del dopoguerra dovrebbe essere vista come derivazione e rappresentazione delle nuove esperienze del pubblico prodotte dalla presenza pervasiva dei mass media visivi, dal mezzo televisivo degli anni Quaranta a Internet degli anni Novanta. «Date queste condizioni, l’identità – una questione presumibilmente privata – ha acquisito la forza politica in passato attribuita a identificazioni collettive come la classe e la nazione. Nell’era del dopoguerra, le esperienze del “pubblico” si verificano sempre più spesso in solitudine o in piccoli gruppi di fronte a uno schermo televisivo o a un computer» (p. 14).
Secondo lo studioso l’arte nordamericana del dopoguerra dovrebbe essere vista come derivazione e rappresentazione delle nuove esperienze del pubblico prodotte dalla presenza pervasiva dei mass media visivi, dal mezzo televisivo degli anni Quaranta a Internet degli anni Novanta. «Date queste condizioni, l’identità – una questione presumibilmente privata – ha acquisito la forza politica in passato attribuita a identificazioni collettive come la classe e la nazione. Nell’era del dopoguerra, le esperienze del “pubblico” si verificano sempre più spesso in solitudine o in piccoli gruppi di fronte a uno schermo televisivo o a un computer» (p. 14).
Sarebbe proprio nella confluenza tra le nuove sfere mediatiche pubbliche e l’esperienza politicizzata dell’identità sviluppatasi in concomitanza con queste, che prende piede l’arte nordamericana del dopoguerra. Se tale combinazione è solitamente associata ai movimenti di liberazione degli anni Sessanta – riassumibile nello slogan “il personale è politico” – , secondo Joselit, l’associazione tra il personale e il pubblico (se non il politico) è però già ravvisabile nell’astrazione apparentemente apolitica dell’esperienza del cosiddetto Espressionismo astratto della New York School di artisti come Jackson Pollock, Willem de Kooning, Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still e Adolph Gottlieb.
Se l’individualismo può suggerire un’astensione dalla vita pubblica, l’individualità aveva un significato politico potente nell’epoca dell’immediato dopoguerra. Per molti americani durante la Guerra Fredda, l’individualismo – in quanto contrapposto ai modelli di governo associati al fascismo o all’Unione Sovietica stalinista – costituiva una reazione morale e politica adeguata alle nuove realtà globali […] lo sviluppo di uno “stile di vita” privato poteva assumere il significato di un atto pubblico. Se l’individualismo era adottato come una manifestazione politica dei valori americani, esso promuoveva anche lo sviluppo della società dei consumi evidenziando le capacità di valutazione e di analisi dei consumatori a fronte alla sbalorditiva varietà dell’offerta di prodotti nell’opulenta America del dopoguerra (pp. 14-15).
Nell’esperienza della New York School, sostiene lo studioso, il tipo di individualità privilegiato aveva a che fare con l’emozione eroica e la sofferenza di uomini eterosessuali bianchi, considerati all’epoca come rappresentanti “naturali” dell’intera umanità. Già in tale esperienza negli Stati Uniti la questione dell’identità viene posta come categoria pubblica, dunque politica.
Se da un lato le poetiche dell’Espressionismo astratto fanno coincidere la specificità di maschi eterosessuali bianchi con l’essere umano nella sua totalità, tale nozione astratta di comunità consolida e rappresenta una sfera pubblica ben precisa: quella degli Stati Uniti del dopoguerra e, nonostante «l’enfasi apparentemente apolitica degli artisti sull’autonomia, l’individualità e la trascendenza, la loro arte finì per essere associata a valori specificatamente americani» (p. 27).
Con l’esperienza Pop americana le azioni individuali e le ideologie collettive risultano filtrate dal mondo dei mass media. Gli artisti che si rifanno a tale poetica se da una parte tracciano «una mappa della commercializzazione dello spazio pubblico» (p. 61), dall’altra dimostrano come le merci finiscono per assumere «un ruolo di icone pubbliche cariche di valori ideologici al di là delle loro funzioni manifeste» (p. 61). Per questi artisti lo spazio pubblico degli anni Sessanta diviene una funzione della rappresentazione al pari di uno spazio fisico. Nelle opere Pop «la superficie pittorica delle merci – la loro “autorappresentazione” nella pubblicità e nel packaging – viene astratta e riformulata. Le icone che ne derivano tendono a oscurare la funzione utile dell’oggetto commerciale a favore delle sue associazioni ideologiche» (p. 89).
Se il Pop tende a concentrarsi sul “nuovo” e “patinato”, l’Assemblage ricorre invece al «versante più povero della società dei consumi» (p. 91). Si tratta di operazioni bene diverse, sottolinea lo studioso: nel primo caso un oggetto di consumo nuovo subisce un’operazione di traslazione in un diverso contesto (sull’onda del ready-made duchampiano), nel secondo si scorge invece un’operazione di dissenso sociale nel suo associare sovente oggetti di scarto ad esistenze anch’esse di scarto.
Soffermandosi poi sull’esperienza Minimal, lo studioso evidenzia come spesso si sia visto in essa una ridefinizione dell’arte come «relazione tra pubblico, spazi e cose più che come oggetto specifico e autosufficiente» (p. 103). Se tale ambito metteva in relazione «incontri scultorei» tra oggetti e spettatori al fine di evidenziare i meccanismi visivi e psicologici della percezione, nel corso degli anni Sessanta altre poetiche, come Fluxus, hanno invece sviluppato forme interattive di produzione artistica denominate “eventi”.
A metà tra performance e scultura, l’evento si fonda su un numero limitato di azioni collegate alla vita quotidiana che potevano passare quasi inosservate, differenziandosi in ciò dall’happening. Nonostante l’insistenza sul rifiuto di relazioni mercificate, indubbiamente Fluxus non manca di adottare, per quanto ironicamente, modalità desunte dal marketing aziendale in cui gli oggetti vengono riformulati come eventi e le reti di diffusione incorporate nell’opera d’arte.
Assemblage, Minimal e Fluxus, pur in modalità differenti, sostiene lo studioso, hanno esplorato «il posto occupato dalle merci nel mondo e in relazione ai singoli spettatori» (p. 114) ed è proprio attraverso la manipolazione degli oggetti commerciali che hanno inteso «comunicare attraverso il linguaggio pubblico condiviso della società dei consumi» (p. 127).
 Nel corso della sua disamina, Joselit sottolinea come l’arte nordamericana degli anni Settanta si sia mossa verso una ridefinizione dell’arte come «puro atto di comunicazione» disinteressato alle «cose materiali», che invece erano parte integrante delle poetiche precedenti. «L’avvento dell’economia dell’informazione basata su tecnologie informatiche allora emergenti, combinato con la diffusione ormai generalizzata dei media elettronici come la televisione, trasformava l’informazione in una sostanza tanto “reale” e soggetta allo scambio dei mercati finanziari quanto qualunque altra merce solida» (p. 117).
Nel corso della sua disamina, Joselit sottolinea come l’arte nordamericana degli anni Settanta si sia mossa verso una ridefinizione dell’arte come «puro atto di comunicazione» disinteressato alle «cose materiali», che invece erano parte integrante delle poetiche precedenti. «L’avvento dell’economia dell’informazione basata su tecnologie informatiche allora emergenti, combinato con la diffusione ormai generalizzata dei media elettronici come la televisione, trasformava l’informazione in una sostanza tanto “reale” e soggetta allo scambio dei mercati finanziari quanto qualunque altra merce solida» (p. 117).
La trasformazione dell’opera d’arte in flussi di informazione presupponeva una trasformazione in coloro che operavano in ambito artistico. Se tra i primi artisti concettuali, in prevalenza maschi bianchi, è ancora individuabile una retorica universalizzante, nel corso degli anni Settanta hanno teso ad evidenziare «le esperienze e condizioni di identità particolari basate su genere, razza e sessualità» (p. 145.)
Circa l’arte concettuale, in disaccordo con chi ha individuato la dematerializzazione dell’oggetto artistico, lo studioso vi coglie invece un nuovo tipo di materialità, consono a documentare le «proprietà intellettuali e fisiche dell’artista». (p. 145)
La nozione di arte come sequenza di proposte filosofiche ha […] una doppia implicazione. Mentre, da un lato, suggerisce un’universalità scientifica o logica nella quale la voce individuale dell’artista viene eclissata da autorità sociali senza volto […], dall’altro canto essa riporta nuovamente lo spettatore alla persona intellettuale e fisica dell’artista. Gran parte dell’arte concettuale può essere, quindi, intesa come un tentativo di mappare i confini dell’individuo come entità logica, sociologica o legale […] La cosiddetta dematerializzazione dell’arte prevede […] due tipi di dislocazione. In primo luogo, le opere d’arte venivano reinventate come estensioni della proprietà intellettuale e fisica dell’artista, e in secondo luogo l’enfasi conseguente sulle proposte o sulla body art richiedevano un passaggio da pratiche tradizionali come la pittura e la scultura a nuovi media basati sull’informazione come fotografia, video e testo (pp. 150 e 155).
Se inizialmente gli artisti concettuali tendevano a vedere le loro opere e la loro stessa presenza fisica come “proprietà privata”, nel corso degli anni Sessanta e Settanta spetterà al movimento delle donne evidenziare quanto il privilegio di “possedere” il proprio corpo dipenda dal genere. Dal punto di vista razziale si deve soprattutto alla comunità afroamericana la denuncia delle pretese egemoniche e totalizzanti dell’America anglosassone in ambito valoriale ed estetico.
Se nel corso degli anni Sessanta e Settanta la critica nei confronti dell’estetica tradizionale è spesso portata attraverso il testo e la fotografia, successivamente è la stessa idea di neutralità di tali mezzi informativi ad essere messa in discussione. Anziché porsi nell’ordine di idee di evitare il mercato, diversi artisti degli anni Ottanta e Novanta preferiscono considerarlo «come una sfera pubblica e i linguaggi commerciali come modalità del discorso pubblico» (p. 188). Le questioni del potere di “identificare” o di “identificarsi” sono state centrali negli ultimi decenni del vecchio millennio.
Rivendicando una piattaforma politica sulla base d uno “stile di vita” particolare, gli artisti, come gli attivisti, finiscono per maneggiare gli stessi stereotipi che vorrebbero disinnescare. Non è un caso che gran parte dell’arte più rilevante degli anni Ottanta e Novanta riconosca questo dilemma soffermandosi meno sulle categorie prestabilite dell’identità e più sulle intersezioni e le trasgressioni dei confini tra le stesse. Queste pratiche sono state etichettate di volta in volta come post-etniche, cyborg o post-umane dai teorici di punta degli anni Novanta. In modi diversi, ciascuna di queste categorie critiche auspica modalità di individualità basate sull’azione volontaria o sull’associazione più che su tratti biologici essenziali o su stereotipi culturali (p. 205).
L’emergere sin dal primo dopoguerra americano di una particolare forma di sfera pubblica massmediatizzata e consumista «ha evocato una politica dell’identità nella quale gli individui sono rappresentati attraverso stili di vita e attributi stereotipati intensamente mercificati» (p. 215). Diversi artisti degli anni Novanta intrecciando sociale e biologico hanno tratteggiato un nuovo mondo post-umano ove il corpo è concepito come sfera pubblica. A David Joselit, in chiusura della sua trattazione, non resta che auspicare che l’allentamento delle rigide differenze tra appartenenze di genere, sessuali ed etniche possa «offrire un’alternativa a un mondo ormai totalmente soffocato dalla commercializzazione di ogni gesto, pensiero ed emozione» (p. 215).



