di Sandro Moiso
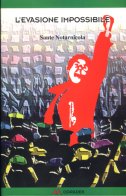 Qui le puntate precedenti.
Qui le puntate precedenti.
A cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta la Barriera era ricca di sale cinematografiche
A cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta la Barriera era ricca di sale cinematografiche.
Sociale, Palermo, Major, Adua, Lanteri, Zenith, solo per ricordarne alcune.
Oggi non ci sono più, ma nella mia infanzia furono luoghi dove sogni a buon mercato aiutarono intere generazioni a crescere e ad andare avanti.
L’avventura ci educò più della scuola e prima del lavoro.
Anche a scuola, nelle grandi occasioni, potevamo assistere in palestra a proiezioni cinematografiche.
Maestri, maestre e direttore della scuola elementare Gabelli sembravano allora andar matti per Marcellino pane e vino e per i filmati dell’USIS, l’istituto culturale rivolto a propagandare aspetti della vita sociale e della storia degli Stati Uniti nei paesi alleati.
Chiesa e America, il nostro pane quotidiano.
Il primo veniva proiettato ogni anno prima delle vacanze pasquali e, forse, anche noi allievi fummo calcolati tra quegli undici milioni di italiani che avrebbero visto il film.
Cattolico, edificante, piagnone e noioso fino alla morte, fu il film franchista che ebbe il maggior successo al mondo. Ma quel crocifisso parlante non contribuì a raccogliere molte vocazioni nella mia scuola e quell’idea di Gesù che faceva morire il piccolo orfano protagonista, per portarlo con sé e fargli conoscere la madre morta, non ci entusiasmò mai.
Un po’ di più ci entusiasmavano i filmati messi a disposizione dall’istituto di propaganda culturale statunitense.
Gli indiani erano veramente cattivi e feroci in quei film e spesso facevano strage di coloni e fortini di frontiera, ma quelle carneficine e quelle battaglie non erano niente male e si lasciavano guardare con meno noia.
Il politically correct sarebbe arrivato solo dopo qualche decennio, ma quei sanguinari filmati educativi non impedirono ad alcuni di noi di diventare, anni dopo, indiani metropolitani e di fumare un calumet della pace, colmo di erbe proibite, con un giovane redattore di un quotidiano torinese destinato poi ad una brillante carriera.
Forse anche lui aveva visto quei filmati e trovandosi nel nostro accampamento per un’intervista preferì adeguarsi alle tradizioni locali piuttosto che farsi scotennare.
Il palazzo universitario di via Sant’Ottavio, nel cui atrio si trovava il nostro accampamento, rischiò anche di diventare il nostro Sand Creek.
Nei panni delle camicie azzurre furono carabinieri e servizio d’ordine del grande partito comunista.
Ma Soldato blu e Piccolo grande uomo erano già diventati parte del nostro patrimonio e non ci facemmo cogliere impreparati. Nessuno quel giorno portò a casa i nostri scalpi.
Fallì così il tentativo di vendicare la storica sconfitta del Settimo cavalleria sindacale tra le Black Hills dell’Università di Roma.
Riuscirono a farci sloggiare dal nostro campo, ma quella era la naturale conseguenza della nostra scelta nomade, del nostro rifiuto di farci rinchiudere in una riserva o da una sigla.
Stanchi di sedi, burocrati e dirigenti a caccia di successo avremmo lasciato per sempre ad altri gli spazi politici istituzionali o definiti una volta per tutte.
Quelli della Barriera lo chiamavano Piero
Quelli della Barriera lo chiamavano Piero.
Più che con i western doveva aver nutrito i suoi sogni giovanili con i film di Cagney e Bogart.
Poi la disillusione politica e la memoria recente della lotta armata partigiana fecero il resto.
Sui muri di corso Giulio Cesare, la grande arteria della Barriera in direzione di Milano, c’erano ancora i segni dei colpi sparati dalle colonne tedesche in ritirata.
Quello non era stato un film, come ci raccontava un maestro elementare.
Il più lunatico e simpatico, un burbero maestro di musica che, in quell’occasione, aveva cercato di sventolare una bandiera dalla sua finestra, rischiando così di far demolire l’intero caseggiato a colpi di mitragliatrice pesante.
Anche Piero Cavallero doveva aver visto quei fori.
Avevo dieci anni quando iniziò l’avventura della sua congrega di fuorilegge proletari.
Era il 1963 e quello stesso anno, a Dallas, fu ucciso John Fitzgerald Kennedy.
Piansi per l’uno e mi appassionai agli audaci assalti di quella banda che non aveva ancora un nome ufficiale.
Il circo mediatico televisivo iniziava allora a porre le sue basi e a trasmettere la morte in diretta.
Nel 1962 era comparso sugli schermi La banda Casaroli di Florestano Vancini.
Una storia di malessere e rapine in banca dell’immediato dopoguerra.
Una Bologna nebbiosa faceva da sfondo all’ultimo colpo e al tragico epilogo dei componenti della banda. L’unico rimasto vivo e in libertà finiva con il tirarsi un colpo di pistola al cuore nel buio di una sala cinematografica.
Chissà se Piero, ancora tranviere in quei giorni, aveva visto quel noir padano?
Anche la sua corsa disperata contro la storia e la politica di quegli anni, così come quella dei suoi compagni Notarnicola, Rovoletto e Lopez , sarebbe finita sullo schermo per opera di Carlo Lizzani e Gian Maria Volontè, soltanto un anno dopo l’ultima rapina.
Per uno di quei paradossi che nessuno può spiegare proprio nel momento della ripresa su vasta scala delle lotte selvagge: il maggio 1968.
Più che le audaci rapine, iniziate con un assalto ad una sede del San Paolo a Torino e finite con quello ad una filiale del banco di Napoli a Milano, fu la cronaca in diretta della fuga e della sparatoria finale a destare l’attenzione del neo-pubblico radio-televisivo.
Ero seduto nel tinello di mia zia quando, otto giorni dopo gli spari e il sangue, fu dato l’annuncio della cattura di Piero e Sante presso il casello ferroviario abbandonato di Villabella.
Ma a colpire ancora di più l’immaginario collettivo di chi già non si rassegnava all’esistente furono le dichiarazioni fatte al processo che li condannò a pesantissime pene.
Il pugno alzato nel momento della condanna all’ergastolo e il canto anarchico all’uscita dall’aula giudiziaria, tra lo scandalo di magistrati e pubblico benpensante.
Era sempre il 1968, ma di luglio.
Si era gettato in quell’avventura a occhi aperti, lucidamente.
La sconfitta era stata fin dall’inizio l’unico traguardo possibile.
Nel 1972 il libro di Notarnicola, che narrava quelle vicende, fu per noialtri un’autentica bibbia.
Ma ad impersonarlo meglio fu William Holden, nel film Il Mucchio Selvaggio quando, in un altro contesto, senza rimpianti e con tanta rabbia, urla No! e dà inizio alla terrificante sparatoria finale.
Rivendicò sempre a sé stesso la responsabilità di ciò che era avvenuto.
A Milano nel corso dell’ultima, folle corsa erano rimasti a terra tre morti e più di venti feriti.
Quanti causati dai banditi in fuga e quanti dagli agenti delle volanti inseguitrici non si seppe mai.
Con il suo ghigno amaro, con il suo volto di sconfitto cosciente del proprio destino, dichiarò ad un mondo addormentato che pur di rimanere liberi si può sparare e si può uccidere.
Diciassette rapine e un bottino che procurò ai componenti della banda uno stipendio medio di duecentomila lire al mese.
Poco, maledettamente poco per le conseguenze poi pagate.
Ma all’epoca lo stipendio di un operaio si aggirava sulle cinquantamila lire mensili.
Poche lire sudate nella paura dei capi, della disoccupazione, di non farcela ad arrivare a fine mese.
Piero no, non volle più avere quel tipo di paura.
Nei quattro anni e mezzo vissuti da fuorilegge la paura la lesse negli occhi degli altri.
Anche dopo il suo arresto, tra quei piccoli borghesi imbestialiti che avrebbero voluto linciarlo davanti alla questura di Milano.
Lo chiamarono belva e massacratore, come sempre si fa con gli sconfitti.
Ben poca cosa, disse, erano state le vittime dell’ultima sparatoria rispetto a ciò che stava già avvenendo in Vietnam.
Il napalm non scuoteva le coscienze comuni, ma le rapine e il rifiuto dell’ordine basato sullo sfruttamento sì.
Ieri e ancora oggi.
La banda non raggiunse mai l’obiettivo dei trecentocinquanta milioni che si era dato, ma le banche dichiararono sempre somme superiori a quelle effettivamente prelevate dai rapinatori.
Duecento anni prima Daniel De Foe aveva già rivelato, nella sue Storie di pirati, che i veri furfanti in definitiva portano sempre le vesti del borghese.
Tocca sempre alla letteratura mostrare le verità più scomode.
Colui che sussurrava nel buio
Colui che sussurrava nel buio.
Un titolo misterioso, accompagnato da una delle enigmatiche copertine di Karel Thole, attrasse la mia attenzione tra le centinaia di romanzi che riempivano gli scaffali di un negozietto di corso Giulio Cesare.
Avvenne così il mio primo incontro con il solitario di Providence, Howard Philip Lovecraft.
Avevo quattordici anni ed ero già allora un appassionato e ostinato visitatore di bancarelle e negozi di libri usati ed erano proprio i vecchi numeri di Urania a farmi spendere le poche lire che avevo in tasca.
Quella sera lessi il primo dei tre racconti contenuti in quella breve antologia e da quel momento i rumori della vecchia casa di campagna in cui passavo l’estate non sarebbero più stati gli stessi.
Poco tempo dopo, la lettura di una più ricca antologia, comparsa nel frattempo, mi avrebbe fatto percepire in quell’autore, autentico maudit del New England, qualcosa di più dell’orrore e della paura.
Avrei scoperto che l’orrore e la paura vera non derivano da esseri più o meno mostruosi nascosti nelle tenebre e neppure soltanto dalla morte. Era la vita stessa che poteva terrorizzare.
Fin da bambino i miei sonni erano stati interrotti o rinviati dal pensiero del nero, inimmaginabile nulla rappresentato dalla morte.
Quel terrore ancora infantile era legato alla coscienza del fatto che un giorno non avrei potuto più rivedere i miei genitori, assorbiti da quell’inevitabile oscurità, da quella zona di oblio in cui tutti siamo condannati a precipitare.
Ma quello scrittore ateo, materialista, razzista, sessuofobo, morto di cancro all’intestino a quarantasette anni, mi rivelò un’altra ben più atroce verità.
La vita stessa, l’esistenza quotidiana potevano nascondere un nulla ben più spaventoso e orripilante. Forze oscure, vecchie, insensibili ai destini individuali e collettivi della specie umana dominano il nostro destino e lo determinano in maniera assolutamente casuale.
A differenza di altri scrittori del genere fantastico o gotico, Lovecraft non crede in una lotta tra il male e il bene, non propone tormenti cui la morte può porre, comunque, termine.
Non c’è nella sua scrittura possibilità di salvezza, lieto fine o anche solo di una dolorosa trasfigurazione o palingenesi.
C’è solo l’assoluta certezza della vanità ed inutilità della vita e del cosmo stesso.
Dopo averlo letto non ho più potuto credere al pessimismo di Leopardi o a ciò che una critica imbelle e una scuola di impianto cattolico spacciava per tale.
Il solitario di Recanati era un sano materialista, con sprazzi di ottimismo nei confronti dell’umanità e del cosmo stesso.
Un coltissimo letterato con una formazione classica e illuministica, venata di romanticismo.
Lovecraft è figlio del Novecento e delle forze demoniache che lo hanno fondato.
Ne è lo spietato e disilluso cantore.
I suoi dei ciechi e idioti che ballano nudi al centro dell’universo al suono di una blasfema cacofonia di flauti e tamburi, che strisciano o sorgono da abissi innominabili per condurre nella propria perdizione gli esseri umani che li evocano, possono davvero rappresentare una delle più terribili metafore delle forze che hanno agitato il secolo appena finito.
Attraverso la sua opera, me ne rendo conto solo ora, conobbi il nichilismo.
L’uomo muore, il cosmo muore e la morte stessa finirà con il morire.
E quegli dei vivono da morti e nutrendosi di morte.
Non vi può essere condanna più spietata della condizione umana e della vita stessa.
E dell’inutile desiderio di conoscenza che anima la scienza.
Il suo razzismo e le sue simpatie hitleriane lo hanno reso inviso a tanta parte della sinistra, ma la destra ha dovuto accontentarsi di relegarlo tra i maestri del fantastico.
Troppo esplosivo, troppo distruttivo per essere maneggiato con vantaggio da chi difende l’esistente, il solitario di Providence condivide con Céline uno spazio unico nella letteratura del ventesimo secolo.
Ma anche quella rabbia e quel rifiuto di un mondo che cela realtà più subdole di quelle che si degna di mostrare hanno animato la nostra rabbia e il nostro rifiuto.
Ci hanno fatto odiare in egual misura la Chiesa, il capitalismo, il fascismo, lo stalinismo, il positivismo scientista e, più di tutto, la menzogna liberale e democratica.
Con buona pace degli intellettuali organici e da salotto.
Il demone che ci divorava era anche quello che ci faceva vivere
Il demone che ci divorava era anche quello che ci faceva vivere.
Non avremmo mai potuto liberarci senza liberarlo.
Occorre comprendere ciò per capire la furia di quegli anni, che fu comunque, sempre, una furia di vita. Anche nelle sue manifestazioni più disperate.
Arrivare a liberare il demone senza esserne divorati, ecco il punto.
La liberazione è un processo complesso.
Non ci si può liberare in parte.
Può essere collettivo, ma anche individuale e non è sempre detto che il primo riesca e il secondo no. Entrambi possono risultare catastrofici nel loro procedere.
E tutti e due possono riservare svolte impreviste, gradevoli e sgradevoli.
Ci nutrimmo di Hubert Selby, William Burroughs e Lou Reed, ma non furono loro a dannarci.
Li incontrammo mentre eravamo già sulla strada della dannazione e della liberazione.
I loro demoni erano i nostri, anche se talvolta assumevano volti differenti.
Ma i demoni sono sempre quelli.
In ognuno di noi e in tutte le epoche.
Sono i demoni della rabbia, dell’offesa e del desiderio che non vuole limiti.
Sono quelli della sofferenza, della violenza, della follia e del riso sfrenato.
Si chiamano autodistruzione, distruzione e utopia.
Si manifestano come odio, intemperanza e amore.
Sono demoni che vogliono tutto, oppure il nulla.
Il benpensante, che nasconde i propri demoni a se stesso e agli altri, non può capire ciò.
Non vuole neppure sentirlo dire.
Chiede raziocinio, impegno e controllo.
Ma non esistono e non possono esistere organigrammi dei sentimenti, istogrammi della rabbia e statistiche o codici del furore.
I martiri con la cintura esplosiva, coloro che hanno impugnato le armi nel momento del riflusso dei movimenti e gli altri che si sono iniettati la morte attraverso le vene, tutti hanno inseguito il loro demone. E la liberazione.
La liberazione dal demone è anche la liberazione del demone.
Nasconderlo non serve a nulla.
I demoni sono fatti di fiele e di miele.
Per aver diritto al secondo bisogna sempre aver bevuto un calice del primo.
Ancora oggi i miei demoni hanno bisogno di nemici, non possono vivere nella pace.
E io non riesco a vivere senza i miei demoni e devo dar loro la luce.
Oppure lasciare che mi strazino nel buio.
Train kept a rollin’
Train kept a rollin’…
Il treno aveva cominciato a correre.
Quando Johnny Burnette aveva inciso quel brano di travolgente rock’n’roll certo non avrebbe mai immaginato di vederlo un giorno eseguito da un quartetto di stralunati capelloni di Detroit che, in una fotografia, avrebbero impugnato fucili a pompa, Garand, baionette e chitarre elettriche.
Frank Bach, Bob Rasmussen, Gary Rasmussen e Scott Bailey: the Up.
La loro furia seguiva il ritmo dei tempi, incarnò il suono della breve estate delle Pantere Bianche.
Musicalmente valevano un po’ più di nulla, but those where the times.
Il treno dei giovani bianchi anche in America aveva cominciato a correre sulle rotaie della violenza contro lo stato.
Tom, l’amico di New York che avevo conosciuto poco prima di partire per gli States, era uno di loro. Aveva lasciato gli studi universitari per entrare in fabbrica, alla Ford.
Si era trasferito ad Oakland, sulla baia di San Francisco e patria delle Pantere Nere.
Ci raccontava storie di operai distrutti dal lavoro e dall’alcol, mentre i più giovani cercavano di superare il turno stordendosi di marijuana.
Oggi si scopre che la cocaina fa girare le catene di montaggio e le piccole e medie imprese.
L’America di quei giorni, ancora una volta ci parlava già del nostro futuro, ma qui pochi lo capirono. Gli altri erano convinti di essere diversi, immuni dal decadimento americano.
Già, europei e di sinistra…c’era davvero da morire di noia.
Avevo già buttato il mio cuore e la mia mente oltre l’Atlantico, non mi rimaneva che andarci col resto del corpo.
Lo skyline di New York era allora dominato dalla Torri Gemelle
Lo skyline di New York era allora dominato dalla Torri Gemelle.
Oggi non ci sono più, ma il tragitto in autobus dall’aeroporto Kennedy a Manhattan sembrò durare un’eternità. Gli occhi miei e di Ettore volevano registrare ogni fotogramma di quel film immaginario che la realtà americana ci proponeva.
Già, gli occhi…il mio compagno di viaggio era affetto da cheratocono, una rara forma di deformazione della cornea che porta al progressivo sfaldarsi della stessa e delle immagini.
Forse fu per questo che scambiò fin dal primo autobus il vano del cesso per un frigorifero o per un bar. Rimase deluso quando gli dissi che lì si andava per pisciare.
Saremmo poi stati ospiti dei genitori di Tom per qualche giorno, ma la prima notte la passammo in un hotel di infima categoria vicino a Columbus Square prenotato tramite un’agenzia italiana.
Faceva schifo e gli scarafaggi la facevan da padroni, ma quei neon che illuminavano la stanza a giorno, il traffico nelle vie, i negozi aperti di notte ci facevano sentire come i protagonisti di Mean Street.
In realtà, avrei scoperto ben presto che solo Ettore poteva essere scambiato per un italo-americano di Scorsese. Io fui sempre per tutti un tedesco: mi dicevano che anche la mia pronuncia era da tedesco.
Ettore rise di ciò fino al giorno in cui un camionista, che ci aveva raccolto in autostop e che aveva appena ribadito il concetto, non frenò improvvisamente, inondandolo di caffè bollente.
Io ne risi con cadenza germanica, lui bestemmiò in italiano.
Il padre di Tom era un ebreo di origine ungherese, la madre scriveva gialli: ci trattarono come dei figli. Più volte in quel viaggio ebbi modo di apprezzare l’ospitalità degli americani.
Per esempio a Green River, nel Wyoming e in prossimità del confine con lo Utah, dove una coppia di pensionati ci offrì bistecche e altro presso il proprio barbecue e, alla fine, l’uomo anche una birra e una partita a biliardo in un bar della cittadina.
Furono davvero ospitali. Anche se credo che, per quanto riguarda la seconda parte della serata, io ed Ettore fummo un’ottima scusa per il marito per liberarsi dall’assillo della moglie.
Anche le zanzare erano assillanti a Green River, ma l’omonima canzone dei Creedence non ce lo aveva detto.
Passammo la serata a schiaffeggiarci collo, braccia e gambe per cacciarle.
Oppure a Nashville, dove arrivammo sull’onda del country rock e del film di Altman.
In un campeggio da quarantamila persone, due famiglie americane di musicisti dilettanti ci offersero un memorabile concerto di bluegrass.
“Where’re ya comin’ from? — Italy?!- You’re welcome…” e via con banjo, chitarre, violini, armonica e tanta, tanta birra.
Ma l’ospitalità più gradita fu sempre quella accompagnata dall’offerta di marijuana, anche se per quella dovemmo arrivare fin sulla costa del Pacifico.
A New York, in quei primi giorni, mancavano ancora migliaia di chilometri per arrivare alla West Coast. E decine e decine di ore di Greyhound.
La tappa successiva sarebbe stata Boston.
Non ero ancora arrivato e già avrei voluto fermarmi lì per tutta la vita
Non ero ancora arrivato e già avrei voluto fermarmi lì per tutta la vita.
Fu Ettore a portarmi via da Boston, reclamando il viaggio che gli avevo promesso attraverso gli States e non solo nel Massachussetts.
La colpa fu di una ragazza, Farland. Figlia fuggitiva di un pastore protestante o di chissà quale diavolo di chiesa, si era fermata per darci informazioni, vedendoci in difficoltà mentre cercavamo un indirizzo di Cambridge.
Mi innamorai all’istante dei suoi capelli biondi, del suo sguardo svagato mentre pedalava, con le cuffiette per ascoltare la musica, sulla sua bicicletta da corsa.
Era una free climber e lavorava in un negozio di alpinismo.
Ci invitò ad un concerto per quella sera e così non dormii mai nella casa in cui dormì Ettore in quei giorni. Il retro del negozio, in cui lavorava e in cui dormiva Farland, mi sembrò da subito più accogliente.
Da noi l’arrampicata libera, detta allora “californiana” si era da poco diffusa.
Proprio a partire da Torino, con gli articoli di Gian Piero Motti su “La rivista della montagna” e l’idea di un nuovo mattino per l’alpinismo.
Il ’68 aveva raggiunto anche gli ambienti austeri del Club Alpino Italiano, portando una ventata di sogni e di libertà.
Si narrava di salite lisergiche lungo le pareti di El Capitan e Half Dome, nella Yosemite Valley.
Si parlava di salite in libera e discese rapide con i discensori per poi risalire il giorno successivo con le maniglie Jumar fino al punto raggiunto il giorno prima per riprendere in libera i novecento metri del Capitan e di arrampicatori che si fermavano a pensare osservando le lucertole delle rocce.
LSD, scarpette e visioni: di questo si nutrì l’arrampicata libera delle origini.
Un noto alpinista italiano aveva da poco aperto una nuova via andina chiodandola dall’inizio alla fine con trapano e chiodi ad espansione: nessun giovane alpinista per diversi anni lo avrebbe più degnato di attenzione.
La velocità non contava più e il tempo si dilatava materialmente attraverso i muscoli, il sudore e la mente dei climbers.
Oggi il circo dello sport ha riportato tutto sotto l’egida del cronometro e della competizione e il tempo del capitale ha ripreso a scorrere normalmente.
Qualche vecchio climber è morto e qualcuno si è suicidato, ma quel sogno ci fece guardare alle montagne con un altro occhio e, anche se solo per un istante, grigie mura di granito divennero sinonimo di libertà.
Farland mi parlava di arrampicate fatte in totale nudità sulle rocce della Baja California, mentre i cavalli selvaggi galoppavano nelle valli sottostanti.
Aprì davanti ai miei occhi e per i miei sensi uno scrigno di meraviglie e di sensualità.
Dal baule dei suoi essenziali averi trasse una giacca di lana che mi ha accompagnato fino a qualche anno fa. Poi Ettore mi costrinse a ripartire.
(10-CONTINUA)



