di Gioacchino Toni
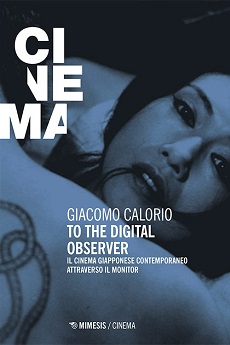 Giacomo Calorio, To the Digital Observer. Il cinema giapponese contemporaneo attraverso il monitor, Mimesis, Milano-Udine, 2020, pp. 132, € 12,00
Giacomo Calorio, To the Digital Observer. Il cinema giapponese contemporaneo attraverso il monitor, Mimesis, Milano-Udine, 2020, pp. 132, € 12,00
Sul finire degli anni Settanta è uscito To the Distant Observer (1979) di Noël Burch, un testo destinato a lasciare il segno tra gli appassionati di cinema giapponese, in cui lo studioso ha inteso individuare, non senza forzature, una specificità del cinema giapponese.
In un suo recente libro, Giacomo Calorio, riprende il titolo di Burch sostituendo il termine “Distant” con “Digital” per sottolineare la trasformazione avvenuta nei decenni che separano le due pubblicazioni: quella distanza a cui faceva riferimento Burch si è infatti nel frattempo assottigliata. Il diffondersi di nuove tecnologie di produzione, fruizione e telecomunicazione ha ridotto la distanza tra spettatore occidentale e cinema giapponese in termini geografici (le opere visionabili in contesti extranipponici sono decisamente aumentate), cronologici (il tempo intercorso tra l’uscita in patria e la possibilità di visiona i film nel resto del mondo è notevolmente diminuito), linguistica (la disponibilità di sottotitoli consente di affrontare le opere anche a chi non ne conosce la lingua originale), culturali ed estetici (l’interconnessione globale ha contribuito a una maggior conoscenza reciproca).
Dopo aver dedicato al cinema nipponico volumi come Horror dal Giappone e dal resto dell’Asia (Mondo Ignoto, 2005), Mondi che cadono. Il cinema di Kurosawa Kiyoshi (Il Castoro, 2007) e Toshirō Mifune (L’Epos, 2011), Giacomo Calorio, nel suo ultimo lavoro, To the Digital Observer. Il cinema giapponese contemporaneo attraverso il monitor (Mimesis, 2020), osserva come la “lente digitale” contemporanea con cui si affronta la cinematografia giapponese sia decisamente diversa dalla “lente analogica” a cui era costretto Burch; si pensi anche solo all’incredibile differenza in termini di opere visionabili. In entrambi i casi si tratta, inevitabilmente, di lenti deformanti, ma tale differenza comporta alcuni interrogativi su cui ragiona Calorio. Si può parlare di una specificità del cinema giapponese in epoca digitale rispetto al periodo analogico? Esiste una specificità del cinema giapponese digitale rispetto ad altre cinematografia digitali?
Il cinema giapponese arriva in Occidente nei primi anni Cinquanta. Se i cinefili lo scoprono grazie ai successi ottenuti da Rashōmon (1950) di Akira Kurosawa in Europa (Leone d’Oro al Festival di Venezia del 1951) e negli Stati Uniti (Oscar per il miglior film straniero sempre nel 1951), il grande pubblico lo conosce invece attraverso una serie di film di mostri (kaijū eiga) con effetti speciali (tokusatsu) inaugurata da Gojira (Godzilla, 1954) di Honda Ishirō e diffusi nelle sale, soprattutto americane, a partire da metà anni Cinquanta.
Quest’ultimo genere di film offriva al pubblico occidentale un’immagine contemporanea vicina ai traumi della guerra, della catastrofe atomica e, successivamente, dell’ascesa economica nipponica. Si trattava, sostiene Calorio, di un’immagine che «per i suoi aspetti camp e al contempo infantili, si presentava davvero come un precursore preistorico di quell’immagine di Giappone folle, esagerato, trash, weird ma per certi versi anche kawaii che decenni dopo avrebbe visto crescere le schiere dei suoi appassionati.» (p. 97)
Nonostante le modalità con cui gli occidentali hanno guardato al cinema nipponico siano mutate nel corso dei decenni, in tutti i casi si è trattato di uno sguardo deformato da luoghi comuni e incomprensioni. Secondo Calorio è possibile individuare un paio di grandi momenti che hanno inciso profondamente sull’immaginario cono cui l’Occidente ha guardato a tale cinematografia (visionata in una sua estrema parzialità) e al paese che l’ha prodotta.
Il primo momento può essere ricondotto al successo festivaliero ottenuto negli anni Cinquanta e Sessanta da cineasti come Kinugasa Teinosuke, Inagaki Hiroshi, Ichikawa Kon, Kobayashi Masaki, Akira Kurosawa e Mizoguchi Kenji. In particolare gli ultimi due sono stati visti dagli occhi occidentali, a seconda dei casi, come esempi di “giapponesità” o di “occidentalità”. Ovviamente su tali letture ha influito, e non poco, la scelta delle pellicole operata dai festival e dalle stesse case produttrici. In generale si può però dire che da tali opere è derivata un’idea di cinema nipponico votato alla tradizione:
un immaginario costituito da samurai virili, geisha pudiche (o in alternativa, fatalmente sensuali), profonda spiritualità, lealtà feudale, suicidi rituali, sete, lacche, spade, kimono, ventagli, paraventi, bambù, fiori di ciliegio, viste del monte Fuji, maschere nō e recitazione in stile kabuki; un’immagine di Giappone avulsa dalla realtà del tempo (p. 93).
Nel corso degli anni Settanta l’interesse del pubblico internazionale si è lentamente allargato «ai cosiddetti gendai-geki (film d’ambientazione contemporanea), mantenendo tuttavia intatta l’alterità dell’oggetto di studio attraverso concetti distanzianti come quelli di “carattere nazionale” e “mentalità giapponese”.» (p. 93)
Il secondo momento, sviluppatosi a partire dagli anni Settanta – influenzato dagli studi di Donald Richie, Noël Burch e David Bordwell –, propone una nuova immagine di cinema giapponese incentrata sulla produzione autoriale derivata dalla riscoperta del cinema di Ozu Yasujirō, attorno alla cui figura si sono costruiti non pochi luoghi comuni sulla cinematografia nipponica, tanto che, nel corso del tempo, in lui si è voluto vedere a volte un esempio di tradizione giapponese applicata al cinema e altre un autore con aspetti di modernità e universalità.
Scemato nel corso degli anni Ottanta l’interesse per la cinematografia giapponese in Occidente – se si escludono i grandi nomi come Akira Kurosawa, Nagisa Ōshima e Shōhei Imamura – questa ha conosciuto nuova fortuna attorno alla metà del decennio successivo grazie soprattutto a Kitano Takeshi.
Anche nella produzione di Kitano a cavallo tra i due millenni si ritrova spesso, in versione aggiornata, il Giappone da cartolina […], e nei discorsi sui suoi film non mancano riferimenti al cinema di Ozu, più che giustificati dall’alto livello di stilizzazione formale che accomuna le opere dei due cineasti. Al contempo, tuttavia, si trova già in nuce qualcos’altro: nel suo guardare alla tradizione da una prospettiva a metà strada tra lo sfacciato ammiccamento al gusto per l’esotico, il distacco ironico e lo spirito dissacratorio, nel suo interrogarsi sull’identità giapponese nel quadro della contemporaneità e, infine, nel suo prestarsi ad accostamenti a una “giapponesità” diversa e rinnovata, come un codice estetico e iconografico che richiama, per esempio, il manga […], il cinema di Kitano ha fatto da ponte verso una generazione di cineasti e di appassionati i cui riferimenti spostano l’immaginario collettivo dal Giappone della cultura “alta” a quello della cultura “bassa”. Sarà spesso infatti attraverso nuove parole d’ordine riferite al contesto popolare e contemporaneo che verranno misurati i film di Kitano e il Giappone che essi ci mostrano. Al contempo, tuttavia, la persistenza dei consueti richiami ai luoghi comuni della tradizione si direbbe sintomatica di un certo grado di sedimentazione di immaginari sostanzialmente immutabili. (p. 98)
Se da un certo punto di vista il panorama cinematografico nipponico contemporaneo si presenta variegato come quello di molti altri paesi, dall’altro non manca però di una sua specificità temporalmente definita: la presenza di una particolare e massiccia produzione di animazione, di generi particolari – jidaigeki, pinku eiga, yakuza-cinema, J-Horror, manga-cinema, ecc. – e il ricorso a forme di narrazione transmediale e di traduzione intermediale oggettivamente differenti da quelle occidentali.
Secondo Calorio l’attuale programmazione di opere giapponesi nelle sale italiane tende a confermare una visione ancorata al passato:
un’immagine del Giappone come luogo custode di una “iper-tradizione” riscoperta dopo qualche decennio di selvaggia e alienante modernizzazione (intesa, con un certo grado di arbitrarietà, come distorsione dei valori “occidentali” mal trapiantati in “Oriente”). Questa versione contemporanea di un immaginario antico, lievemente saccarina e agnosticamente spirituale, […] si porta dietro tracce più trasparenti sia delle “icone familiari” del Giappone da immaginario ottocentesco (ri)scoperto negli anni Cinquanta, sia di quello armonioso, malinconico e minimalista associato al cinema di Ozu, andando a costituire un’etichetta di Giappone perfetta per il supermercato culturale del terzo millennio. (p. 99).
Se si prendono come punti di osservazione i grandi festival, come Cannes o Venezia, quella giapponese oggi appare come una cinematografia stantia, priva di vere e proprie nuove proposte e con i suoi interpreti più noti in Occidente in difficoltà nell’eguagliare le prove che li hanno portati alla ribalta internazionale. Le cose cambiano un po’ se si esce dai festival mainstream e si fa riferimento a eventi più settoriali; in questo caso ci si può imbattere più facilmente in opere più innovative e in qualche nuovo autore. In tutti i modi resta decisamente scarso è il numero delle opere che ottengono distribuzione nelle sale italiane, ad eccezione di qualche uscita nell’ambito dell’animazione.
Prendendo invece come punto di osservazione il Web o le piattaforme digitali (Netflix, Amazon…), sottolinea Calorio, il panorama relativo al cinema giapponese contemporaneo si amplia decisamente. Se da tale prospettiva si vede come la cinematografia nipponica non possa essere ricondotta al solo manga-cinema, non di meno, puntualizza lo studioso, può essere negata la sua importanza.
To the Digital Observer affronta il cinema giapponese contemporaneo e le modalità con cui viene fruito, ricostruendo il percorso che lo ha portato a essere quel che è e ad essere fruito così come lo si fruisce qui ed ora. Anche se, sostiene Calorio, il cinema giapponese contemporaneo non sembra avvicinarsi ai livelli qualitativi di quello indagato da Burch, non di meno vale la pena indagarne le forme e i significati al fine di comprendere quanto e come la J-Culture abbia inciso sulla cinematografia nipponica e su quella di altri paesi.
Il fenomeno J-Horror, nato come genere locale low budget, nell’acquisire una rilevanza internazionale ha contribuito notevolmente a far conoscere globalmente il cinema giapponese contemporaneo. La diffusione di tale cinematografia fuori dal paese, sottolinea Calorio, è stata facilitata dalla sedimentazione in Europa e in America di una cultura pop giapponese costruitasi soprattutto attorno ai successi delle serie animate nipponiche, dei videogiochi, dei giocattoli, delle serie televisive. A monte di tutto ciò, non vanno sottostimati i successi della serie di film di mostri (kaijū eiga) diffusi nelle sale occidentali a partire da metà anni Cinquanta.
Il J-Horror prende il via nei primi anni Novanta con produzioni esplicatamene indirizzate all’home-video e alla televisione ad opera di registi come Nakata Hideo, Kurosawa Kiyoshi e soprattutto Tsuruta Norio per la sua opera d’esordiio Hontō ni attakowai hanashi (Scary True Stories, 1991) realizzata per Japan Home Video:
il fenomeno nacque quindi nell’ambito di un mercato e di un quadro industriale e commerciale nuovo, seppure ancora in prevalenza analogico, in cui ai modelli di produzione e distribuzione classici se ne stavano affiancando altri che vedevano, da un lato, l’ingresso in campo delle emittenti televisive; dall’altro, l’avventurarsi delle stesse case di produzione, prima tra tutte la Tōei, nel mercato rivolto al videonoleggio. Questo piccolo filone extra o paracinematografico era tuttavia destinato a essere intercettato dalla convergenza di due risorse tecnologiche altrettanto giovani ma diverse e imparentate tra loro dalla medesima natura “numerica”: nella seconda metà del decennio, infatti, si sarebbe consumato anche il connubio tra l’avvento dei supporti ottici adibiti ad accogliere file video digitali, e la diffusione capillare del World Wide Web. (p. 45)
L’ascesa del genere, che finisce velocemente per contaminare le altre cinematografie asiatiche e per raggiungere una diffusione globale, avviene nel momento in cui nascono il Video Compact Disc (VCD) e, poco dopo, il Digital Versatile Disc (DVD). È attraverso il VCD che si diffondono nell’area asiatica le serie televisive giapponesi rivolte ai giovani e le prime produzioni J-Horror
la cui stessa estetica, basata su un rapporto di stretta vicinanza con l’esperienza di visione dello spettatore, presto imparò ad attingere proprio dagli aspetti più disturbanti dei formati video su cui viaggiava: analogici prima (povertà delle immagini, segni dell’usura sui nastri, interruzioni), digitali poi (glitch visivi, distorsioni sonore, clonabilità, viralità). (p. 46)
Da parte sua il DVD, invece, oltre a migliorare la qualità dell’immagine, permette la possibilità di una fruizione dell’opera non necessariamente sequenziale e la presenza di tracce audio e sottotitoli in diverse lingue. Sono tali supporti digitali ad aprire la strada alla successiva smaterializzazione dell’oggetto-film che si dispiegherà in tutta la sua potenza espansiva grazie alle piattaforme di e-commerce.
Il successo planetario delle produzioni nipponiche, oltre che per la facilità d’acquisto online dei supporti materiali, con annessa feticizzazione collezionistica dell’oggetto di provenienza esotica, è raggiunto soprattutto grazie alle produzione incentrate sul sesso e sulla violenza, ambiti già fecondi negli ambienti underground giapponesi a cavallo tra anni Ottanta e Novanta da cui derivò il successivo, e meno estremo, psyco-horror.
È stato il successo in Occidente degli horror asiatici raggiunto attraverso il passaparola informatico “dal basso” a convincere Hollywood ad accaparrarsi i diritti d’autore, quando non gli stessi realizzatori (Hideo Nakata, Shimizu Takashi, Kitamura Ryūhei…) per realizzare una serie di rifacimenti tra cui spicca, per successo, The Ring (2002) dello statunitense Gore Verbinski, remake del film di Hideo Nakata del 1998, tratto dell’omonimo romanzo di Kōji Suzuki.
La fortuna di questo tipo di film in Occidente ha presto finito per estendersi ben oltre le schiere dei cultori dei prodotti nipponici. Il successo, oltre a determinare una sorta di nobilitazione dei prodotti in patria, ha indotto gli stessi produttori giapponesi a prodigarsi nella realizzazione di film pensati direttamente per il mercato internazionale. Emblematico, a tal proposito, il caso della serie “J-Horror Theater”, comprendente sei opere di altrettanti registi giapponesi, commissionate dal produttore Takashige Ichise: Infection (2004) di Masayuki Ochiai; Premonition (2004) di Norio Tsuruta; Reincarnation (Rinne, 2005) di Takashi Shimizu; Retribution (2006) di Kiyoshi Kurosawa; Kaidan (2007) di Hideo Nakata; The Sylvian Experiments (2010) di Hiroshi Takahashi.
Il cinema giapponese contemporaneo fa dunque i conti con nuove pratiche discorsive e di fruizione che ne hanno trasformato la sua ricezione rispetto al passato favorendo l’emergere di determinate sue espressioni a scapito di altre. Rilocato su una moltitudine di schermi, che sempre meno hanno a che fare con la sala cinematografica, il cinema giapponese vanta tra i nuovi osservatori digitali, oltre ai cinefili a caccia di cult movies, anche folte schiere di “cosmopoliti pop” attratti da un’immagine diversamente giapponese. Tutti questi fruitori digitali, con le loro pratiche virtuali, sottolinea lo studioso, contribuiscono a riplasmare l’immagine nipponica sia svelandone che occultandone specificità. Secondo Calorio in ambito occidentale oggi sembra essersi fatta strada
un’immagine del Giappone e del suo cinema che si discosta con una certa fatica dai luoghi comuni del passato. Certo, le tecnologie informatiche e i fenomeni di convergenza che hanno trovato terreno fertile in un pubblico già predisposto e preparato hanno offerto un’immagine più ampia della realtà giapponese e del suo cinema, affiancando ai cliché legati alla tradizione una nuova immagine cool, otaku, kawaii o estrema. Ma questa immagine bifronte di iper-tradizione e iper-modernità non esaurisce affatto l’ampiezza di sfumature dell’attuale panorama cinematografico giapponese, composto tra le altre cose da un’ampia produzione “media” che ricalca più pedissequamente gli standard classici hollywoodiani o quelli di una tradizione cinematografica locale ben rodata, oltre che da numerosi autori indipendenti la cui opera, sul piano stilistico scevra di qualsivoglia “odore” locale, è più facilmente accostabile a modelli europei, asiatici o a tendenze cinematografiche internazionali. (pp. 106-107)
In ogni caso, sottolinea Calorio, «l’immagine odierna del cinema giapponese che filtra fino a noi, così come, di riflesso, quella che esso restituisce del Giappone, parrebbe insomma ricalcare i vecchi luoghi comuni che dipingono questo paese e il suo cinema come il luogo del crisantemo e della spada, nazione paradossale, fuori da ogni logica, terra degli estremi opposti, “paese alla rovescia”. » (p. 107)



