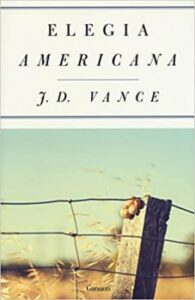di Alessandro Barile
J. D. Vance, Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family and Culture in Crisis, 2016 (trad. It. Elegia Americana, Garzanti, 2017, trad. R. Merlini, pp, 254, € 18,00)
Pochi libri recenti possono vantare la fortuna critica di Hillbilly Elegy, manifesto (post)moderno di un’America giudicata incomprensibile ma in realtà sempre uguale a se stessa. Non per caso, dunque, nell’anno del faticoso trapasso da Trump a Biden Netflix ne sforna un adattamento cinematografico, operazione fin troppo scoperta per dire: Trump è stato sconfitto alle urne ma non nella società, e se volete capire da dove deriva la sua forza vedetevi il nostro film. La profezia, sapientemente alimentata con una certa dose di mistero (del tipo: com’è possibile che dei lavoratori poveri votino un repubblicano ricco? Già, come sarà mai possibile?), viene ribadita almeno dallo sfondamento reaganiano nell’elettorato democratico. Quarant’anni di sociologie sulla crisi del ceto medio-operaio americano, nel frattempo divenuto white trash o, per dirla con Vance, hillbilly: intraducibile termine con cui vengono designate le popolazioni rurali dell’America centrale, un po’ Midwest un po’ Bible belt, un tempo contadine, poi operaie, oggi disoccupate o precarie nei fast food di Walmart. Di certo incattivite. Ma in quale preciso punto del passato queste stesse popolazioni vivevano pacificate e in sintonia con la cultura della East cost, del New England o di San Francisco? Certamente la redistribuzione keynesiana dei trent’anni gloriosi contribuiva anche negli Usa ad appianare le contraddizioni di una confederazione di culture, economie e società in carsico conflitto tra loro, unificate dall’ideologia proprietaria che è il vero collante socio-culturale americano: imporre confini (e conseguenti diritti di proprietà) – siano essi staccionate ai confini del West, recinti minerari in Alaska, selezioni “meritocratiche” nell’Ivy League o guerre umanitarie in Medioriente – è un po’ il sottotesto dell’American dream, il grumo di valori che affratella il manager newyorkese al contadino del Kentucky. E questa è sempre stata una cultura conflittuale, competitiva, rancorosa, umana solo laddove ha saputo liberarsi della distopia proprietaria, per sfiducia più che per convinzione.
- D. Vance ci parla di questo, ma lo fa in maniera prima sfuggente, poi ambigua, infine caricaturale. Un crescendo di confusione che parte proprio dal titolo. Capita spesso che la traduzione di un titolo evocativo perda per strada un certo carico di significati poetici insiti nella scelta autoriale (o editoriale). Pensiamo ai noti casi del giovane Holden (The Catcher in the Rye), o del Buio oltre la siepe (To Kill a Mockingbird), tra i mille che se ne potrebbero citare. In questo caso l’elegia hillbilly diviene, in italiano, un’elegia americana. Un apparente capovolgimento di senso: se l’autore proponeva un canto in onore di una popolazione sconfitta, in italiano l’elegia diviene tout court “americana”. Laddove in inglese c’era opposizione in italiano vi è uniformazione. Eppure, man mano che le pagine scorrono e si esplicitano più chiaramente le intenzioni dell’autore, a venire edificata è esattamente quella suggestione di riferimenti mitopoietici alla base del fatidico sogno americano, l’intruppamento al fianco di valori si direbbe eterni e si direbbe rovinati dall’incapacità di questi stessi hillbilly. Termine che, nelle intenzioni dell’autore, non descrive (solo) le popolazioni rurali del Kentucky o dell’Ohio, ma il proletariato bianco declassato da un quarantennio di crisi economica. Insomma la società trumpiana della rust belt (e il libro, anche qui non per caso, esce nel 2016, fatidico inizio del calvario politico liberale). Il sospetto che il titolo giusto sia allora quello tradotto viene confermato anche dal sottotitolo, presente nell’edizione originale e venuto meno nella versione italiana. L’impegnativa specificazione (“memoria di una famiglia e di una cultura in crisi”) sembra rimandare ad un confronto collettivo con una società impoverita, di valori e di economie, ma la narrazione rimane ancorata al suo particolare biografico, anche qui capovolgendo il senso dell’espediente: la vicenda personale di Vance viene mostrata e cantata come soluzione al lamento di una società morente (e non come espressione di questo). Per coglierne il senso conviene allora addentrarci nel racconto.
Seguendo correttamente l’etimo del sostantivo elegia, Vance procede confessandosi, rimanendo pienamente nel campo letterario dell’autobiografia, supportata (come ormai usuale) da fonti extra-letterarie: citazioni di articoli, saggi, testimonianze orali colmano il “bisogno di realtà” della narrazione memoriale, in linea con la tendenza predominante della fiction contemporanea. Si seguono le vicende, raccontate in prima persona, dell’autore invischiato in un’infanzia a dir poco difficile: madre tossicodipendente, andirivieni di padri casuali e momentanei (e violenti), difficoltà economiche e affettive colmate dal ruolo provvidenziale dei nonni; il paesaggio è quello desolato di certo Midwest (la narrazione di svolge tra Kentucky e soprattutto Ohio), non quello delle grandi praterie del Kansas o dell’Oklahoma però, ma quello post-industriale e impoverito degli Appalachi, delle acciaierie dismesse e del welfare aziendale in rapida ritirata. Dentro questa catastrofe collettiva e, in particolare, personale-familiare, ecco la progressiva catarsi: dapprima l’arruolamento nei Marines – e quale edificio mitologico americano non li prevede prima o poi? – poi l’iscrizione alla Ohio State University, infine la laurea in Legge a Yale. Basta volerlo, ci ricorda Vance, e l’inevitabile sacrificio connesso alla purificazione (dal suo ambiente di sconfitte e di depressione) è l’allontanamento dalla madre-matrigna. Insomma, recidere le radici apprestandosi ad entrare nell’America che conta, quella della Ivy League e dei grandi studi notarili, realizzando infine quell’American dream davvero alla portata di tutti.
E se l’autore procede cautamente nei primi capitoli – forse i più utili o, come dire, i più sostenibili – in quanto impegnato nell’evocare un ambiente che è al tempo stesso familiare e sociale, nella seconda parte della narrazione – la fuoriuscita dall’incubo, inteso come destino segnato – Vance deborda in un riscatto che è solo individuale, pienamente proprietario, in opposizione a quella stessa popolazione, quegli stessi hillbilly, immobili in un destino di sconfitta per mancanza di coraggio, di intraprendenza, vincolati alla catena del lamento. L’autore, meritoriamente, non nasconde la sua posizione: fa vanto di definirsi neocon, e non è certo questo il problema, anzi lo si apprezza proprio nel tentativo (però fallito) di superare il suo orizzonte ideologico. Si racconta come neocon ragionevole, la società è divisa in classi e le fratture non ricalcano le difficoltà economiche, ma valoriali (sempre questi “valori” di mezzo, vera ossessione americana): è la “volontà di farcela” la molla per uscire fuori da una cultura perdente. Il risultato di questa lotta (che non è una lotta “per il riconoscimento”, ma per emergere fuori – e contro – il suo ambiente sociale) è lo stesso J. D. Vance, laureato a Yale e oggi venture capitalist tra Cincinnati e San Francisco. Una storia di successo allora, quella che non potranno mai avere i suoi cari hillbilly. Perché “si accaniscono contro il governo invece di lavorare”, si legge in uno dei tanti passaggi metafisici del libro, manifesto di un’etica capitalistica derisa oggi dagli stessi sacerdoti della meritocrazia liberista.
Caricato di aspettative sin dal titolo, il libro procede dunque adeguandosi agli standard del politicamente scorretto: se siete poveri è colpa vostra, anzi: è colpa del governo che concede agli hillbilly di vivere a spese dei contribuenti americani. Mettiamo da parte allora il contenuto. Ma che lingua ci propone l’autore? Quale la costruzione narrativa? Anche qui le attese non mancavano. Anzi, si potrebbe addirittura dire di una certa speranza di ritrovare una certa poetica di una certa America: quella letteratura d’animo, come dire, “confederato”, violentemente disincantato e in lotta con Dio e con l’uomo. Alienata, certo, ma non mistificante. Non l’America di Hemingway o di Dos Passos, cosciente e giornalistica; ma quella che ha come nome tutelare Faulkner e come figlia (legittima?) Flannery O’Connor. Riferimenti ovviamente ideali e non perseguibili, ma che trovano ad esempio in Truman Capote una stramba ed esaltante rivisitazione iperrealistica, che somma, come suggerisce Alberto Rollo nella nuova traduzione di A sangue freddo, «una lingua indecisa fra la disciplina del dettato (mutuata dal giornalismo), la furia della ricerca (legata all’esibizione dei materiali) e la seduzione di un lessico e di una sinfonia opulenti». Un procedere essenziale e al contempo barocco, tipico di una certa letteratura “del sud”, luogo geo-letterario di straordinaria effervescenza poetica e linguistica. Niente di tutto questo, purtroppo. Il lessico piano e stringato non arriva prima “al punto” ma lo aggira. Contribuisce, da par suo, ad alimentare la confusione di una condizione umana non più indagata ma colpevolizzata, e qui si situa il limite decisivo di un romanzo colmo di potenzialità (e di pretese), ma che si ferma sull’uscio dei problemi, ritirandosi al momento di guardarli negli occhi. Il risultato è quello dell’occasione mancata. Se avessimo voluto capire i motivi profondi della società trumpiana, se avessimo voluto farci spiegare davvero questa distonia strutturale tra aspirazioni ideali e condizioni materiali che negli Usa raggiungono l’acme occidentale, dovremo rassegnarci a guardare altrove. Rimanendo sempre in Ohio, forse rivolgendoci al recente esordio di Stephen Markley (intitolato, per l’appunto, Ohio). Ma questa è un’altra storia.