di Alessandro Barile
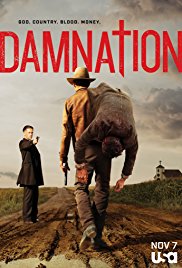 Damnation è una serie Netflix che vorrebbe raccontare episodi della lotta di classe negli stati rurali degli Usa nel mezzo della depressione degli anni Trenta dello scorso secolo. Nobile proposito, peraltro in scia di una lunga serie di tentativi simili. Complice la crisi economica o l’elezione di Trump, la depressione (esistenziale) sembra andare di gran moda oltreoceano. Varcando le (temibili) soglie della prima puntata, però, il contesto sociale perde subito centralità ed efficacia, lasciando campo libero all’azione di una maleodorante congrega di protagonisti in guerra fra loro: il pastore Seth e il suo alter ego Creeley, lo sceriffo e le sue malefatte adolescenziali, bordelli e “legioni nere”.
Damnation è una serie Netflix che vorrebbe raccontare episodi della lotta di classe negli stati rurali degli Usa nel mezzo della depressione degli anni Trenta dello scorso secolo. Nobile proposito, peraltro in scia di una lunga serie di tentativi simili. Complice la crisi economica o l’elezione di Trump, la depressione (esistenziale) sembra andare di gran moda oltreoceano. Varcando le (temibili) soglie della prima puntata, però, il contesto sociale perde subito centralità ed efficacia, lasciando campo libero all’azione di una maleodorante congrega di protagonisti in guerra fra loro: il pastore Seth e il suo alter ego Creeley, lo sceriffo e le sue malefatte adolescenziali, bordelli e “legioni nere”.
Le ragioni della lotta di classe vanno rapidamente a farsi benedire, ripescate di tanto in tanto con qualche frasetta ad effetto che però stimola solo la confusione generale dei racconti sovrapposti. Se lo sviluppo della storia è talmente povero da aver dileguato persino l’idea di una seconda stagione (la serie è stata un flop di pubblico e ascolti tale da consigliare a Netflix l’abbandono), qualcosa si dovrebbe dire riguardo alla prima puntata, che invece dovrebbe rappresentare l’esca ideologica per spettatori progressisti (che costituiscono il target principale di Netflix). E’ proprio la prima puntata il problema in questo caso, non lo scontato scivolamento fumettistico delle restanti nove. E’ il modo in cui viene costretto il racconto delle lotte di classe a essere, come minimo, diseducativo.
Le masse contadine sono soltanto oggetto di una storia che si svolge altrove e secondo altri parametri narrativi, che rientrano poi nel consueto canone hollywoodiano: al centro del racconto c’è l’eroe, deus ex machina di qualsiasi emancipazione sociale, impossibile a darsi nelle forme davvero collettive che auspica. Il protagonista e i suoi avversari combattono una guerra privata, in nome e per conto di protagonisti reali che possono solo rimanere sullo sfondo, subalterni alla lettura eroica che disattiva ogni forza non incarnata in qualche way of life ribelle o reazionaria che sia.
Le masse senza volto non possono essere raccontate se non attraverso la personificazione eroica (e borghese) di un qualche vendicatore mascherato. Un cliché talmente abusato da scontentare persino i chierici dello stile hollywoodiano. Ovviamente il finale è già scritto nelle premesse: se la questione è solo frutto dello schiribizzo personale di qualche avventuriero, saranno le volontà di quest’ultimo a determinare le evoluzioni della lotta di classe. Fatta la pace con l’antagonista in nome dei sacri sentimenti familiari, ecco ricomposta l’unità nella provincia americana: sceriffo e popolazione, banchiere dai nobili sentimenti progressisti e crumiro dal cuore d’oro, tutti nuovamente riuniti nella fede nel progresso.
E’ così che vanno le cose nel mondo reale? Ovviamente no. Persino nella violentissima epopea rivoluzionaria delle lotte contadine e operaie negli Stati Uniti del primo trentennio del Novecento la lotta di classe era un fatto collettivo e anonimo, eroico nella sua necessità storica e non nella volontà di qualche cow boy operaio folgorato sulla via di Damasco dall’amore per una donna (qui l’affastellarsi di stereotipi, invece di raggiungere «profondità omeriche», come direbbe Eco, tracima più prosaicamente nel ridicolo). Raccontare le lotte operaie attraverso strumenti culturali borghesi non farà altro che rafforzare questi ultimi e impoverire la forza evocativa dei processi collettivi, che sono composti da molteplici ed eroici atti di coraggio individuali, comprensibili però solo dentro dinamiche sociali più grandi e dirompenti di ciascuno.
Vale per il proletariato, ma anche per la borghesia, anche qui (figuriamoci) incarnata dal banchiere senza scrupoli e non nei suoi crudi e impersonali rapporti di forza. Dopo un secolo siamo ancora al dannunzianesimo riproposto in sedicesimi, senza neanche il coraggio di rischiare il tutto per tutto ed essere davvero provocatori. Qui la provocazione si ferma a una pistola nascosta in una bibbia.
Non si pretende certo una qualche forma di virtuoso realismo in una serie televisiva targata Netflix, per carità di patria. Ma allora, invece di prendersi sul serio, si abbassino le ambizioni e si racconti semplicemente il travaglio psicologico di qualche sbandato del Midwest. Si ammetterebbero i propri limiti, ma almeno ci si godrebbe uno spettacolo per quello che è: un intrattenimento, e non uno strumento di comprensione della realtà.



