di Franco Pezzini
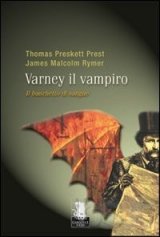 Potrà non essere considerata alta letteratura, eppure confesso un’assoluta ammirazione per gli autori di penny dreadful (“spaventi da un penny” — o penny blood o penny number), misconosciuti protagonisti a metà dell’Ottocento inglese di una delle più curiose avventure editoriali dell’età moderna. Autori costretti a scrivere a marce forzate in un continuo rilancio di colpi di scena, visto che i capitoli-puntate delle loro saghe erano sfornati settimanalmente a beneficio di un bramoso pubblico, con tirature da capogiro (grazie alla meraviglia delle nuovissime rotative a vapore) e successo da urlo. Autori che spesso scrivevano nel più oscuro anonimato, e i cui pensieri, emozioni e sogni possiamo in genere dedurre solo da indizi indiretti, ma che hanno influenzato con prepotenza l’immaginario del loro tempo — e non soltanto, a giudicare da influssi ancora avvertibili sui moderni cinema e TV. Autori che lavoravano per diversi editori, ma il cui pull più celebre costituiva il nerbo della cosiddetta “Salisbury Square School of Fiction”, cioè la casa editrice del dinamico Edward Lloyd (1815-1890), ex-edicolante figlio di un agricoltore rovinato dalle enclosures, liberale e membro del Reform Club.
Potrà non essere considerata alta letteratura, eppure confesso un’assoluta ammirazione per gli autori di penny dreadful (“spaventi da un penny” — o penny blood o penny number), misconosciuti protagonisti a metà dell’Ottocento inglese di una delle più curiose avventure editoriali dell’età moderna. Autori costretti a scrivere a marce forzate in un continuo rilancio di colpi di scena, visto che i capitoli-puntate delle loro saghe erano sfornati settimanalmente a beneficio di un bramoso pubblico, con tirature da capogiro (grazie alla meraviglia delle nuovissime rotative a vapore) e successo da urlo. Autori che spesso scrivevano nel più oscuro anonimato, e i cui pensieri, emozioni e sogni possiamo in genere dedurre solo da indizi indiretti, ma che hanno influenzato con prepotenza l’immaginario del loro tempo — e non soltanto, a giudicare da influssi ancora avvertibili sui moderni cinema e TV. Autori che lavoravano per diversi editori, ma il cui pull più celebre costituiva il nerbo della cosiddetta “Salisbury Square School of Fiction”, cioè la casa editrice del dinamico Edward Lloyd (1815-1890), ex-edicolante figlio di un agricoltore rovinato dalle enclosures, liberale e membro del Reform Club.
Lloyd era partito nel ’35 col lanciare sul mercato economicissime edizioni-tarocco di bestseller dickensiani: e appunto in questa meritoria intrapresa si era illustrato uno dei nostri eroi. Pare infatti che a scrivere gli spudorati The Penny Pickwick, The Life and Adventures of Oliver Twiss, Workhouse Boy, poi David Copperful e Nickelas Nicklebery sia stato, tra gli anni Trenta e Quaranta, quel Thomas Preskett Prest — oppure Peckett Prest, persino i dati anagrafici sono dubbi (1810?-1859) — che presto diviene una delle colonne portanti della squadra. Possiamo immaginare una certa ironia, da parte di autore ed editore, nel lanciare esche per i fan dell’Immenso Romanziere (anzi Prest si firma a volte “Bos”, ammiccando al “Boz” pen name di Dickens): ma a complicare le cose arriva nel 1842 una nuova legge sul diritto d’autore. Lloyd ha però il naso lungo: da quell’anno inizia a pubblicare periodici, con grande successo (soprattutto nel caso del «Lloyd’s Illustrated London Newspaper», poi divenuto «Lloyd’s Weekly Newspaper»), e in parallelo decide di battere in modo anche più convinto il filone del sensazionalismo nero tanto amato dai connazionali. Già dal Settecento il celebre «The Newgate Calendar, or Malefactors’ Bloody Register» — in origine un bollettino sugli impiccati del mese nel carcere di Newgate — faceva sdilinquire i lettori con storie trucissime di true crime; e dalla fine degli anni Venti del secolo successivo a tener banco sono le cosiddette Newgate novels, che rileggono melodrammaticamente le gesta di criminali celebri con tale successo popolare da suscitare crescenti timori di emulazione (le accuse odierne ai film dell’orrore non costituiscono insomma una novità). Si noti che la formula delle Newgate novels è perseguita anche da autori di vaglia, come Edward Bulwer-Lytton con Paul Clifford ed Eugene Aram (rispettivamente 1830 e 1832), o lo stesso Dickens con Oliver Twist (1837), da qualche critico compreso nella categoria. Ma una delle ultime prove degne d’attenzione, il melodramma di amori e sbarre Newgate: A Romance (1847), viene scritta proprio da Prest — poi lentamente il filone evolve verso altre forme, poliziesco compreso. Assodato dunque il piacere per il nero, Lloyd vuole però fidelizzare il suo pubblico: e niente di meglio che offrire i romanzi a puntate a fascicoli settimanali. Appunto gli “spaventi da un penny”.
Il fenomeno penny dreadful nasce negli anni Trenta, per conoscere il massimo sviluppo nel decennio successivo e defluire in seguito verso la fascia di pubblico più giovane. A divorare queste storie a tinte forti, con passioni e brividi più o meno orrifici, sono soprattutto la piccola borghesia cittadina — in particolare di una Londra in espansione caotica, fuligginosa e labirintica nell’incalzare dell’industrializzazione — e i membri alfabetizzati delle classi lavoratrici. Vengono così ristampati o a volte riscritti per lettori di bocca buona capisaldi del gotico come The Monk o The Castle of Otranto, ma più spesso si tratta di storie nuove — e qui entra in gioco la fantasia della squadra di Lloyd. In cui brilla quel talentaccio di Prest, musicista di vaglia, giornalista vivace, e inventore di trame capace di passare disinvoltamente dalla pagina stampata alle tavole dei teatri: e che tra un trasloco e l’altro per sfuggire ai creditori, afflitto da problemi con l’alcool e via via consumato da un superlavoro sicuro quanto poco retribuito, partorisce per la Casa una sfilza di storie scellerate.
A partire idealmente (se l’identificazione autorale è corretta, visto che il testo è anonimo) da quel Sweeney Todd or The String of Pearls apparso a puntate su «The People’s Periodical and Family Library» in diciotto capitoli nel 1846; con un tale successo da indurre l’Autore a dilatarlo a ben centosettanta capitoli per l’edizione dell’anno successivo, reintitolata The String of Pearls: A Romance. Nell’opera le gesta dell’infame Sweeney Todd, “the Demon Barber of Fleet Street” impiccato nel 1802 a Newgate, non sono ancora paludate dall’aura romantica di vendetta che l’accoppiata Tim Burton-Johnny Depp celebrerà con il film del 2007: si tratta di squallidi crimini per denaro con eliminazione dei corpi in pasticci di carne, e il fatto che Fleet Street disti tanto poco dalla Salisbury Square degli uffici di Lloyd, e sia da sempre sede di giornali (al punto da essere nota come Ink Street, “via dell’inchiostro”) pone il problema se Prest non intenda togliersi sottotesto qualche sassetto sul cannibalismo degli editori. Nel 1850 un’edizione ristretta dell’opera, The String of Pearls or A Sailor’s Gift, in trentanove capitoli e frutto di più mani — compresa, pare, quella di James Malcolm Rymer (1814-1884) di cui dovremo riparlare — le darà un assetto più o meno definitivo; e intanto nel ’47 il diabolico barbiere si è conquistato uno spazio anche nel mondo dello spettacolo, con l’adattamento teatrale di George Dibdin Pitt forse aiutato dallo stesso Prest. In Italia la versione ridotta del ’50 è apparsa nel 2007 per i tipi Newton Compton (Sweeney Todd — Il diabolico barbiere di Fleet Street), curata in modo eccellente da Cristiano Armati: resta invece purtroppo intradotta la versione estesa, che ancor meglio avrebbe potuto mostrare ai nostri lettori il ribaldo virtuosismo di Prest. Sulla stessa scia, comunque, vengono a lui attribuite opere truci come The Maniac Father; or, The Victims of Seduction, The Brigand; or, The Mountain Chief: A Romance, Vice and its Victims; or, Phoebe the Peasant’s Daughter, The Miller and His Men; or, The Bohemian Banditti e The Hebrew Maiden; or, The Lost Diamond. Fino a quel Varney the Vampyre; or, The Feast of Blood che, inizialmente considerato farina del suo sacco, la critica tende invece oggi ad accreditare — almeno nella parte più ampia, perché probabilmente vi ha posto mano più di un autore — al citato collega Rymer. Anche su quest’ultimo, ingegnere civile e giornalista, sappiamo piuttosto poco. Di origine scozzese, sembra sia vissuto un periodo in America (ciò che può meglio spiegare alcune sue fonti); e nella sua strabordante produzione per Lloyd e altri editori, in forma anonima o sotto pseudonimi, si annovererebbero titoli come The Black Monk; or, The Secret of the Grey Turret, Ada the Betrayed; or, The Murder at the Old Smithy, The First False Step; or The Path to Crime e The Wronged Wife: or The Heart of Hate — che possono già dirla lunga sui contenuti.
Ma il panorama penny dreadful è ovviamente più ampio. Per restare ai più noti, basti pensare a The Mysteries of London, avviato nel 1844 da George William MacArthur Reynolds su ispirazione al feuilleton Les Mystères de Paris di Eugene Sue, e dopo le prime due serie continuato da colleghi: diventerà The Mysteries of the Court of London, e correrà dal 1848 al 1856, fornendo ai lettori un tramite ideale tra i castelli del primo gotico e l’orrore urbano della tarda età vittoriana. Oppure al primo romanzo di licantropi, Wagner, the Wehr-Wolf sempre di Reynolds, pubblicato a puntate in settantasette fascicoli, tra il 1846 e il 1847: un’opera il cui eroe nero — un Uomo Lupo, ideale contrappunto teratologico al vampiro del Varney — muove dalle fantasie diavolesche del Faust, per ammodernarsi però in frequentazioni (la seducente criminale Nisida) e conclusione (il deus ex machina dei soliti Rosacroce di moda all’epoca, si pensi a Zanoni di Bulwer-Lytton, 1842). Va detto che Reynolds (1814-1879), a differenza di Prest, Rymer e gran parte dei colleghi, non scrive nell’ombra ed è all’epoca apprezzato quanto Dickens; giornalista e fondatore di riviste, milita con passione nel Movimento cartista. È invece nuovamente anonimo uno tra gli ultimi “spaventi da un penny”, quel fortunatissimo Black Bess; or, the Knight of the Road, ispirato liberamente alla vita del leggendario brigante Dick Turpin (1705?-1739), che andrà avanti per 254 puntate tra il 1867 e il 1868 e torna a guardare alle saghe di criminali e forche di Newgate: attribuito quale opera giovanile allo studioso shakespeariano Edward Viles, il testo viene oggi riconosciuto come scritto almeno parzialmente dal giornalista John Frederick Smith. Nel frattempo Prest è morto in miseria, coi polmoni devastati, logorato dal suo scrivere matto e disperatissimo dietro le quinte; Rymer invece vedrà il crepuscolo dei penny dreadful e il nascere di nuove forme di letteratura popolare — e l’ormai ricco Lloyd sopravvivrà a entrambi.
Alla luce di tutto ciò, la proposta in Italia per i tipi Gargoyle di Varney the Vampyre reca l’opportunità di accostarsi a un personaggio fondamentale per lo statuto letterario del vampiro — a rappresentare il vero trait d’union tra il Lord Ruthven di Polidori, a inizio Ottocento (1819) e il Conte Dracula di Bram Stoker a fine secolo (1897), nell’ambito di una genealogia il cui ultimo epigono è in fondo l’Edward Cullen di Twilight. Ma insieme Varney, con la sua folla di personaggi e gli scorci vivacissimi su una società in trasformazione, rappresenta l’esempio più emblematico dell’orizzonte penny dreadful; e fa apprezzare (con un’operazione di enorme impegno per la casa romana), un modo di narrare e un’intera epopea di letteratura popolare. Apparso tra il 1845 e il 1847 in fascicoli settimanali, alla conclusione Varney viene immediatamente accorpato in un’edizione in tre volumi, il triple decker delle biblioteche circolanti: e con le sue 868 pagine per la bellezza di 220 capitoli, lungo infinite e complicatissime avventure, sembra evocare anche formalmente la tortuosa fuga nel tempo del protagonista. Nell’imminenza dell’uscita del volume conclusivo (novembre 2010), la complessità della vicenda offerta nei primi due e la latitudine della panoramica rendono possibile già formulare qualche considerazione sull’opera — in particolare sulla vivacissima fantasia dell’Autore e la disinvoltura con cui gioca la materia.
Si è ipotizzato che la storia di Varney trovi prima ispirazione in una leggenda del Cumberland, il discusso caso di Croglin Grange (a meno che il romanzo abbia influito sulla trascrizione tardottocentesca del caso, però un’ipotesi non esclude l’altra). Ma soprattutto attinge a un orizzonte fantastico assai ampio, da Shakespeare a Scott (nel cui Kenilworth, 1821, c’è un vilain di nome Varney) e Ann Radcliffe, da Polidori a Mary Shelley (Frankenstein e il racconto Il mortale immortale), da Hawthorne (ne La lettera scarlatta c’è un allarmante Chillingworth — qui il nome del medico) a Poe, e fino ovviamente a Dickens. La sua influenza poi sarà massiccia, dai coevi personaggi tenebrosi delle sorelle Brontë fino a testi assai più tardi. Il vertiginoso finale del Varney (forse tributario delle scene vesuviane di Zanoni) può aver suggerito la scena principale del racconto The Final Problem di Conan Doyle, come l’ingombrante patriarca Marmaduke di casa Bannerworth ispirerà forse in chiave parodistica l’omonimo personaggio dell’Orlando di Virginia Woolf.
Ma soprattutto, ovviamente, il vecchio penny dreadful offrirà ispirazione per Dracula. Già nel Varney troviamo un gruppo di giovani più o meno aristocratici e senza padri — a segnare una significativa cesura col passato — che devono fronteggiare il vampiro. Troviamo poi un trio di figure mature — cioè due similpadri, Mr. Marchdale e l’ammiraglio Bell, e un medico, Chillingworth — che con le loro connotazioni di bizzarria e ambiguità possono ben aver conosciuto sintesi nel Van Helsing di Stoker. In particolare Chillingworth — emulo di Frankenstein in quelle tecniche di resurrezione alle quali Gianfranco Manfredi ha da poco offerto un splendido romanzo sempre per Gargoyle — appare nei panni dell’indagatore e ha una moglie scomoda nel senso di pirotecnicamente insopportabile; quella di Van Helsing sarà pazza. Ma anche Varney, apprendiamo, appartiene alla sfera dei padri, complice com’è di quello criminale e suicida dell’innocentissima Flora: dove una notevole differenza da Stoker sta nel fatto che in Varney Darwin non ha ancora spazio, e i figli non sono geneticamente contaminati dalle colpe dei genitori. Mentre il “nobile d’Ungheria” e il barone (sedicente) austriaco che compaiono nel secondo volume preparano idealmente agli austro-ungheresi Karnstein di Le Fanu e e al conte transilvano-ungherese di Stoker.
Troviamo poi nel Varney, declinato variamente in tutta l’opera ma centrale soprattutto nela prima parte, un interesse spasmodico per le proprietà immobiliari — tema che costituirà il punto di partenza del Dracula. Troviamo la frase “Tu non hai mai amato!”, che qui (cap. 28) non è rivolta al vampiro come in Dracula, ma che il vampiro riecheggia nelle proprie confidenze a Flora (“…finora non ho mai amato”, cap. 34). E troviamo lo stranissimo racconto dell’ammiraglio Bell sul “passeggero maledetto” (cap. 25) — forse il punto più genuinamente inquietante del Varney — che prelude quasi testualmente al racconto del terribile viaggio di Dracula sul Demeter. Il peso del tema della caccia al mostro negli equilibri della narrazione è rilevante in entrambi i testi, e si possono ravvisare affinità tra le graziose vittime dell’uno e dell’altro vampiro. Varney riesce poi a stare “come una mosca sul muro” (cap. 87) e rammentiamo il modo di muoversi di Dracula sul muro del castello; ci si aspetta che Varney sia fuggito verso il labirinto di Londra, “probabilmente a Piccadilly” (cap. 103), e Dracula troverà proprio lì uno dei suoi covi, protetto dalla vastità della metropoli. E c’è persino un punto del Varney (cap. 104) in cui le battute circa una strana apparizione sul mare possono aver offerto spunto a Stoker per la potente immagine marina del suo romanzo tardo The Lady of the Shroud (1909).
Fin qui si tratta di influssi su Stoker: ma si potrebbe addirittura ipotizzare un’influenza diretta del Varney sul Dracula cinematografico di Tod Browning con Bela Lugosi (1931) — e forse già sui precedenti teatrali, che per certi versi richiamano più da vicino situazioni del vecchio penny dreadful che non il romanzo stokeriano. Nelle play di Hamilton Deane e di John L. Balderston, infatti, il vampiro è a tutti gli effetti un ambiguo vicino di casa, proprio come Varney, e non semplicemente l’ospite di una costruzione in rovina; e il suo rapporto con i vicini si articola in schermaglie la cui posta è la giovane di turno. Di più: nel film di Browning trova per la prima volta statuto cinematografico il fatto che il vampiro abiti in un’abbazia (Carfax Abbey): un elemento che reca una lieve forzatura al richiamo stokeriano alla “cappella o chiesetta” compresa nella proprietà di Carfax, e che in seguito rileverà visivamente in parecchi film. Certo, come qualche critico osserva, può trattarsi di un richiamo all’abbazia di Whitby che Stoker ben conosceva: ma è difficile cancellare il dubbio di una derivazione dal Varney, dove il vampiro abita in Ratford Abbey nei pressi di Bannerworth Hall.
La partizione in volumi dell’edizione italiana è quella storica del triple decker, più o meno sulla base dell’ingombro paginale e non di una precisa architettura di trama. Che però in qualche modo viene soddisfatta: così il primo volume (Varney il vampiro. Il banchetto di sangue, apparso a marzo), incentrato sulla persecuzione del succhiasangue ai danni di Flora Bannerworth e della sua famiglia, si conclude preparando il lieto ricongiungimento degli amanti, con la presa di coscienza da parte del lettore che Varney è sì un vilain ma capace di umanissimi tormenti e imprevedibili atti di generosità. E il secondo (Varney il vampiro. L’inafferrabile, uscito a luglio) vede risolvere i misteri di quel ramo principale della vicenda, e aprirne di nuovi attraverso il caso dell’enigmatico barone Stolmuyer. Senza togliere sorprese a chi legga, è anzi proprio in questo secondo volume che l’originalità del narratore, ormai affezionato al cast, emerge in modo più ruspante e disinvolto. Varney non è diventato buono, ma riesce a spiazzare il lettore con il suo comportamento insieme spregiudicato e candido, rapace e cavalleresco: e nel modellare in progress, a suon di colpi di scena, l’immagine vampiresca, l’Autore non si fa scrupolo di mettere in crisi e ridiscutere ogni nostra certezza sul personaggio. Non solo attraverso la cifra del turbamento di lui e delle contraddizioni che ne derivano, ma costringendo a una continua reinterpretazione di dati che crediamo acquisiti. Varney è un vampiro, ma in che senso? Quale è stato il rapporto con il procedimento di reviviscenza gestito dal dottor Chillingworth (che è difficile immaginare senza i tratti di Peter Cushing)? Quale poi la verità sull’attacco-stupro a Flora, che nel corso del secondo volume viene riletto da Varney (cap. 88) in un senso del tutto diverso? Certo tutto ciò è funzionale a un rilascio progressivo di rivelazioni al lettore, con continue dilazioni in termini di suspense; ma al contempo si avverte come l’Autore rimodelli via via, una settimana dopo l’altra, caratteri ed eventi. E i passi successivi di questo rapporto illusionistico con la verità non potranno che essere rappresentati dall’allusiva ambiguità di Le Fanu e dall’inconoscibilità del Dracula di Stoker, avvicinato solo attraverso le memorie dei suoi nemici.
Ovviamente Varney mira alle giugulari ed è anzi il primo vampiro della letteratura a lasciare fori sul collo (si rimanda alla bella introduzione di Fabio Giovannini al secondo volume) — anche se qualcosa di crudamente sessuale sembra sempre alluso nei suoi attacchi. Ma in realtà, si percepisce, l’interesse più pressante dei vampiri del Varney è quello economico: appropriazioni immobiliari, rapine, ricatti. E del resto se lo sbandato protagonista, alla deriva del tempo e delle leggi degli uomini, è un vilain e un vampiro, l’Autore dipinge con spietata ironia la natura feroce e vampiresca di gran parte del consorzio umano — incapace, a differenza dell’antieroe, di rimorsi anche solo saltuari. Un orizzonte talora rappresentato da singoli individui, maschere di avidità come la caricaturale Mrs Williams (che svende la figlia più carina col compiaciuto assenso delle altre) o d’una religiosità ipocrita e arraffona, come nel caso dell’odioso quacchero Shepherd; e talora invece da quell’orrida mob, moltitudine minacciosa e ignorante la cui caccia al vampiro ha il respiro del caos. In scena nel Varney troviamo il demone del gioco, la miseria divorante; troviamo la caricatura di un riscatto attraverso occupazioni maledette (la melodrammatica storia del boia); troviamo il delitto. A riecheggiare in fondo il richiamo di Newgate, le sue saghe di marginalità e violenza: Varney stesso — o meglio la sua precedente identità di Francis Beauchamp — aveva pagato col capestro per i propri crimini, varando un rapporto tra vampiri e impiccagioni poi corteggiato dal cinema (si pensi alla pellicola Hammer Captain Kronos Vampire Hunter, 1974, o a Dracula 2000). E d’altra parte l’evocazione del vampiro tradisce, persino al di là delle intenzioni dell’Autore, un senso di disagio: trickster malinconico e sorta di Robin Hood riveduto e corrotto, Varney permette la messa a fuoco dei vampirismi sociali, fa esplodere le contraddizioni nei rapporti coi beni, col tempo e con la stessa interiorità — ed è immagine di una desolazione che nessun fighetto Cullen potrebbe restituire.
Eppure l’Autore non vuole lasciare con la bocca amara. Una storia che veda vampiri accolti con catini di saponata (cap. 83), e il cui secondo volume termina addirittura con un inseguimento alla Ridolini e una torta in faccia tra personaggi di contorno non può esaurirsi nella malinconia. Anzi una parte persino più ampia di quella orrifica è dedicata alla commedia, in particolare attraverso gli esilaranti teatrini tra l’ammiraglio e il suo compagno/contraltare, il marinaio Jack Pringle — i personaggi più vivaci dell’intera storia. Sono proprio loro — o altri uomini di mare, la categoria cui l’Autore guarda con maggior simpatia — a usare la definizione “uno strano pesce” per figure che considerano bizzarre o al di fuori dei propri parametri. Una definizione che applicano allo stesso Varney, e che nei sottocodici del romanzo finisce talora per svelare un vampiro (cap. 115): e si è tentati di collegare il concetto alle Jenny Haniver, le sirene farlocche assemblate con parti disseccate di pesci chitarra per stupire i sempliciotti. Insomma il monstrum come manipolazione illusionistica, gioco marpione di assemblaggi a beneficio di un pubblico ben disposto: qualcosa che ben può richiamare la disinvolta manipolazione letteraria del modello-vampiro e degli ingredienti delle sue saghe, ai tempi del Varney come di Twilight. Ma che insieme evoca, a un livello più generale, le pirotecnie artigianali dei penny dreadful e di tanta misconosciuta letteratura popolare: una lezione con cui l’anonimo autore del Varney e i suoi colleghi continuano a stupirci e deliziarci.



