di Giuseppe Genna
 A volte gli scrittori hanno problemi – o ne creano ai loro lettori. E’ il secondo caso quello di cui qui si scrive. Sono assolutamente sconcertato dalla inaspettata prova di potenza che Cormac McCarthy, autore della memorabile Trilogia della Frontiera (Meridiano di sangue, Cavalli selvaggi e Città della pianura), offre con questo suo nuovo, chirurgico romanzo, Non è un paese per vecchi. Non è un mondo né per vecchi né per giovani, quello in cui McCarthy ambienta il più classico inseguimento a tre dell’hard-boiled anni Cinquanta, pura occasione narrativa per costruire la premessa maggiore alla conclusione di un sillogismo sorprendente, che ha tappe consimili a un’operazione endoscopica: la spietatezza pura, la spietatezza del tempo in generale e di questo tempo in particolare, e di quest’epoca americana ancor più in particolare.
A volte gli scrittori hanno problemi – o ne creano ai loro lettori. E’ il secondo caso quello di cui qui si scrive. Sono assolutamente sconcertato dalla inaspettata prova di potenza che Cormac McCarthy, autore della memorabile Trilogia della Frontiera (Meridiano di sangue, Cavalli selvaggi e Città della pianura), offre con questo suo nuovo, chirurgico romanzo, Non è un paese per vecchi. Non è un mondo né per vecchi né per giovani, quello in cui McCarthy ambienta il più classico inseguimento a tre dell’hard-boiled anni Cinquanta, pura occasione narrativa per costruire la premessa maggiore alla conclusione di un sillogismo sorprendente, che ha tappe consimili a un’operazione endoscopica: la spietatezza pura, la spietatezza del tempo in generale e di questo tempo in particolare, e di quest’epoca americana ancor più in particolare.
E ciò nonostante il tutto si svolga agli inizi degli anni Ottanta, fatti i debiti calcoli sull’età del più empatico tra i protagonisti, il trentaseienne Moss, reduce dal Vietnam, di professione saldatore, che sarebbe reduce anche da una sfortunata giornata di caccia all’antilope, se non trovasse, immersi in un silenzio assoluto, alcun SUV con a bordo trafficanti di droga, messicani, morti o quasi. C’è stata una sparatoria. Qualcuno è fuggito coi soldi. Quel qualcuno, Moss, lo ritrova: è morto a poca distanza ed è a lui che l’ormai già ex saldatore strappa di mano una borsa contenente due milioni di dollari. 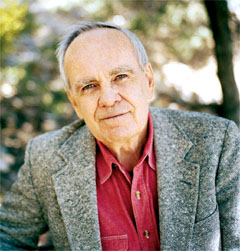 E’ l’inizio di una fuga devastante, che ha per protagonista il vecchio sceriffo Bell insieme a un sicario di professione, l’impronunciabile Chigurh, psicopatico, dotato di un’arma allucinante per potenza e modalità di esplosione dei colpi – un aggeggio ad aria compressa che lo rende estraneo a qualunque contesto narrativo, esattamente come il suo sguardo gelido, descrivendo il quale sembra di avvertire tremare il polso perfino al vecchio cuoiato McCarthy, lo scrittore che, con Ellroy, dispone attualmente dell’immaginario più tenebrosamente implacabile del comparto letterario Usa.
E’ l’inizio di una fuga devastante, che ha per protagonista il vecchio sceriffo Bell insieme a un sicario di professione, l’impronunciabile Chigurh, psicopatico, dotato di un’arma allucinante per potenza e modalità di esplosione dei colpi – un aggeggio ad aria compressa che lo rende estraneo a qualunque contesto narrativo, esattamente come il suo sguardo gelido, descrivendo il quale sembra di avvertire tremare il polso perfino al vecchio cuoiato McCarthy, lo scrittore che, con Ellroy, dispone attualmente dell’immaginario più tenebrosamente implacabile del comparto letterario Usa.
A un ritmo che non è frenetico perché viene calmato dai frequenti dialoghi, spesso monosillabici, ma che rimane velocissimo (esattamente come a uno psicotico si dà il Serenase e questo non muta di una virgola la situazione generale), la fuga si snoda in un on the road cupissimo e al calor bianco, sul confine col Messico: stanze di motel affittate e riguardate come tane di serpenti, auto noleggiate o rubate per viaggi che non sono scorribande ma precisi spostamenti che costruiscono la geometria solida di un inseguimento che non lascia respiro, confronti all’arma non bianca che sono freddissime scene di devastazione organica, un profluvio di sangue congelato dallo stile del geniale autore ritiratosi in Texas. Il corredo c’è tutto. Sarebbe già un gran libro a 2/3, ma a 2/3 il giallo ha la sua soluzione più devastantemente impietosa e lascia aperta una porta che nessuno sarà in grado di chiudere.
E’ a questo punto che McCarthy, improvvisamente, al di fuori di ogni logica canonica, inserisce una sorta di secondo romanzo, che è l’esatto opposto del romanzo di formazione: un romanzo di addio, una narrazione di congedo, la profezia enunciata nel momento in cui si avvera e si consuma. La voce fondamentale è quella del vecchio Bell (ma c’è chi è anche più vecchio di lui, che parla e dice cose pesanti), e non resta che assistere, inebetiti come davanti a un miracolo, a questa anticipazione della disgregazione: personale e civile, sociale e morale. Si cammina sul filo di un rasoio: da una parte c’è il rischio del moralismo reazionario tipico degli Stati del sud, mentre dall’altra parte si rischia l’abisso della verità: si cade da questa parte, credo, si affonda in questo abisso. Il romanzo di McCarthy potrà anche sembrare un atto d’accusa alla modernità in genere, ma è uno specchietto per le allodole: si tratta in realtà di un attacco formidabile al sistema America, al suo sogno putrefatto, alla sua incapacità di radicarsi storicamente nella sua stessa vicenda, come dimostra l’apice poetico del libro, nelle pagine finali: uno scolatoio scalpellato in pietra due secoli prima, che, come scrive McCarthy, poteva durare diecimila anni: ma non durerà tanto.
Occhio raggelante che vede tutto, quello dello scrittore di Non è un paese per vecchi: vede la decadenza americana e la descrive, seppure con brachilogismi magistrali, secondo le metriche delle grandi epopee, quelle che noi europei consideriamo minori, vergate dagli antichi quando gli imperi crollavano. Questo romanzo non è un campanello che squilla: è già la campana a morto di un Paese che, allegorizzato a vent’anni dall’attuale situazione, entra nel ventre molle dell’attualità, e lo squarcia senza remore.
Cormac McCarthy – Non è un paese per vecchi – Einaudi – 17 euro



