di Gioacchino Toni
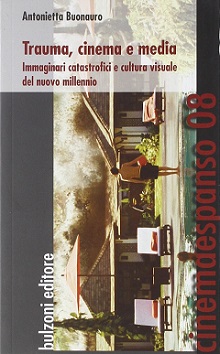 Nei primi anni Sessanta del Novecento, con la serie Death and Disaster, Andy Wharol testimonia come l’evento traumatico, sedia elettrica o incidente stradale che sia, grazie all’amplificazione mediatica si dimostri dotato di una capacità attrattiva non inferiore a quella delle icone pop dell’epoca, dunque, di poter conquistare anch’esso il rango di arte insieme a quello di merce. A riprova del forte legame esistente tra i media e i grandi traumi novecenteschi, basti pensare a come i primi non abbiano mancato di appropriarsi dei secondi amplificando e propagando il loro effetto scioccante incidendo così in maniera tutt’altro che irrilevante sulla costruzione dell’opinione pubblica. Non sarebbe forse del tutto azzardato affermare che il trauma, nel momento in cui su di esso agisce l’interesse mediale, finisca sovente per mettere in moto una potente macchina di costruzione di senso e consenso.
Nei primi anni Sessanta del Novecento, con la serie Death and Disaster, Andy Wharol testimonia come l’evento traumatico, sedia elettrica o incidente stradale che sia, grazie all’amplificazione mediatica si dimostri dotato di una capacità attrattiva non inferiore a quella delle icone pop dell’epoca, dunque, di poter conquistare anch’esso il rango di arte insieme a quello di merce. A riprova del forte legame esistente tra i media e i grandi traumi novecenteschi, basti pensare a come i primi non abbiano mancato di appropriarsi dei secondi amplificando e propagando il loro effetto scioccante incidendo così in maniera tutt’altro che irrilevante sulla costruzione dell’opinione pubblica. Non sarebbe forse del tutto azzardato affermare che il trauma, nel momento in cui su di esso agisce l’interesse mediale, finisca sovente per mettere in moto una potente macchina di costruzione di senso e consenso.
Lasciando momentaneamente da parte il ruolo dei media, si può dire che il rapporto tra trauma e soggettività/identità attraversi la cultura novecentesca, soprattutto a partire dagli studi di Freud sul trauma tanto in rapporto alla guerra quanto al ruolo da esso esercitato nelle culture, e di Benjamin relativamente agli aspetti traumatici della vita quotidiana nella metropoli moderna.
Su tali questioni si sofferma il volume di Antonietta Buonauro, Trauma, cinema e media. Immaginari catastrofici e cultura visuale del nuovo millennio (Bulzoni 2014). Qua l’autrice, dopo aver tratteggiato gli studi sul trauma nei primi approcci clinici e psicoanalitici, ricostruisce l’affermarsi in seno al pensiero post-strutturalista, decostruzionista e psicoanalitico dei Trauma Studies che, dopo una fase iniziale incentrata sul dramma della Shoah, estendono l’interesse al rapporto tra memoria e storia più in generale. Tali studi, soprattutto negli Stati Uniti nel corso della seconda metà del Novecento, si sono focalizzati sui traumi dei reduci di guerra e su quelli delle donne che hanno subito abusi sessuali durante l’infanzia in ambiente famigliare, focus quest’ultimo che ha contribuito ad evidenziare quanto il trauma risulti spesso sessuato.
Ad essere ricostruito da Buonauro è anche il rapporto storico e teorico novecentesco tra dinamiche traumatiche e mezzi audiovisivi, dunque tra trauma e visione così come è stato affrontato da Simmel e Benjamin e da interpretazioni più recenti. Successivamente l’autrice si sofferma su quella parte di produzione cinematografica contemporanea, anche hollywoodiana, «caratterizzata dall’adozione di dinamiche psichiche dissociative come modello per al costruzione delle strategie formali e narrative del testo filmico» (p. 17).
A ridosso del cambio di millennio, segnala Buonauro, diverse opere cinematografiche hanno adottato strategie narrative non convenzionali, tanto da sostituire la tradizionale linearità con modalità disomogenee contraddistinte da meccanismi diegetici illusori, falsi falshback, articolazioni labirintiche, ambigue, non plausibili, personaggi schizofrenici ecc., tutte comunque tendenti a mettere in crisi quel meccanismo di credenza spettatoriale proprio della narrazione classica. A tale nuova tendenza del cinema si è fatto riferimento con denominazioni differenti – forking-path film, mind-game film, puzzle-film… – a seconda che si volesse evidenziare la presenza di elementi ingannevoli sia a livello diegetico che spettatoriale, la complessità delle opere tendente a disorientare il pubblico costretto a rivedere le sue ipotesi interpretative più volte nel corso del film ecc.
Film come I soliti sospetti (1995) di Bryan Singer, Fight Club (1999) di David Fincher, Memento (2000) di Christopher Nolan, Il Sesto Senso (1999) di M. Night Shyamalan, The Others (2001) di Alejandro Amenábar sono ad esempio contraddistinti dalla presenza di protagonisti affetti da patologie mentali o da condizioni post-traumatiche che investono lo stesso impianto formale realativizzando le categorie di vero e di falso ed immergendo lo spettatore in una narrazione antilineare spesso destinata a rivelarsi/riscriversi soltanto nel finale. Altre produzioni hanno letteralmente giocato sulla percezione della realtà mettendo lo spettatore, sul finale del film, di fronte a opzioni differenti presentate tutte come plausibili: si pensi a Spider (2002) di David Cronenberg, Funny Games (1997) di Michael Haneke oppure Chunking Express (1994), In the Mood for Love (2000) e 2046 (2004) di Wong Kar-wai.
Nell’essere messa in discussione, oltre alla fiducia solitamente concessa al narratore, la possibilità del raggiungimento di una conoscenza oggettiva della realtà, lo spettatore è indotto ad una più generale riflessione circa il suo rapporto con i contesti mediatici e tecnologici avanzati ponendolo dunque direttamente a confronto con la capacità del cinema di “creare realtà”, di «cambiare lo statuto soggettivo di chi guarda, definendone l’immaginario attraverso la messa in scena di fantasie (psicoanalitiche) che indirizzano e organizzano il desiderio» (p. 109). Di fronte a quelle che possono essere dette vere e proprie “paranoie produttive”, lo spettatore può mette in atto una modalità di organizzazione gli eventi che emula «le dinamiche dissociative dei processi traumatici o patologici intendendoli come versioni amplificate (in quanto patologiche) del rapporto tra soggetto e mondo contemporaneo» (p. 110).
Nel volume trova spazio anche una riflessione sul rapporto tra determinati parametri estetici cine-fotografici e delle arti visive in genere con la rappresentazione dell’11 settembre, «evento che in una certa misura ha inaugurato la tendenza odierna alla spettacolarizzazione e alla cosiddetta “premediazione” degli scenari catastrofici» (p. 17). Esaminando la celebre fotografia del falling man di Richard Drew, l’autrice pone
in relazione i tratti caratterizzanti dell’estetica traumatica con le identificazioni della soggettività contemporanea nella forma performativa descritta da Judith Butler, per poi affrontare da un lato, il concetto di trauma vicario spettatoriale proposto da E. Ann Kaplan e dall’altro, quello di “sfera pubblica patologica” generata dalla “fantasia catastrofica” tipica della produzione culturale americana recente (pp. 17-18).
La parte finale del libro è invece dedicata al trauma collettivo degli tsunami del 2004 in Thailandia e del 2011 in Giappone che, per il loro trattamento mediatico, sottolinea l’autrice, confermano l’importanza della raffigurazione del trauma nella cultura visuale contemporanea.
Attraverso la veicolazione di user generated content, la diffusione di disaster film e di documentari su questi eventi, la spettacolarità contemporanea sembra infatti accedere al piacere della visione ravvicinata di immagini recrudescenti, un avvicinamento che da un lato implica una significativa modificazione del confine tra la norma culturale e l’abiezione (così come era stata descritta da Julia Kristeva), e dall’altro, mettendo in discussione immaginari legati alla capacità di controllo delle tecnologie avanzate su contesti ambientali, solleva riflessioni su tempi attuali e controversi come il rapporto tra identità e alterità e tra globale e locale (p. 18).



