di Gioacchino Toni
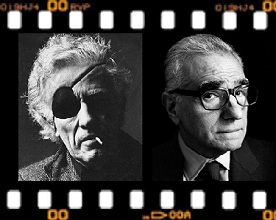 Nello scritto precedente [su Carmilla] ci siamo soffermati sulla narrazione audiovisiva all’americana compresa tra il muto e la fase classica del cinema hollywoodiano esposta da Federico di Chio nella prima parte del suo American storytelling. Le forme del racconto nel cinema e nelle serie tv (Carocci editore, 2016), in questo secondo intervento, integrandola con altri scritti, passeremo in rassegna quanto propone la seconda parte del saggio relativamente al periodo che va dall’avvento della televisione all’età della convergenza digitale.
Nello scritto precedente [su Carmilla] ci siamo soffermati sulla narrazione audiovisiva all’americana compresa tra il muto e la fase classica del cinema hollywoodiano esposta da Federico di Chio nella prima parte del suo American storytelling. Le forme del racconto nel cinema e nelle serie tv (Carocci editore, 2016), in questo secondo intervento, integrandola con altri scritti, passeremo in rassegna quanto propone la seconda parte del saggio relativamente al periodo che va dall’avvento della televisione all’età della convergenza digitale.
Nell’affrontare la postclassicità degli audiovisivi statunitensi, Federico di Chio segnala come essa sia caratterizzata, tra le altre cose, dalla progressiva diffusione della televisione, che a metà anni Cinquanta è presente già nella metà delle case americane, e da una regolamentazione che, rompendo il modello industriale dei decenni precedenti – basato sul monopolio degli Studios nella produzione, distribuzione e proprietà delle sale -, penalizza la distribuzione delle opere minori. Il nuovo assetto hollywoodiano comporta una maggiore attenzione verso il mercato internazionale ed un decentramento produttivo finalizzato all’abbattimento dei costi, oltre che all’aggiramento dei vincoli protezionistici introdotti da diversi paesi stranieri.
A partire dalla metà degli anni Cinquanta il western e la produzione di grandi opere per il cinema affiancano la realizzazione di numerosi telefilm per la televisione. In generale i nuovi eroi tendono ad essere non più giovanissimi, spesso si mostrano acciaccati, indeboliti e costretti a destreggiarsi senza l’aiuto della collettività. «Per questi eroi la frontiera non è più il limite da oltrepassare, l’orizzonte della possibilità, ma la fine del percorso, il luogo in cui finalmente fare i conti con se stessi e con quei valori (autodeterminazione, fiducia in se stessi, senso dell’onore) celebrati, sì, dalla tradizione e che però, se assolutizzati, si rivelano fattori di isolamento, di autodistruzione e persino di disumanità» (p. 88). L’ambientazione stessa si rivela ostile e tale ripiegamento tende a trasformarsi in un’insistita teatralità dei dialoghi in cui sono più le relazioni ad interessare che non le azioni.
Numerose sono le pellicole belliche realizzate nel periodo compreso tra la guerra di Corea e quella del Vietnam ed anche in questo caso, diversamente rispetto al passato, si assiste ad una maggiore introspezione: la guerra viene mostrata più per la sua durezza che non per la sua spettacolarità.
In American storytelling si sottolinea come siano diversi i generi che risentono del clima della guerra fredda e della paranoia anticomunista. La figura del detective borderline tende a lasciare il posto a quella dell’uomo delle istituzioni integerrimo ed un certo spazio viene dedicato all’americano qualunque che si trova improvvisamente coinvolto, suo malgrado, in situazioni pericolose. Non mancano pellicole che mostrano il crimine dal punto di vista dei malviventi. Ad inizio degli anni Sessanta il crime si sviluppa lungo due direzioni; se al cinema si mettono in scena situazioni cupe e violente, nelle produzioni televisive si seguono maggiormente i canoni consolidati. Nei telefilm polizieschi, ad esempio, trionfano uomini delle istituzioni senza macchia e senza peccato.
Tale periodo è caratterizzato dal trionfo del macro genere del drama che ricorre spesso ad autori teatrali e letterari. «Le commedie degli anni Cinquanta sono forse lo specchio più evidente del clima culturale americano dell’epoca: risultano, in generale, prive di mordente, opache, prevedibili, per quanto visivamente sofisticate» (p. 92).
La fantascienza degli anni Cinquanta è invece fortemente permeata dalle avventure spaziali, dalla paranoia atomica e dal clima della guerra fredda che vede minacce comuniste ovunque. A tal proposito si rimanda al saggio di Roberto Giacomelli, Nemici dell’America, nemici dell’umanità. Il “nemico” nel cinema fantascientifico americano (Sovera Edizioni, 2014) su cui ci siamo lungamente soffermati in passato [su Carmilla].
Nel corso degli anni Sessanta se la commedia al cinema , dopo un avvio sofisticato, intraprende una direzione decisamente movimentata, in linea con le turbolenze del periodo, la produzione televisione pare decisamente più convenzionale. In un clima fortemente condizionato dal perbenismo e dal pericolo dell’infiltrazione comunista, in generale «il malessere psicologico e relazionale dei personaggi […] viene circoscritto alla sfera privata e, dunque, isolato dal contesto sociale, economico e politico. Individualizzando e patologizzando il disagio, gli autori si [mettono] al riparo dall’accusa di ritrarre una società malata. Una prudenza di ordine politico che peraltro si [aggiunge] a quella convinzione tipica della mentalità americana […] per cui le ragioni della debolezza o della devianza di un uomo sono da ricondurre alla sua indole e non a contesto sociale in cui vive» (p. 94).
Di Chio si sottolinea come la famiglia resti uno dei temi più trattati durante questo periodo, soprattutto attraverso la sua celebrazione, ma non mancano opere capaci di mostrarne la crisi. Anche la donna viene trattata come soggetto problematico e se al cinema viene mostrata alla faticosa ricerca di un equilibrio tra realizzazione professionale ed impegni domestici, le produzioni televisive tendono invece ad accontentarsi di modelli molto più rassicuranti per il pubblico maschile. «Le donne pericolose degli anni Quaranta lo erano perché irretivano l’uomo: lo manipolavano (per sbarazzarsi del marito, arricchirsi ecc.), ma ne avevano bisogno; quelle degli anni Cinquanta, invece, sono pericolose perché sanno farne a meno!» (p. 96).
Una delle maggiori novità del periodo riguarda la figura del “giovane sensibile e tormentato” che si presenta sullo schermo assai distante dagli stereotipi della middle class masculinity. In alcune pellicole ad essere messo in scena è un giovane riflessivo, sensibile, insicuro e magari ribelle ma quasi sempre lontano dai risvolti politici e sociali; si tratta di un ragazzo che non vuole scappare dal mondo o cambiarlo ma solo farne parte a pieno titolo.
Secondo lo studioso nodi centrali della produzione postclassica sono il difficile rapporto tra individuo e comunità e la degradazione dell’eroe. Nel primo caso i film esplicitano le difficoltà del rapporto ricorrendo spesso al topoi narrativo dell’arrivo del forestiero o del ritorno a casa di un membro della comunità dopo una prolungata assenza; questa figura altra contribuisce a rompere gli equilibri di facciata ed a far emergere il rimosso. Nel caso della degradazione dell’eroe nel saggio si insiste sulla sua ambiguità e sul suo isolamento dalla comunità, tanto che questa figura finisce col perdere quella gradevolezza necessaria all’immedesimazione da parte dello spettatore.
Nell’era postclassica più che al cinema le figure forti ed affascinanti di official hero in cui identificarsi le si ritrovano nelle produzioni televisive. Anche la figura dell’outlaw degrada la sua posizione e mentre al cinema diventa sempre più simile al villain, in televisione conserva tutto sommato il suo vecchio statuto.
Nella seconda metà degli anni Sessanta gli Stati Uniti sono scossi da una serie di spinte sociali, politiche e culturali che mettono in discussione nelle fondamenta il modello americano palesando contraddizioni sino a questo momento celate e taciute. Anche l’industria cinematografica è costretta a fare i conti con il nuovo clima che attraversa la società e lo fa avviando una ristrutturazione degli Studios da qualche tempo in preda ad una crisi economica e d’identità. Nel frattempo anche il Codice Hays, riformulato una prima volta nel 1956 ed una seconda nel 1966, finalmente, nel 1968, viene accantonato e sostituito da un sistema di mera “indicazione di visione” (es. “G” General, per tutti, “X” vietato ai minori ecc.). Tale sistema, gestito dalla CARA – Code And Rating Administration, permette sostanzialmente al cinema di rappresentare esplicitamente (quasi) qualsiasi tematica e situazione. A cambiare, però, a partire dalla fine degli anni Sessanta, è soprattutto il pubblico: nelle sale cinematografiche il calo della presenza di famiglie e componente femminile, tendenzialmente assorbite dalla televisione, lascia il campo ad un segmento maschile, giovane e scolarizzato di middle class.
Se da un lato, sul finire degli anni Sessanta, Hollywood dedica numerose produzioni low budget al pubblico giovanile (i figli del baby boom) concentrandosi su tematiche controverse legate al sesso ed alla violenza, dall’altro continua a produrre opere ad alto budget decisamente più convenzionali. A tal proposito nel saggio si ricorda come negli Oscar del 1969 vengano premiati contemporaneamente due cowboy molto diversi: la statuetta al miglior film viene assegnata a Midnight Cowboy (Un uomo da marciapiede, 1969 di John Schlesinger), mentre il riconoscimento al miglior attore tocca a John Wayne per il film True Grit (Il “Grinta”, 1969 di Henry Hathaway).
I film maggiormente impostati su posizioni anticonformiste sono centrati «più sui personaggi che sul plot, con un andamento narrativo lasco e rapsodico ben oltre i canoni della forma debole del racconto […] dominati da antieroi irregolari, gravati dal senso del limite, che manifestano un’attitudine critica, spesso anche apertamente ostile, verso le agenzie istituzionali (la famiglia, la politica, l’esercito, la polizia, la religione) e verso l’autorità in genere» (p. 109). In alternativa, sull’altro versante, si trovano spesso personaggi attivi e risoluti, come militari fanatici e poliziotti ossessionati dalla persecuzione del crimine, che popolano narrazioni dallo sviluppo lineare.
Di Chio sottolinea anche come non manchino nemmeno pellicole di incerta classificazione in cui si trovano giustizieri che non agiscono secondo la tradizionale visione «reazionaria e machista, bensì per disperazione e paranoia […] e per necessità, tradendo un’angoscia e una sensibilità che ne fanno eroi di segno decisamente diverso. In tutti i casi, la produzione della New Hollywood è caratterizzata da un’amarezza e da una cupezza decisamente evidenti. «La cupezza di questi film si deve al dilagare di scene di violenza, lunghe e disturbanti. Molto spesso si tratta di una concessione facile ai gusti del pubblico più giovanile e maschile, resa possibile dall’abbandono dell’eufemismo tematico e visivo imposto dal Codice. Ma in taluni casi […] la rappresentazione rivela un consapevole approccio “controculturale”: quell’elemento così controverso e tuttavia costitutivo della storia de del carattere degli americani, che la narrazione mitica aveva sublimato e a volte addirittura rimosso, viene ora esibito in modo talmente insistito e iperbolico da rivelare al sua vera natura e la sua autentica funzione storica. Il processo si riscrittura operato dal mito viene in questo modo smascherato» (pp. 110-111).
Di Chio si sofferma anche su come il genere horror moderno offra una rappresentazione del tutto nuova del male e di come la minaccia si sviluppi in seno all’umanità stessa. Da parte nostra abbiamo approfondito in un precedente scritto [su Carmilla] il tema dell’essere umano nemico di se stesso in ambito fantascientifico. Una profonda revisione tocca un po’ tutti i generi: dal noir al musical, dal crime al western che si avvia, tra fine anni Sessanta e primi anni Settanta, ai suoi ultimi colpi di coda alternando opere convenzionali ad opere manierizzate presentando anche interessanti riletture del mito della frontiera.
Trasversale a diversi generi, la figure dell’eroe, sia outlaw che official, tende a dissolversi. Secondo lo studioso nel caso dell’outlaw si perdono alcune sue caratteristiche fondamentali come l’asocialità e la performatività; si tratta ora di un personaggio fragile e sbandato che non riesce più a cavarsela da solo e ciò lo rende sempre più simile alla figura del villain. Nel caso dell’official, ad esempio nel poliziotto, si perdono la disciplina istituzionale ed il legame sociale tanto che diviene sempre più solitario. Nel saggio viene fatto notare come outlaw ed official non si incontrino quasi più nelle storie: o abbiamo uno o l’altro. Al posto di queste due tipologie tradizionali di eroe sembra sempre più prendere piede la figura dell’antieroe privo di una visione del mondo e di riferimenti valoriali forti. Tutto ciò, però, sottolinea lo studioso, non avviene in televisione; in questo caso ci si tiene decisamente alla larga dagli antieroi tragici e distruttivi.
In American storytelling si pone l’accento su come il cinema della New Hollywood risulti contraddistinto dal pressoché totale predominio di personaggi maschili ed in parte ciò è dovuto alla crisi in cui versa la figura maschile ormai incapace di raccapezzarsi nella nuova società. Qualche persistenza di eroe forte la si ritrova ancora, ad esempio, nei film poliziesco-giustizialisti, negli spy-thriller e, soprattutto, nei disaster movie ove, non di rado, si ritrova un personaggio maschile maturo che, a costo di fuoriuscire dalle norme comportamentali istituzionali, funge da leader di un piccolo gruppo che si trova a dover fronteggiare una situazione estrema. «Come nel dopoguerra, ma in modo ancora più evidente, la messa in scena della debolezza del maschio (l’antieroe), così come la riaffermazione fin troppo esibita della sua forza (i nuovi eroi d’azione, tutti d’un pezzo e politically incorrect) hanno a che fare con la crisi della maschilità e del modello patriarcale della società che in questi anni, a valle della rivoluzione femminista, emerge in modo davvero esplosivo» (p. 117).
Tra le novità introdotte dalla produzione della New Hollywood nel saggio vengono indicati il ricambio generazionale degli attori, l’uso di una fotografia decisamente contrastata e desaturata con effetti realistici, il ricorso a focali in grado di cogliere dettagli tanto ravvicinati che in lontananza o di allargare a dismisura i confini del visibile.
Alla New Hollywood succede quella che è stata definita l’età della restaurazione o del ritorno all’ordine anche se, a dire il vero, le cose risultano decisamente più complesse e variegate. È comunque sicuramente vero che sul finire degli anni Settanta l’immaginario americano cominci a distanziarsi da quel clima caratteristico della New Hollywood in cui si intersecano critica, sfiducia e pessimismo. Sul finire del decennio nei diversi generi riemerge la volontà di riproporre la forza dei miti non di rado viene messo in scena il riscatto di protagonisti del ceto medio-basso che ritrovano un sogno per cui vale la pena fare sacrifici. Sembra dunque far capolino nuovamente l’American dream smarrito.
Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta del secolo scorso viene abbandonata la strategia classica di distribuzione che tendeva a centellinare il numero di pellicole distribuite per allungare il più possibile il tempo di permanenza dei film nelle sale. Ora la strategia diventa quella della saturazione: vengono distribuite contemporaneamente molte copie, supportate da un lancio pubblicitario ragguardevole, cercando di incassare tutto l’incassabile nel minor tempo possibile. Ciò contribuisce alla sempre più marcata tendenza hollywoodiana di concentrare enormi investimenti su di un numero ridotto di pellicole, tendenza che poi, nel corso degli anni Ottanta, si relaziona con la possibilità di sfruttare i grandi titoli anche nei circuiti delle pay tv. Il pubblico di questi blockbuster votati alla spettacolarità è quello delle famiglie anche se una fetta importante di produzioni mira ad un pubblico maschile per il quale vengono realizzati prodotti privilegianti scene violente.
Esauritosi il western, secondo l’autore, è per certi versi la fantascienza a raccogliere il testimone del mito della frontiera tanto caro al pubblico americano. Una parte importante della produzione a cavallo tra gli anni Settanta ed Ottanta spetta alle commedie demenziali giovanili, anche se spesso costrette ad ambientazioni retrodatate per potervi collocare condotte sguaiate ed anticonformiste altrimenti difficilmente ambientabili nell’edonismo dell’epoca del rappel à l’ordre. Inoltre, dalla metà degli anni Ottanta la paura dell’AIDS non consente ai film di trattare la sessualità giovanile in maniera scanzonata. «Se il melodramma giovanile degli anni Cinquanta-Sessanta e l’horror degli anni Sessanta-Settanta […] avevano radici nella repressione causata dalla struttura rigida, patriarcale o matriarcale, della famiglia, i teen drama e i teen horror di questi anni ci raccontano che i ragazzi, una volta liberati dalle autorità oppressive, iniziano ad aver paura di loro stessi, delle proprie emozioni e persino dei propri sogni!» (p. 123).
Nel clima che attraversa i decenni Ottanta e Novanta è evidente il disimpegno politico ed il ripiegamento nel privato, tanto che della critica espressa dai due decenni precedenti resta ora soltanto il disincanto che facilmente si trasforma in cinico opportunismo ed è per certi versi da quest’ultimo che riemerge, con non poche contraddizioni, l’American dream.
Nel cinema più commerciale, di pari passo all’accantonamento dell’impegno e della critica sociale e politica, tende a far capolino un certo ottimismo in cui spiccano eroi d’azione inclini a sfidare i pericoli più incredibili uscendone indenni. Da un certo punto di vista rientrano in questo profilo anche diversi supereroi e personaggi delle serie poliziesche televisive. Grazie a tali eroi viene «nuovamente celebrata la maschilità performante attraverso l’esibizione di “hard bodies” […], forti e violenti: un’evidente riscossa nei confronti dell’antieroismo e del femminismo critico del periodo precedente» (p. 125).
Insieme al ritorno dell’eroe maschile sotto tali sembianze, sottolinea Federico di Chio, ricompare con forza l’affermazione dell’ordine patriarcale, mentre la donna autonoma ed indipendente, comunque già poco presente nelle produzioni della New Hollywood, ora diviene una moglie egoista, una madre scostante ed un pericolo per l’uomo. Soltanto nei primi anni Novanta, secondo lo studioso, si ha un’attenuazione del riflusso patriarcale con il conseguente ritorno sugli schermi di figure femminili meno stereotipate. Nel saggio viene riportata anche l’interessante tesi dello studioso Fred Pfeil (“From Pillar to Postmodernism” in Jon Lewis , ed., The New American Cinema, 1998) che tende a ricollegare «la restaurazione patriarcale, il rilancio dell’individualismo capitalistico e il ritorno della narrazione “forte” degli anni Ottanta» (p. 126).
Da parte nostra abbiamo affrontato il clima di nostalgia e di bisogno di normalità trasmesso dal cinema americano degli anni Novanta nello scritto “A Family Affair” (2004) [su Carmilla] mostrando come in molte opere si palesi la crisi della vecchia istituzione famigliare ed una visione nostalgica per un’epoca idilliaca che sembra essersi eclissata. In diverse pellicole dell’epoca il riscatto della nazione, gravemente ammalata, sembra potersi dare solo attraverso la riconquista, da parte maschile, di quello smarrito senso di responsabilità nei confronti della sua cellula base: la famiglia. In sostanza il ristabilimento del sistema patriarcale viene presentato come condizione necessaria al riscatto dell’intera nazione.
In “A Family Affair” abbiamo evidenziato come in diverse opere l’incapacità, non solo da parte maschile, di far fronte ai problemi che investono la famiglia, conduca i protagonisti a veri e propri deragliamenti mentali e comportamentali. Ad accomunare molti film è il desiderio provato dai protagonisti di riottenere quella normalità americana andata perduta certo anche a causa loro, ma, più spesso, per colpa di una società che, inspiegabilmente, sembrerebbe aver perso la bussola. È un’America malata quella messa in scena, con personaggi che manifestano i sintomi della malattia: l’incapacità di costruirsi una normalità, di praticare quei valori tramandati da generazioni a cui si credeva e si vuol continuare a credere. I protagonisti percepiscono non solo la propria incapacità nel raggiungere tali obbiettivi ma anche di trovarsi di fronte una società ostile, pronta a rinfacciare loro i fallimenti.
Sempre in “A Family Affair” abbiamo visto come non manchino film in cui la perdita di identità di un membro della famiglia sembra derivare dal successo professionale quando al suo conseguimento corrisponde la perdita dei vecchi valori sui quali si fondava il rapporto di coppia.
Di Chio sottolinea giustamente come la serializzazione di alcuni film d’azione o d’avventura finisca con il minare la narrazione forte: al fine di giustificare nuovi capitoli, al protagonista è negata la risoluzione definitiva della minaccia che affligge il mondo. In tali film l’eroe risolve la minaccia immediata ma «non riesce a operare una piena trasformazione di sé e della realtà in cui vive. Ed è questa la grande differenza con il regime classico» (p. 126). A tale incapacità risolutiva che tocca tanto il cinema, quanto le produzioni televisive, facilmente seriali, si supplisce spesso con eccessi autoreferenziali poco utili all’evoluzione narrativa e/o con un’accentuazione dell’aspetto ludico.
Naturalmente, a fianco di una produzione hollywoodiana orientata all’ottimismo superficiale, esiste anche una proposta più amara e riflessiva. Non mancano infatti opere votate a smascherare le ipocrisie e i miti riproposti. Nel saggio sono elencati diversi film che denunciano la politica istituzionale ed il mito yuppie, che sottolineano la fine dell’innocenza americana e palesano le difficoltà di convivenza tra le diverse etnie e tra i diversi orientamenti sessuali. Occorre sottolineare che a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta finalmente anche la televisione propone situazioni problematiche, tanto da giungere a mettere in scena rappresentazioni della famiglia meno stereotipate e più critiche.
Nel corso degli anni Ottanta diverse opere cinematografiche danno immagine ad una problematica che inizia a diffondersi nell’immaginario collettivo occidentale: la mutazione. Come abbiamo sostenuto nello scritto “Immagini e trasformazioni postindustriali americane” (2004) [prima parte e seconda parte, su Carmilla] tale tematica non può essere ricondotta al solo New Horror del decennio; la sensazione di perdere la propria identità è una problematica diffusa che ha a che fare con la paura o, in misura minore, con la speranza della mutazione. L’idea stessa di mutazione sembra svilupparsi in reazione alla perdita dell’identità e se il più delle volte l’individuo tenta di resistere alla mutazione, in altri casi ne palesa la necessità.
Sempre in “Immagini e trasformazioni postindustriali americane” abbiamo visto come il cinema degli anni Ottanta e Novanta metta in scena diverse forme di crisi di identità e diverse forme di mutazione: crisi della middle class, classe cinematografica per eccellenza, in preda all’amaro risveglio post-reaganiano (crollo del tenore di vita e del sogno americano), crisi dell’identità di genere tradizionale (amplificata dall’incapacità maschile di comprendere il mutato ruolo sociale), dunque crisi della famiglia e con essa dell’idea di nazione ma anche crisi dell’individuo nei confronti delle nuove tecnologie di comunicazione e dei relativi modelli di percezione delle realtà.
 Nei film di questo ventennio il senso di crisi che ha investito la società americana è rappresentato a volte come crisi temporanea di un modello fondamentalmente sano, altre come crisi definitiva che ha finito per colpire anche l’unico sistema sopravvissuto alla guerra fredda. A tal proposito nella nostra analisi abbiamo indicato due filoni di opere, dai confini non sempre marcati: uno votato alla nostalgia per un passato felice andato perduto, ed uno decisamente più apocalittico.
Nei film di questo ventennio il senso di crisi che ha investito la società americana è rappresentato a volte come crisi temporanea di un modello fondamentalmente sano, altre come crisi definitiva che ha finito per colpire anche l’unico sistema sopravvissuto alla guerra fredda. A tal proposito nella nostra analisi abbiamo indicato due filoni di opere, dai confini non sempre marcati: uno votato alla nostalgia per un passato felice andato perduto, ed uno decisamente più apocalittico.
Spesso nelle produzioni hollywoodiane tanto le visioni progressiste quanto quelle reazionarie tendono ad individuare le cause della deriva non nelle fondamenta stesse del modello americano, ma nelle deviazioni dalla retta via che esso ha subito. Se la visione più reazionaria tende a leggere la disgregazione come conseguenza di ciò che ha prodotto l’epoca della contestazione (a cui vengono sostanzialmente imputate la sconfitta militare in Vietnam, la distruzione della famiglia come nucleo-base della società, il dilagare dei problemi razziali, il disordine sessuale ecc.), la visione più progressista proposta dal cinema sembra voler ricercare le colpe in quella politica economica ultraliberista che, al potere, ha prodotto il cinismo individualista di uomini d’affari senza scrupoli che ha distrutto quanto generazioni e generazioni di veri americani hanno pazientemente costruito. In entrambe le letture il male non sembra tanto essere endemico al modello quanto piuttosto derivato dal suo tradimento.
L’idea di vecchia-America socialmente unita e solidale, che sugli schermi sembra propria tanto della visione conservatrice quanto progressista, tende a vedere nei mali dell’America contemporanea il crollo di tutti i suoi valori a causa di chi ha operato smarrendo l’American way. La soluzione, in entrambi gli approcci, parrebbe essere nel ristabilimento dell’ordine e della morale di un tempo, dunque in molte pellicole si procede secondo una narrazione volta alla redenzione.
Molti film mettono in scena personaggi cresciuti con sani valori che, improvvisamente, ed inspiegabilmente, si trovano magari a maneggiare tastiere di computer pericolose come i comandi delle testate nucleari, in grado di distruggere l’intero sistema costruito da generazioni di americani che ora si sentono traditi da quegli stessi figli che hanno messo al mondo. Può il mito americano aver allevato un mostro? É possibile porvi rimedio e redimerlo dall’interno? O siamo di fronte ad un mostro che soltanto oggi inizia a mostrare anche alla middle class quanto milioni e milioni di individui di ceto sociale più basso, all’interno ed all’esterno del paese, conoscono già da diverso tempo? Sulla sostanziale coincidenza tra tante visioni progressiste e quelle più apertamente reazionarie ha impietosamente insistito Sandro Moiso in diversi suoi scritti utili a comprendere l’attualità statunitense. Si veda, ad esempio, “Hard working men: alle radici del fascismo di Trump (e non solo)” (2017) [su Carmilla].
Se c’è una cosa che i colletti bianchi, nel corso degli anni Ottanta, hanno finito per comprendere, al di là della retorica mediatica a cui hanno voluto prestar fede fino a quando non ne sono stati coinvolti direttamente, è il vero significato del termine ristrutturazione: peggioramento delle condizioni e dei rapporti di lavoro, se non il licenziamento vero e proprio. E quell’America cresciuta con il mito del consumo illimitato senza pensare che si sarebbe potuto perdere il lavoro e con esso tutto il resto, quell’America che ha contribuito a costruire e difendere il Paese, improvvisamente si sente abbandona a se stessa.
Anche in American storytrelling viene concesso spazio al problema dell’ibridazione corpo/macchina segnalando come diverse pellicole affrontino «la dissoluzione, lo slittamento, l’incertezza dell’identità personale e la labilità della soglia tra umano e non umano, nelle due opposte forme dell’umanizzazione del non umano, con il proliferare di cloni, droidi, robot; e della disumanizzazione dell’umano, insistendo sulla virtualizzazione delle esperienze» (p. 128). Da parte nostra abbiamo affrontato l’immaginario attorno al quale ruotano tali tipi di opere nello scritto “Il postumano tra soggettivazione emancipatoria e nuove forme di dominio” (2016) [su Carmilla].
L’insistenza sul corpo umano di molti film si lega inevitabilmente alla riflessione sull’identità americana che «si è costruita storicamente sull’esistenza di un nemico esterno, dai pellerossa ai comunisti, dai nazisti ai viet-cong» (p. 129). Dal momento che viene a mancare una minaccia esterna sentita come realmente tale, l’individuo americano tende a rivolgersi verso di sé: «al corpo che non ci risponde più, alla mente che ci tradisce o che si sdoppia, alla fantasia che ci minaccia. Nell’era dell’individualismo senza antagonisti, insomma, il nemico sono io. Non a caso, altro grande tema ricorrente è l’indistinzione di realtà e immaginazione» (p. 129).
Se dal punto di vista contenutistico la produzione hollywoodiana degli anni Ottanta è certamente contraddistinta da un evidente rappel à l’ordre, pur essendo più variegata di quel che appare ad un primo sguardo, dal punto di vista produttivo il nuovo decennio porta invece una vera e propria rivoluzione tecnologica, con le sue inevitabili ripercussioni produttive e distributive: si apre l’era digitale e con essa l’età della convergenza. In altri termini l’innovazione digitale e la rimozione di vecchi vincoli normativi permettono forme convergenti tra Studios, Broadcaster televisivi, DVD, tv multi-channel ed internet che non mancano di avere importanti ricadute anche sull’immaginario collettivo. Qua si apre davvero una nuova fase tutta da approfondire.






