di Gioacchino Toni
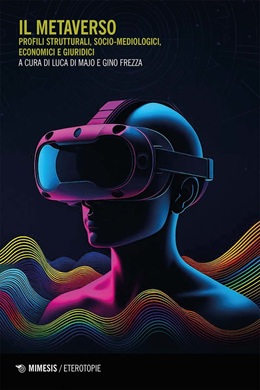 Luca Di Majo, Gino Frezza, a cura di, Il Metaverso. Profili strutturali, socio-mediologici, economici e giuridici, Mimesis, Milano-Udine, 2025, pp. 472, € 36.00
Luca Di Majo, Gino Frezza, a cura di, Il Metaverso. Profili strutturali, socio-mediologici, economici e giuridici, Mimesis, Milano-Udine, 2025, pp. 472, € 36.00
Avvalendosi di una serie di contributi di ingegneri informatici, sociologi, mediologi, economisti e giuristi, il volume Il Metaverso (Mimesis, 2025), curato da Luca Di Majo e Gino Frezza, dopo un primo gruppo di scritti utili a introdurre agli ambienti tecno-relazionali dei mondi paralleli delineandone la struttura e il funzionamento, presenta una serie di approfondimenti degli aspetti culturali, sociali e di consumo del Metaverso per poi, nella parte finale, affrontarne gli aspetti legali ed economici, evidenziando come il diritto fatichi a tenere il passo del progresso tecnologico e il rischio che si vengano a creare inedite forme di sovranità compromettenti i diritti fondamentali degli esseri umani.
In apertura del suo contributo, Massimiliano Rak introduce il Metaverso, gli avatar che in/con esso si relazionano e la Realtà Estesa, intesa come soluzione tecnologica per la percezione di tale ambiente tecno-relazionale, in questo modo:
Il Metaverso in quanto Mondo Virtuale è caratterizzato da un ecosistema autosufficiente, all’interno del quale è possibile interagire, con altri partecipanti o con gli oggetti digitali del mondo stesso, secondo regole sue proprie e con regole di interazione che sono limitate solo dalle caratteristiche del mondo virtuale stesso. Gli avatar sono l’altra faccia della medaglia del mondo virtuale: sono il modo in cui l’individuo si pone nel Metaverso e nella ricostruita realtà. La forma con la quale interagisce con gli altri e il modo in cui gli altri percepiscono chi a quel mondo partecipa. La Realtà Estesa infine è la soluzione tecnologica per la percezione del Metaverso stesso: l’utilizzo di strumenti che ampliano (potenziano? Alterano?) i sensi per permettere l’interazione nel mondo virtuale e immergere il partecipante nel mondo virtuale e impersonare il suo avatar, ad oggi la parte meno diffusa e consolidata nella gestione dei Metaversi, a causa della immaturità e il costo delle tecnologie coinvolte (p. 19).
L’idea di mondo virtuale, come spazio simulato, retto da regole proprie e abitato da entità che interagiscono secondo dinamiche locali producendo comportamenti, precede quella di Metaverso. Rak riporta esempi pionieristici ancora privi di interattività con esseri umani a cui hanno fatto seguito, in ambito ludico, i Role Playing Games (RPG) e, successivamente, i Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) che hanno trovato diffusione nel nuovo millennio. Tra gli esempi più conosciuti di game che si espandono in vere e proprie piattaforme creative e sociali associabili al concetto di Metaverso, Rak indica Minecraft (dal 2009), sandbox che consente ai gamer di intervenire creativamente sullo spazio virtuale creando regole e narrazioni e di agire sulle meccaniche di gioco, mentre tra i precursori veri e propri del concetto di Metaverso l’autore indica Second Life (dal 2003), Roblox (2006), Spatial (dal 2017), Cryptovoxels (2018), Horizon Worlds (dal 2019) e Decentraland (dal 2020).
Rak si sofferma sull’impiego in ambito non ludico dei diversi tipi di Metaverso facendo riferimento al ricorso a mondi virtuali come strumenti utili per valutazioni economiche e sociali, al loro utilizzo per simulare politiche, modelli di business e dinamiche sociali con modalità interattive: dall’introduzione di un’economia virtuale in Second Life all’uso degli spazi virtuali da parte di multinazionali come J.P. Morgan, dall’ambito didattico (es. Educa360 e Virbela) a quello sanitario, come nel caso delle cliniche virtuali di supporto da remoto ai pazienti (es. XRHealth e Thumbay Group), dalla formazione professionale alla prototipazione industriale e alla collaborazione remota. Al di là del tecnoentusiasmo dispensato da chi guarda al Metaverso soprattutto dal punto di vista del business e delle possibilità di esercitare controllo, resta difficile, sostiene Rak, prevedere l’impatto sulla società che avranno le tecnologie di realtà virtuale indirizzate «a fondere completamente i mondi virtuali (non più immaginari, ma virtuali) con la realtà fisica (la cosiddetta realtà estesa)» (p. 33).
Nel suo intervento, Leo Sorge definisce il Metaverso come «una collezione di mondi digitali diversi, con rappresentazione tridimensionale sul piano o nello spazio, che seguono le stesse regole», mondi che simulano caratteristiche spaziali e sensoriali del corpo umano e delle modalità con cui quest’ultimo percepisce il mondo. Sorge si sofferma sul Metaverso industriale privo della componete umanizzata, il Digital Twin (gemello digitale), utile per «riprodurre digitalmente il funzionamento di tutte le componenti di determinate attività quali magazzini, fabbriche, città […], eventualmente parti del corpo umano e via via scalando fino al mondo intero» (p. 38). A farne ricorso sono colossi come Siemens, General Electric, Dassault Systèmes, Nvidia e Microsoft. Il Digital Twin consente non solo di verificare il funzionamento dell’insieme nel tempo ma anche di prevedere improvvisi cambiamenti.
Nonostante l’importanza assunta dal Metaverso nel discorso pubblico contemporaneo, nota Christiano Presutti, la sua definizione rimane sfuggente e in continua trasformazione, dipendente com’è dall’evoluzione tecnologica, dalla mutevolezza delle pratiche sociali e, ovviamente, dal mutare delle interpretazioni teoriche che ne ridefiniscono i confini. Per quanto alcuni studiosi e sviluppatori lo descrivano come «un ambiente digitale persistente e immersivo, in cui gli utenti interagiscono attraverso avatar e oggetti virtuali», è evidente, continua Presutti, che, lungi dall’essere un’entità monolitica, il Metaverso è piuttosto «un insieme di spazi virtuali eterogenei, che si evolvono attraverso tecnologie, architetture e standard differenti» (p. 62). Nonostante il tentativo di creare una condizione immersiva attraverso il coinvolgimento sensoriale abbia una lunga storia, è soltanto sul finire del Novecento che, con la rivoluzione telematica e con il diffondersi della cultura cyberpunk nel discorso pubblico, secondo Presutti, si può parlare propriamente di Metaverso a prescindere dall’appropriazione del termine da parte di Mark Zuckerberg nel 2021.
Per quanto, come detto, ogni definizione non possa che essere provvisoria, per fornire un quadro concettuale utile all’analisi tecnologica, a oggi, il Metaverso potrebbe essere definito come «un ecosistema digitale persistente e interoperabile, composto da spazi virtuali interconnessi, in cui gli utenti interagiscono attraverso avatar e oggetti digitali, sfruttando tecnologie di realtà estesa, blockchain e intelligenza artificiale» (pp. 64-65). Sottolineando come il Metaverso non sia riconducibile a mero ambiente tecnologico, bensì occorra guardare ad esso come un terreno di negoziazione sociale, politica ed economica, nel suo scritto Presutti ricostruisce le tappe principali dell’evoluzione storica del concetto di Metaverso determinato dall’intrecciarsi di sviluppi tecnologici, di trasformazioni dell’industria videoludica, di cambiamenti socio-economici e di momenti di svolta nell’immaginario collettivo, evidenziando, al contempo, i limiti sensoriali delle tecnologie immersive contemporanee, ancora in buona parte concentrate sull’udito e sulla vista, e come l’ambito videoludico rappresenti al momento il settore di sperimentazione trainante.
A partire dall’importanza storicamente assegnata all’immagine nel tentativo di superare i limiti fisici dell’essere umano per «visitare mondi possibili in cui non valgono le regole della natura e dove è possibile vivere storie nelle quali immergerci» (p. 77), Francesco Parisi guarda alle due strade con cui, a partire dagli albori della modernità, si è guardato all’immagine: la via rinascimentale italiana incentrata sulla rappresentazione di un evento intenzionalmente progettato e costruito e quella olandese mirante invece alla descrizione oggettiva del mondo senza implicare una narrazione compiuta e autoriferita, strade destinate a confrontarsi con l’avvento ottocentesco della fotografia, strumento tanto narrativo quanto descrittivo che ha imposto un importante cambio di paradigma percettivo.
Al fine di analizzare la Realtà Virtuale (RV) e la Realtà Aumentata (RA) che fanno seguito alla stagione in cui il cinema e gli audiovisivi hanno forgiato l’immaginario novecentesco, Parisi riprende la distinzione proposta da Jonathan Friday fra due diverse logiche che sottostanno rispettivamente all’immagine rinascimentale albertiana ed a quella kepleriana. Nella prima si guarda all’immagine come a «finestra dalla quale l’osservatore si affaccia per contemplare un mondo finzionale, parallelo e alternativo al mondo reale, in cui si sviluppa una storia che ha un inizio e una fine e che ha senso compiuto all’interno della cornice», un’immagine incentrata sulla volontà del pittore di «creare un mondo finzionale che risponda a una propria logica e sia completamente sganciato da ogni riferimento al mondo reale». Nel caso kepleriano, invece, l’immagine si propone come materializzazione dell’esperienza visiva di un osservatore, come frammento di mondo che, come tale, «non deve necessariamente avere o rappresentare una storia, ma solo essere visto per ciò che è» (p. 78).
Parisi guarda dunque alla realtà virtuale come alla più avanzata manifestazione del principio albertiano, e alla realtà aumentata come all’attuale punto di arrivo dell’immagine kepleriana evidenziando come, a suo avviso, «l’altalenante fortuna del Metaverso della quale si discute da tempo sia riconducibile all’eccessivo sbilanciamento, alimentato dai visori di RV, verso la logica dell’immagine albertiana», e come «l’adozione del paradigma kepleriano, mediante i dispositivi che vengono definiti oggi smart glasses, possa favorire non tanto la contemplazione di un Metaverso ma l’esplorazione di un diaverso, un universo che non sta altrove, ma che è già di fronte a noi e che possiamo espandere attraversandolo tecnologicamente» (p. 79). L’immagine kepleriana, nel suo «non propone un mondo fittizio in cui una storia si articola, ma solo la prospettiva descrittiva di un pezzo di mondo visto da qualcun altro», sostiene Parisi, «non ha lo scopo di trasferirci altrove, ma di essere strumento mediante cui accedere a un frammento di realtà altrimenti inaccessibile»; essa è dunque «la materializzazione di un’opportunità visuale» (p. 81), da qui la proposta di ricorrere al prefisso dià, a significare per mezzo di, attraverso.
A concludere la sezione dedicata ai profili strutturali del Metaverso, Leo Sorge riprende i principali snodi trattati dai diversi autori evidenziando come per quanto il mondo attuale continui a pensarsi strutturato da confini fisici, si trovi a fare i conti con una realtà rimodellata dall’espansione nel cyberspazio e nella space economy.
La sezione del volume dedicata agli aspetti socio-mediologici si apre con un saggio di Gino Frezza che invita a non guardare al Metaverso come se si trattasse di un’innovazione estemporanea priva di una storia. Lo studioso evidenzia, infatti, come la condizione di immersività all’interno di un ambiente visivo dall’apparenza tridimensionale in cui si interagisce con altri soggetti permessa dal Metaverso derivi da una serie di innovazioni tecnico-sociali che lo precedono. Il Metaverso andrebbe dunque guardato come risultato di un lungo processo che ha preso il via con la fotografia e che si è poi sviluppato nel cinema che, con la sua capacità di creare l’identificazione degli spettatori sullo schermo, ha posto le basi per l’esperienza immersiva consentita dal muovo ecosistema digitale.
 Marco Centorrino ripercorre invece la storia della Rete mostrando come questa, tradendo le sue promesse libertarie, abbia finito per indirizzarsi verso il capitalismo digitale. Essendo i presupposti libertari con cui era nata la Rete ben diversi da quelli profit oriented da cui nasce il Metaverso, sarebbe sbagliato, sostiene lo studioso, vedere in quest’ultimo una nuova versione della Rete. Quello del Metaverso è infatti uno spazio concepito e realizzato direttamente dalle aziende private per scopi commerciali, per raccogliere dati biometrici degli utenti (salute, umore, emozioni) e per la vendita di prodotti virtuali in un contesto in cui muta il concetto stesso di proprietà. Non si tratta, dunque, di una semplice evoluzione della Rete, il Metaverso si sta configurando come un universo destinato a dotare le aziende di esercitare inedite forme di potere nei confronti degli utenti.
Marco Centorrino ripercorre invece la storia della Rete mostrando come questa, tradendo le sue promesse libertarie, abbia finito per indirizzarsi verso il capitalismo digitale. Essendo i presupposti libertari con cui era nata la Rete ben diversi da quelli profit oriented da cui nasce il Metaverso, sarebbe sbagliato, sostiene lo studioso, vedere in quest’ultimo una nuova versione della Rete. Quello del Metaverso è infatti uno spazio concepito e realizzato direttamente dalle aziende private per scopi commerciali, per raccogliere dati biometrici degli utenti (salute, umore, emozioni) e per la vendita di prodotti virtuali in un contesto in cui muta il concetto stesso di proprietà. Non si tratta, dunque, di una semplice evoluzione della Rete, il Metaverso si sta configurando come un universo destinato a dotare le aziende di esercitare inedite forme di potere nei confronti degli utenti.
Riprendendo Friedrich Kittler nel suo denunciare la non neutralità tecnologica, nel convincimento che ogni dispositivo digitale sia contraddistinto da una precisa architettura di potere e controllo e che le operazioni mediate da macchine dipendano ben più dalle configurazioni fisiche (hardware) dell’apparecchiatura che dal software, Mario Tirino applica tale prospettiva di lettura anche al Metaverso rivelando come dietro alle lusinghe delle esperienze immersive sia possibile cogliere come le sue tecnologie non siano affatto «semplici strumenti di connessione», bensì «elementi che ristrutturano le relazioni sociali e i processi economici, rendendo gli utenti sempre più dipendenti dalle piattaforme digitali» (pp. 112-113). Nonostante le tecnologie e le applicazioni del Metaverso tendano ad essere presentate come una rivoluzione epocale priva di storia, anche Tirino evidenzia come, in realtà, queste siano costruite su modelli precedenti di controllo e archiviazione. Guardando alla dimensione materiale delle tecnologie digitali del Metaverso è possibile deostruire l’idea di un mondo virtuale completamente immateriale: «dietro la realtà simulata si nasconde il lavoro di sviluppatori, designer e operatori di data center, spesso sottopagati e sfruttati». Senza dimenticare che la digitalizzazione delle interazioni sociali nel Metaverso «implica nuove forme di alienazione, manipolando in diversi modi e per differenti finalità l’esperienza corporea e sensoriale dell’individuo» (p. 114).
Come scrive Gennaro Iorio, i saggi di Frezza, Centorrino e Tirino «dimostrano come il Metaverso non sia una semplice innovazione tecnica, ma un progetto che ridefinisce le regole dell’economia digitale e dell’interazione sociale, con implicazioni che vanno ben oltre il settore tecnologico» (p. 119). Insomma, più che un’opportunità di emancipazione e di innovazione democratica, il Metaverso si configura come un progetto volto ad estendere le dinamiche di controllo e sorveglianza già esistenti.
Se i toni entusiastici che accompagnarono la presentazione di Mark Zuckerberg del “suo” Metaverso nel 2021 si sono affievoliti, ciò è dovuto, sostiene Lorenzo Di Paola, soprattutto a tre fattori: la mancata attuazione in tempi rapidi della promessa di un mondo pienamente immersivo accessibile a tutti; il desiderio di recuperare pratiche sociali, di studio e di lavoro “in presenza”, dopo l’overdose di ricorso all’online dell’epoca della pandemia; la centralità assunta a livello mediatico ed economico dall’intelligenza artificiale a partire dal 2022 anche grazie alla sua capacità di interfacciarsi con i sistemi aziendali, creativi e sociali esistenti. Nonostante il progetto di Zuckerberg sia stato accompagnato/supportato da un’enfasi eccessiva rispetto alla sua concretizzazione pratica e diffusa (mentre nel frattempo si sono sviluppati mondi virtuali come Roblox, Fortnite e Decentraland) Di Paola invita a considerare quanto questo il progetto di Meta abbia comunque già influenzato le nostre vite. Il fatto stesso di essere stato presentato ha infatti posto una serie di problematiche con cui occorre sin da ora fare i conti:
La governance degli spazi (chi controllerà e come saranno regolamentati tali ambienti, quali quadri normativi saranno necessari); la sicurezza dei dati e della privacy degli utenti (con l’enorme quantità di dati che gli utenti metteranno a disposizione, sarà essenziale sviluppare sistemi di protezione avanzati per prevenire abusi e tutelare la fiducia degli utenti); le identità nel Metaverso (come gestire le identità degli utenti e garantire la sicurezza evitando truffe e manipolazioni); partecipazione equa e accessibile (per evitare nuove forme di esclusione socio-economiche e garantire accesso e opportunità a un pubblico più ampio possibile) (p. 126).
Di certo la progressiva immersione degli individui negli ambienti digitali è destinata a incidere radicalmente sulle dinamiche socio-tecnologiche contemporanee, a dar luogo a forme di sorveglianza e profilazione biometrica sempre più pervasive e a problematiche derivanti dall’indistinguibilità tra interazioni autentiche e manipolate, con relative implicazioni non solo a livello individuale ma anche sociale e politico. Un Metaverso di proprietà esclusiva di un ristretto numero di colossi tecnologici transnazionali comporterebbe, oltre che una sempre maggiore centralizzazione e mercificazione della rete, una concentrazione di potere incontrollabile dai governi nazionali, con evidenti ricadute sulle libertà individuali e sulle dinamiche sociali.
Antonella Napoli propone di guardare al Metaverso come «un crocevia tra l’immaginario sociale che elabora costantemente vie d’uscita e seconde occasioni […] in cui sono riversate paure e sogni socialmente prodotti» e «le ragioni tecnocratiche che, a partire da quello stesso immaginario, definiscono temi e narrazioni che rispondono in modi innovativi alle trasformazioni del capitalismo» (pp. 163-164). Il Metaverso può dunque essere visto come metafora di una contemporaneità attraversata da inquietanti contraddizioni tra potenzialità tecnomagiche e limitazioni tecnofeudali, tra crisi economiche legate a dinamiche di speculazione finanziaria, processi di crescente virtualizzazione dell’economia, dematerializzazione dei sistemi vitali e comunicativi e progressivo scivolamento verso l’indistinguibilità tra verità e menzogna.
Angelo Romeo indaga l’importanza degli attuali dispositivi tecnologici dell’agire comunicativo nella costruzione della conoscenza in un epoca in cui «ogni azione di intelligentia viene delegata sempre più spesso a una macchina» (p. 167), mentre Luigi Somma guarda ai rapporti fra la corporeità umana e le tecnologie del Metaverso in un contesto contraddistinto dall’indistinzione fra reale e virtuale, da identità sempre più dinisincarnate e da ambienti digitali despazializzati. «Le identità sociali che verranno a configurarsi nel Metaverso», scrive lo studioso, «saranno simulazioni iperrealistiche del proprio sé: simulacri della nostra identità, privi di qualunque ancoraggio a un referente reale». Allo stesso modo, «anche le relazioni, sotto l’insegna di un regime di (falsa) esibizione di trasparenza e autenticità, simuleranno le interazioni faccia a faccia, ma attraverso un alto grado di fluidità delle relazioni; le quali sempre più richiederanno una capacità di rekeying […] nel teletrasportarsi da un ambiente digitale all’altro, costituendo comunità multiple» (p. 183).
A partire dalla serie Black Mirror (Channel 4-Netflix, dal 2011) e dal film interattivo Black Mirror: Bandersnatch (2018) diretto da David Slade, entrambi creati da Charlie Brooker, Ivan Pintor Iranzo guarda al multiverso e al Metaverso come appiattimento del possibile. Entrambe le produzioni audiovisive mettono in scena l’impotenza umana nel plasmare il futuro, in esse le alternative offerte dalle tecnologie si palesano come accelerazione verso il nulla. Black Mirror, insomma, secondo lo studioso, induce a pensare multiversi e Metaversi come «un sintomo e una diagnosi di un presente esausto, segnato da fenomeni come l’economia dell’attenzione […], lo sfruttamento del capitale emotivo della popolazione, l’inscindibilità tra lavoro, svago ed emozioni e la creazione di un’economia globale della performance». Anziché meccanismi per scenari controfattuali, multiversi e Metaversi alternativi sembrano «rappresentazioni iterative dell’influenza che la tecnologia esercita sulla configurazione neuro-cognitiva della popolazione» (p. 208). I personaggi solitari immersi nei dispositivi tecnologici per accedere a un universo parallelo e interconnesso con l’esperienza di altre persone che popolano egli episodi della serie di Charlie Brooker, suggeriscono «un’impossibilità, quella dell’alleanza tra la tecnologia e un’immaginazione emancipatoria» (p. 209). Questi personaggi, appartenenti alla «classe media occidentale, perennemente sorvegliati in una società panottica e trasparente e spinti verso un’economia dell’attenzione che sovrappone il tempo libero con la produzione attraverso multiversi e Metaversi» (pp. 210-211), si configurano come testimonianza del realismo capitalistico, della propagandata impossibilità di immaginare un sistema alternativo.
Alcuni contributi della sezione dedicata agli aspetti socio-mediologici del Metaverso prendono in esame la sua incidenza su ambiti come la moda, lo sport, il gusto nell’alimentazione, l’universo museale e la salute. Michelle Grillo presenta una panoramica del rapporto attuale e in prospettiva tra mondo della moda e Metaverso soffermandosi sulla relazione di reciproca influenza tra i bisogni e i desideri di personalizzazione dei consumatori e le strategie commerciali dei brand che si approcciano a tale ambiente. Sarebbe limitativo vedere nel Metaverso una semplice replica digitale della realtà della moda; tale intersezione tra moda e tecnologia digitale introduce, oltre a nuovi modelli di business, inediti capitali simbolici e sociali che rafforzano le relazioni tra i brand e le community ponendo le premesse per un futuro in cui produzione e consumo sono sempre più intrecciati.
Delle trasformazioni che il Metaverso ha introdotto nel settore dello sport e di come le tecnologie immersive ne abbiano modificato il consumo mediale in termini di interattività e personalizzazione, trasformando l’esperienza del tifoso – investitore di prodotti digitali – in una una fonte continua di profitto per le società sportive si occupa Simona Castellano. Josephine Condemi riflette sull’incidenza delle rivoluzioni tecno-industriali sul senso del gusto e su come i Taste Media aprano inediti scenari di sofisticazione alimentare, mentre Marco Navarra guarda a come la digitalizzazione abbia trasformato il ruolo degli archivi e dei musei rendendoli spazi di fruizione e interazione virtuale e come l’avvento delle tecnologie immersive sia destinato a ridefinire ulteriormente il concetto stesso di esperienza museale promettendo da un lato un maggior accesso alla cultura e dall’altro ponendo interrogativi circa l’autenticità dell’esperienza estetica e la funzione sociale delle istituzioni museali. Di come il ricorso al Metaverso possa incidere sulla gestione della salute, tanto in ambito clinico che assistenziale, si occupa Cristiana Ferrigno ponendo attenzione su come la monetizzando dei dati sulla salute degli utenti attraverso sistemi di gamification promuova un’idea di benessere quantificabile attraverso pratiche di auto-monitoraggio dei parametrici fisici e delle performance nello svolgimento di attività. Se risulta problematica la scelta del soggetto o dei soggetti a cui affidare il controllo del Metaverso nell’ambito della salute, non lo è da meno, ricorda Ferrigno, l’individuazione di chi dovrà “controllare i controllori”.
A commento della corposa sezione dedicata ai profili socio-mediologici del Metaverso, Emanuela Piga Bruni evidenzia come lo «sfumare dei confini tra realtà e immaginazione, storia e memoria, naturale e artificiale» (p. 249) conduca al cyborg di Donna Haraway, al nuovo individuo che abita tale universo digitale immersivo. Riprendendo riflessioni che attraversano film e serie televisive di fantascienza come Blade Runner (1982) di Ridley Scott, Ghost in the Shell (1995) di Mamoru Oshii, Westworld (1973) di Michael Crichton e la serie televisiva Westworld (2016-2022) creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, la studiosa ritiene che ripartire dal corpo potrebbe essere «uno dei modi di abitare i mondi molteplici del Metaverso in modo tale che le istanze di anelito al sogno, alla consapevolezza di sé, alla connessione profonda con altre coscienze possano trovare spazio, insieme a esperienza di riconoscimento e trascendenza in ambienti dai confini sempre più porosi e iridescenti» (pp. 256-257)
Nella sezione finale del volume, dedicata economici e giuridici, come scrive Marco Bassini a commento e conclusione dei diversi saggi che la compongono, gli autori dei contributi «colgono efficacemente come il Metaverso non costituisca una dimensione futura ed eventuale, bensì una realtà all’interno della quale si spiegano già dinamiche che rassomigliano alle modalità tradizionali del potere, ancorché incanalate entro forme differenti» (pp. 375-376). Come sottolinea Bassini,
le trasformazioni che accompagnano l’affermazione del Metaverso si spingono oltre la frontiera del rapporto tra diritti e potere, coinvolgendo la dimensione antropologica che connota l’essenza stessa dell’individuo e descrive il mutare dei suoi predicati nell’ambito di tecnologie immersive, coinvolgendo aspetti legati anche a profili economici. Si tratta di recuperare a una dimensione che prescinde da confini spaziali la centralità dell’individuo, còlta finora dalle costituzioni e dalle carte dei diritti esistenti nella sua dimensione prettamente fisica e dunque ancorata a un paradigma spazialmente limitato (p. 376).
Francesca Paruzzo si concentra sul potere esercitato sugli utenti dalle imprese private che operano nel mondo digitale, in particolare all’interno del Metaverso, «mantenendo il controllo di ogni vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva che si realizza all’interno di tali mondi» (p. 262). La studiosa guarda a come «il costituzionalismo possa offrire strumenti idonei a ridurre lo scarto, oggi più che mai esistente, tra l’esigenza di una regolamentazione politica – di un vincolo, appunto – all’azione di tali nuovi poteri digitali e la contrapposta pretesa di questi ultimi di rimettere la propria attività “alla negoziazione iure privatorum”» (p. 263), cioè alle norme di diritto privato. Quanto insomma negli ecosistemi digitali immersivi l’ambito pubblico sia piegato ad ambito privato. A partire dall’inedita peculiarità immersiva che contraddistingue tali ambienti, Maria Francesca De Tullio, una volta dichiarata l’esigenza di un intervento regolatorio per la tutela dei diritti fondamentali, della privacy e dell’autodeterminazione individuale e collettiva in tale nuovo contesto, si domanda quanto il Metaverso richieda una normativa specifica rispetto a quella più generale applicata a Internet.
Osservando la tendenza degli ecosistemi digitali a presentarsi come universi dotati di logiche regolatorie di derivazione tecnica, per certi versi assimilabili a Stati, Andrea Venanzoni evidenzia come ciò metta «in crisi la stessa elaborazione concettuale della scienza giuspubblicistica, evolutasi geologicamente per stratificazione sui concetti salienti dell’articolazione statale; popolo, territorio e sovranità» (p. 297). Lo studioso concentra dunque la sua riflessione sul territorio, l’elemento che risulta «storicamente e paradigmaticamente più inciso dal digitale, con la sua fisiologia di potere tecnico spazialmente a-territoriale» (p. 297). Dopo essersi soffermato sulla centralità del territorio nella teoria generale dello Stato, dunque sul suo passaggio dal territorio fisico allo spazio digitale, Venanzoni ripercorre l’architettura portante del Gaming, del Metaverso e della economia delle piattaforme.
Guardando al Metaverso come sintesi di una molteplicità di tecnologie interconnesse da cui deriva un nuovo habitat relazionale in cui si ridefiniscono governance, sistemi produttivi e dinamiche di valore e di consumo, è, possibile cogliere come in esso prenda forma, scrive Mario Passaretta, «un nuovo ordine giuridico del mercato, caratterizzato non tanto dalla sostituzione dei tradizionali attori economici, quanto dalla riconfigurazione dei rapporti secondo paradigmi del tutto innovativi» (p. 336). In un tale ambiente l’«economia digitale, sostenuta da un’architettura informativa reticolare, afferma il primato della disintermediazione, dell’integrazione funzionale, della commistione tra mercati contigui e della personalizzazione algoritmica, con il dato che assume progressivamente un ruolo centrale quale fattore produttivo primario e leva dell’organizzazione concorrenziale» (p. 336). Lo studioso passa dunque in rassegna come le istituzioni politiche e giuridiche stiano tentando di regolamentare il nuovo ecosistema digitale.
Miriam Abu Salem guarda invece all’uso del web fatto delle religioni cattolica e islamica, soffermandosi su come l’ecosistema digitale sviluppi un’inedita dinamica partecipativa che rende l’internauta-fedele parte attiva del discorso religioso più di quanto non lo sia il fedele al di fuori dello spazio digitale, incrementando interpretazioni eterodosse e sottraendo parte del potere di guida alle tradizionali autorità religiose.
L’intrecciarsi delle interazioni online con le esperienze quotidiane comportante una modalità di esistenza al contempo fisica e virtuale, induce Anna Papa, nella sua postfazione al volume, ad evidenziare come ciò abbia importanti ricadute sia sul piano individuale che collettivo. La studiosa concentra la sua riflessione sul tema spinoso dell’identità rapportata alla vita ibrida, all’onlife, un terreno per certi versi inedito dal punto di vista della tutela, alla luce del fatto che, focalizzati sull’identità fisica, i tradizionali ordinamenti giuridici faticano ad essere applicabili alle identità digitali che il soggetto viene ad assumere, con importanti ripercussioni sul percorso evolutivo della personalità individuale e sulla sua tutela. Non si può prescindere, chiosa Papa, dall’affermare l’assoluta «centralità della persona anche nello spazio digitale, garantendo che l’evoluzione tecnologica sia al servizio dello sviluppo umano e non la sua sostituzione» (p. 389).



