di Gioacchino Toni
 Alfredo Rossi, Elio Petri e il cinema politico italiano. La piazza carnevalizzata, Mimesis, Milano – Udine, 2015, 228 pagine, € 20,00
Alfredo Rossi, Elio Petri e il cinema politico italiano. La piazza carnevalizzata, Mimesis, Milano – Udine, 2015, 228 pagine, € 20,00
«La mia visione del cinema di Petri è quella di un cineasta, di un intellettuale pervaso di un lucido pessimismo fondato sull’analisi delle contraddizioni sociali e politiche, che si muove all’interno di una visione tragica dei conflitti, e che si sforza di metterli in scena come tali. Senza rassegnazione ma senza credenza» Alfredo Rossi (p. 55)
Perché scrivere oggi un libro su Elio Petri? Non si tratta, ci tiene a sottolinearlo l’autore, di sconfessare oggi «una letteratura pesantemente, a volte, ostile per forzare e chiudere un’azione risarcitoria nei riguardi di Petri. [il suo cinema] concerne oggi la scena critica per il suo lavorare in modo diretto sul problema del Potere e dell’Amore del Potere. Mai, infatti, come negli ultimi anni sono questi i nodi su cui si misura, in tutti gli ambiti del discorso, la cultura militante che non guardi in modo meccanicistico al tema del politico. Ecco perché il cinema di Elio Petri si fa dire oggi: perché lavora, nella sua major phase, in modo analitico attorno alla impossibile rappresentazione del Soggetto nel Politico se non in termini psicotici» (p. 27).
Elio Petri è sicuramente un autore dalla fortuna critica alterna. Tanti tra coloro che avevano supportato, seppur problematicamente, il cinema del “primo Petri”, hanno finito col contestarne, spesso drasticamente, l’ultima fase, segnata da un mutamento profondo; alcuni, secondo l’autore, «erano impossibilitati “per natura” a capire una nuova pratica della scrittura e della politica che troverà il momento più alto in Todo modo», altri, quelli che Rossi definisce «i rappresentanti del “terrorismo critico”, dell’avanguardia critica, “Cinema&Film” e “Ombre Rosse”», risultarono incapaci di «superare gli effetti di una supposta distanza politica, vittime loro malgrado delle proprie petizioni di principio e di lotta ideologica» (p. 21). Già all’uscita del film La classe operaia va in paradiso (1971) si alzarono pesanti critiche nei confronti dell’opera, accusata apertamente di essere reazionaria sia da parte dell’estrema sinistra che da parte degli esponenti dall’avanguardia del cinema militante, come il regista Jean Marie Straub.
 Agli attacchi ed alle accuse Petri non mancò mai di rispondere con tono altrettanto polemico, a testimonianza di ciò si possono leggere alcuni passi, riportati dal saggio, tratti da Parla il cinema italiano vol. 2 (Il Formichiere, 1979 – p. 252-256), in cui il regista non risparmia stilettate sia alla critica marxista tradizionale che alla critica militante più recente, legata alle nuove riviste di cinema sorte negli anni ’60: «I marxisti dopo la scomparsa di Barbaro e Della Volpe, si sono ansiosamente ancorati ad un loro storicismo buono per tutte le occasioni. Marxisti, cattolici e idealisti si sono tutti trovati d’accordo in ciò, che la lettura di un testo è essenzialmente contenutistica […] Dal sessanta in poi vi sono state, inoltre, molte frettolose traduzioni dal francese di idee spesso tradotte dal tedesco e dal russo. Battaglioni di avventizi si sono gettati su queste idee, sbranandole, divorandole, in una gran confusione di fini. Molti si sono improvvisati formalisti, stilisti, semiologi, strutturalisti, lacaniani, o un po’ dell’uno un po’ dell’altro…» (p. 21-22). La polemica nei confronti di “Cinema&Film” ed “Ombre Rosse” è palese, come è certo che tali riviste, sostiene Rossi, abbiano mantenuto un atteggiamento di «chiusura nei suoi riguardi in quella fase di passaggio radicale, gli anni settanta, vera sua fase di mutazione ideologica e stilistica da un cinema di narrazione, esistenzialista, ad un cinema volto al simbolico» (p.23).
Agli attacchi ed alle accuse Petri non mancò mai di rispondere con tono altrettanto polemico, a testimonianza di ciò si possono leggere alcuni passi, riportati dal saggio, tratti da Parla il cinema italiano vol. 2 (Il Formichiere, 1979 – p. 252-256), in cui il regista non risparmia stilettate sia alla critica marxista tradizionale che alla critica militante più recente, legata alle nuove riviste di cinema sorte negli anni ’60: «I marxisti dopo la scomparsa di Barbaro e Della Volpe, si sono ansiosamente ancorati ad un loro storicismo buono per tutte le occasioni. Marxisti, cattolici e idealisti si sono tutti trovati d’accordo in ciò, che la lettura di un testo è essenzialmente contenutistica […] Dal sessanta in poi vi sono state, inoltre, molte frettolose traduzioni dal francese di idee spesso tradotte dal tedesco e dal russo. Battaglioni di avventizi si sono gettati su queste idee, sbranandole, divorandole, in una gran confusione di fini. Molti si sono improvvisati formalisti, stilisti, semiologi, strutturalisti, lacaniani, o un po’ dell’uno un po’ dell’altro…» (p. 21-22). La polemica nei confronti di “Cinema&Film” ed “Ombre Rosse” è palese, come è certo che tali riviste, sostiene Rossi, abbiano mantenuto un atteggiamento di «chiusura nei suoi riguardi in quella fase di passaggio radicale, gli anni settanta, vera sua fase di mutazione ideologica e stilistica da un cinema di narrazione, esistenzialista, ad un cinema volto al simbolico» (p.23).
Relativamente alla trasformazione imposta dal cineasta alle ultime opere, Rossi propone oggi una lettura differente da quella sostenuta a suo tempo, quando i film uscirono in un contesto culturale, politico e sociale diverso, in un periodo contraddistinto da ben altre urgenze: «Petri è un marxista e un materialista, lo psicologismo individualistico gli è estraneo o, nel tempo lo ha totalmente capovolto e ciò risulta chiarissimo nelle esperienze evolutive degli ultimi anni. È l’analisi della struttura capitalistica e psicotica che muove la sua riflessione sui fatti: gli attanti dei suoi film ultimi sono soggetti giocati dal reale e non individui – esistenze. L’oggetto del suo cinema sono soggetti equivocanti sul proprio supposto sé razionale, sociale e politico, sono maschere di una rappresentazione carnascialesca dominata dalla pulsione di morte. Elio legge con lenti marxiste e freudiane il mondo. Elabora all’interno della rappresentazione il gioco della pulsione di morte nelle dinamiche del reale della politica: è questa la genialità della sua scrittura. […] Il concetto di morte al lavoro è il rovello continuo della loro elaborazione: morte come processo di degrado del costume civile, decadimento dell’essere come insensatezza di soggetto lavorato dalla perdita identitaria. Pasolini parlava di corruttibilità della specie, delle facies, Elio la rappresentava, con genio registico a mio avviso assai superiore, radicalizzando la sua messa in scena grazie al gioco di maschere carnascialesche del potere, in una sfera di teatralità vicina al kabuki. È Elio il vero autore d’avanguardia del cinema italiano degli anni settanta, (assieme, come già detto al diversissimo Carmelo Bene e a qualche film di Ferreri, regista che amava) il vero padroneggiatore di un discorso sovversivo sul soggetto nel politico» (p. 26)
Nel corso degli anni ’60 si è sviluppata una profonda frattura tra i registi italiani “impegnati”, coinvolti nelle strutture produttive dell’industria del cinema, e la componente più radicale della critica cinematografica. Da allora, registi quali Petri, Rosi, Pontecorvo, Damiani e Montaldo rappresentano, secondo il saggio, «l’impensato della critica militante», tanto che ancora oggi risulta difficile «oltrepassare il limbo formalizzato della politica della rappresentazione per puntare all’analisi della rappresentazione del politico» (p. 40). Se si capiscono i motivi per cui i film di tali cineasti venivano, all’epoca, spesso attaccati da parte della critica politica (cinematografica e non) più radicale, oggi «tutto fa pensare che siano l’oggetto perturbante anche secondo i modesti criteri della comune pratica critica odierna che sono quelli della valorizzazione del cinema in quanto tale, come cosa cinematografica e prescindono da approcci analitici complessi. Oggi il massimo che ci si può attendere è l’assunzione impensata dei registi del cinema politico nell’empireo già affollatissimo del cinema italiano, quali esperti in un generone, come l’horror, il comico, la commedia, il peplum, il dramma popolare» (p. 40).
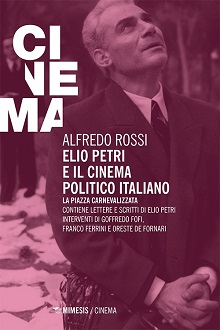 Alcune letture riducono il cinema politico italiano dell’epoca ad uno stereotipato catalogo di situazioni: «Le sceneggiature ruotano sempre infatti attorno a temi civili, variando esclusivamente l’economia della loro distribuzione. La polizia… italiana, la giustizia… italiana, la gestione… italiana del potere pubblico: si potrebbe dire che quel che è in questione è sempre l’apparato del Potere in Italia, distorto, mafioso, intrigato ed intrigante» (p. 42). Rossi evidenzia come gli ultimi due aggettivi non siano utilizzati casualmente; «poiché la politicità di tali film consiste nel contestare una realtà di potere, oggi, nel nostro Paese, inscenandola come “intrigo di potere” e, sottolineerei, intrigo “italiano” […] in quanto riconduce a modalità del dire, dell’immaginare, del rappresentare il Potere radicatesi nella notte della teatralità italiana. È dunque attraverso la griglia della doppia connotazione di “intrigo” ed “italianità” che il cinema italiano trova, a livello extracritico soprattutto, una sua riconoscibilità di massima che fa distinguere i film di registi quali Rosi, Montaldo, Pontecorvo, Petri da un altro cinema che pur esso si appella alle categorie del politico, quello dei Taviani, Bertolucci, Pasolini» (p. 42).
Alcune letture riducono il cinema politico italiano dell’epoca ad uno stereotipato catalogo di situazioni: «Le sceneggiature ruotano sempre infatti attorno a temi civili, variando esclusivamente l’economia della loro distribuzione. La polizia… italiana, la giustizia… italiana, la gestione… italiana del potere pubblico: si potrebbe dire che quel che è in questione è sempre l’apparato del Potere in Italia, distorto, mafioso, intrigato ed intrigante» (p. 42). Rossi evidenzia come gli ultimi due aggettivi non siano utilizzati casualmente; «poiché la politicità di tali film consiste nel contestare una realtà di potere, oggi, nel nostro Paese, inscenandola come “intrigo di potere” e, sottolineerei, intrigo “italiano” […] in quanto riconduce a modalità del dire, dell’immaginare, del rappresentare il Potere radicatesi nella notte della teatralità italiana. È dunque attraverso la griglia della doppia connotazione di “intrigo” ed “italianità” che il cinema italiano trova, a livello extracritico soprattutto, una sua riconoscibilità di massima che fa distinguere i film di registi quali Rosi, Montaldo, Pontecorvo, Petri da un altro cinema che pur esso si appella alle categorie del politico, quello dei Taviani, Bertolucci, Pasolini» (p. 42).
Se abbiamo un “intrigo”, continua lo studioso, «vi è qualcosa che va svelato, da parte di qualcuno di una certa “scena”» e si deve credere che esista una soluzione all’enigma, «ovvero che la Scena ricopra, celi, una Verità svelabile, dicibile. E che sussista la funzione catartica di strappare il velo della scena del “reale” in modo che esso possa dirsi nella sua verità» (p. 43). Il cinema politico italiano, secondo Rossi, intende mettere in scena l’enigma del sociale capitalista, sotto forma di intrigo politico al fine di denunciarne la natura di classe.
Circa la seconda connotazione, quella di “italianità”, il cinema politico italiano ha inevitabili rapporti con la commedia all’italiana (registi, attori, sceneggiatori, tecnici, produttori…) e tale legame ha la sua incidenza. Rossi indica come commedia all’italiana, commedia dell’arte e delle maschere borghesi siano segnate dell’immaginario politico di cui il cinema politico non ha di certo l’esclusiva. Nel saggio si sostiene che proprio a Petri si deve la più importante scoperta linguistica del cinema politico italiano, cioè «l’invenzione della necessità scritturale di attribuire all’ordine del politico la maschera di Gian Maria Volonté. Il che vuol dire strappare all’ordine simbolico della commedia all’italiana, tipicamente borghese, la pregnanza immaginaria della maschera spostandola sulla scena dell’agone del desiderio politico e restituendo alla maschera asservita e mercantile tutta la sua significanza» (p. 45). Non è dunque un caso che Petri si sia servito di un attore estraneo al firmamento del grottesco della commedia all’italiana. Il saggio evidenzia come esista una distanza netta tra le maschere degli attori della commedia all’italiana e la maschera di Volonté; in quest’ultimo caso l’attore riesce a «raggiungere la perfezione della maschera, la totalità della mimèsi e, di conseguenza, l’assoluta indifferenza rispetto al modello» (p. 46). Nel cinema di Petri prevale un’oscillazione permanente in un’alternanza di sublime/comico e ciò è dovuto alle capacità di alternanza della maschera di Volonté.
È nella ricostruzione del ruolo politico della maschera nella scena teatrale italiana che Rossi individua ciò che accomuna e ciò che differenzia la commedia all’italiana ed il cinema politico italiano, giungendo alla conclusione che, al fine di comprendere la peculiarità del cinema politico di Petri, si debba riflettere sulla maschera di Volonté e da qui sul ruolo della “festa” quale «avventura immaginaria del suddito ma anche la sua tragedia, il suo scacco radicale, la sua mancanza ad essere che si inscena nello stesso recinto spaziotemporale» (p. 48).
Ricorrendo ad una chiave di lettura psicanalitica, di matrice lacaniana, Rossi giunge alla conclusione che «anche il problema della maschera concerne il sintomo discorsivo dell’allegoria. Re Carnevale ne è la cifra, doppiamente, in quanto rappresenta il tentativo di incarnarsi nel tutto del desiderio facente capo al soggetto in ordine al Politico. E questo nella prefigurazione di natura isterica che quella totalità, quella assolutizzata verità sia inscenabile. Qui, precisamente, si situa il paradosso dell’allegoria: per dire il tutto, la verità del Potere, non si dice nulla del potere-reale. La scena festiva, quindi, dal punto di vista della politica-reale non è un fatto trasgressivo, o, peggio, rivoluzionario. Ché, anzi, è il gesto confermativo di una dipendenza fantasmatica. […] La dinamica pulsionale del soggetto e del collettivo disdicono il reale-politico rappresentandone il simulacro. Come tale l’allegoria festiva, dell’enunciato politico, ha per effetto di introdurre, nella scena, il Politico come fantasma del politico-reale. Ma quest’ultimo ricompare come effetto di ritorno nella rappresentazione. E il suo “effetto di ritorno”, o après coup, consiste precisamente nell’impraticabilità dell’allegoria, ovvero nell’impossibilità per Re Carnevale di trattenere le fattezze di maschera» (pp. 49-50). A Carnevale succede Quaresima, al desiderio subentra la sua negazione, alla festa che tenta di fare a meno del principio di realtà si sostituisce la cancellazione del principio di piacere.
La lunga disamina circa il ruolo della festa è ritenuta indispensabile al fine di affrontare il cinema politico italiano che, nella lettura proposta da Rossi, «rappresenta l’agone del collettivo, attuato, per il tramite dello spettacolo cinematografico, al fine di specchiarsi (“specchio” e “spettacolo” hanno lo stesso etimo) come Potere, di raffigurarsi tale al centro di un palcoscenico immaginario che ha per quinte le nostre città, i nostri palazzi del potere» (p. 51). Il cinema politico italiano sarebbe dunque caratterizzato dal conflitto che si instaura nella rappresentazione tra la festa carnevalesca ed il contraccolpo quaresimale, il «gioco di maschera che esso propone è sempre destinato alla tragedia, alla Quaresima, alla conferma fantasmatica del “sistema” contro cui si rivolta» (p. 53), così facendo l’enigma della società politica italiana tende a riconfermarsi come tale visto che l’assunto di credenza non è messo in questione. «Questa dialettica non risolvibile è invece il centro stesso del meccanismo scenico dei film di Petri. Laddove, in tutta la produzione che esaminiamo, permane come sintomo, come discorso in perdita. E di perdita» (p. 53).
Rossi ripropone, più di una volta, nel saggio una celebre citazione lacaniana: «L’aspirazione rivoluzionaria ha una sola possibilità, quella di portare, sempre, al discorso del padrone. È ciò di cui l’esperienza ha dato prova. Ciò cui aspirate, come rivoluzionari, è un padrone. Lo avrete.» (J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII, Il rovescio della psicoanalisi, p 259). Tale citazione sintetizza bene la griglia di lettura attraverso cui Rossi analizza il cinema di Petri.
Nel cineasta la scena carnevalesca si fonda sull’attualità della politica-reale, il film affronta l’attualità del paese. «La messa in scena dell’impossibilità del desiderio, di dire il Politico-reale, il Potere-reale, fa si che Petri, in questa prospettiva, analizzi una fenomenologia del bisogno-politico quale si è prefigurata a partire dalla “festa sessantottesca”. Il ’68 come spazio festivo: le piazze le strade d’Italia battute da un’onda delirante, conclamatesi Potere» (p. 55). Secondo la lettura proposta dal saggio, mentre molti autori italiani del cinema politico «hanno letto l’invocazione ribellistica in termini di risposta, Petri l’ha letta in termini di domanda, quale disagio e pulsione di morte, di cui è intessuta» (p.55).
 Secondo Rossi, nel film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), Petri inserisce la rappresentazione della politica italiana all’interno di canoni discorsivi carnevaleschi attraverso la maschera di Volonté. Dell’attore il cineasta esalta le qualità mimetico giocose della sua recitazione senza mai farle scivolare in quel che lo studioso definisce “mascherone”, tipico della cinematografia italiana del dopoguerra che, facilmente, avrebbe trasformato il personaggio dell’ispettore di polizia in semplice caricatura del funzionario dell’amministrazione centralistica e gerarchica dello Stato. Il film di Petri, sostiene Rossi, «persegue invece un altro effetto: il lazzo, il comico, il grottesco che alimentano la sua finzione hanno una significanza differente nel testo, avente a che vedere con il desiderio del Cittadino piuttosto che dell’“ispettore”» (pp. 101-102).
Secondo Rossi, nel film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), Petri inserisce la rappresentazione della politica italiana all’interno di canoni discorsivi carnevaleschi attraverso la maschera di Volonté. Dell’attore il cineasta esalta le qualità mimetico giocose della sua recitazione senza mai farle scivolare in quel che lo studioso definisce “mascherone”, tipico della cinematografia italiana del dopoguerra che, facilmente, avrebbe trasformato il personaggio dell’ispettore di polizia in semplice caricatura del funzionario dell’amministrazione centralistica e gerarchica dello Stato. Il film di Petri, sostiene Rossi, «persegue invece un altro effetto: il lazzo, il comico, il grottesco che alimentano la sua finzione hanno una significanza differente nel testo, avente a che vedere con il desiderio del Cittadino piuttosto che dell’“ispettore”» (pp. 101-102).
«L’ispettore-Volontè risucchia la scena, la dissangua, la riduce ad ossessivo rumore di fondo per lanciare alta la sua invocazione isterica d’amore del Potere» e, continua lo studioso, quegli studenti che fronteggia, oggi si ritroverebbero nei panni di «funzionari dello Stato assistenziale, che con gesto amoroso li ha raccolti dalle piazze d’Italia e li ha “incardinati” nell’Amministrazione. Oggi essi fanno cardine: un po’ dovunque desidereranno esser ricevuti e amati dai capuffici, dai capi sezione, dai direttori generali, oppure sono già loro il Potere» (p. 102). La festa carnevalesca del ’68 si conclude, lacaniamente, verrebbe da dire, in maniera quaresimalistica.
«Per l’ispettore compiere l’assassinio dell’amante significa portare una sfida al centro del meccanismo fideistico che fonda l’Autorità, e al suo effetto di credenza. Non è un caso che nel corso del film, parlando dell’“interrogatorio” e della sua metodologia così lui lo definisca: “È una messa in scena per toccare corde profonde, sentimenti segreti. Di fronte a me che rappresento il Potere l’indiziato diventa un po’ bambino ed io divento il Padre, il modello inattaccabile; la mia faccia diventa quella di Dio, della Coscienza”. Ecco Re Carnevale […] Ma il dirsi Dio è anche una bestemmia: è nel contempo la incoronazione e la scoronizzazione del Potere e del suo effetto di credenza nell’ambito del Collettivo […] Proprio l’imputarsi, il farsi vittima sacrificale è il movimento stesso della colpevolizzazione per la pronunzia della bestemmia. È qui che s’annida il tarlo comico che mina la sublimità, l’eroicità dell’agire. Questa altalenanza è propria di ogni enunciato attorno al Politico, traversato come esso è dal sintomo isterico, in questo senso l’ispettore è anzitutto Cittadino, membro del Collettivo desiderante attorno al Potere. Di questa desideranza sessantottesca, nella sua continua pronunzia della bestemmia, nel godimento precluso, il Cittadino è il fantoccio, la maschera sublime e comica» (p. 102).
Con riferimento alla tarda produzione di Petri, secondo l’analisi proposta dal saggio, non si può parlare propriamente di “ritorno al privato”, di “riflusso dal politico” e di “disinganno”. Di certo gli ultimi film, a partire da La proprietà non è più un furto (1973) sono caratterizzati da una gestazione contorta, contraddittorietà e sofferta, ben testimoniata da una mole di scritti del regista in cui si alternano momenti di eccitazione ed altri di delusione. L’impressione, suggerisce il saggio, è che da un certo punto in avanti il cineasta abbia preferito lavorare per dare immagine ai propri fantasmi che a lungo erano stati “coperti” dal fragore della piazza. Nel film Le buone notizie (1979), al posto di Giancarlo Giannini, avrebbe dovuto recitare Marcello Mastroianni, attore che rappresenta per certi versi l’altra faccia di Volonté: «se quest’ultimo è la maschera del politico, Mastroianni lo è del privato. Ma un privato legato a doppio filo con il politico: un privato appartenente al dominio del conflitto attorno ad un’idea di morale possibile nel reale e di chiusura del Soggetto nel reale. Dunque nulla a che fare con modelli di introversione piccolo borghese, ma un privato giocato dalle contraddizioni tra il principio di realtà e le istanze anarchiche, violente e luttuose, di cui Elio è attraversato» (pp. 58-59).
La ri-lettura di Petri proposta da Rossi, che, come tiene a sottolineare, non vuole venga intesa come risarcitoria sconfessione di una precedente lettura ostile, sicuramente risente di come sono andate le cose dopo la sbornia sessantottesca e, se anche non vuol essere risarcitoria nei confronti di Petri, sembra riconoscergli doti di preveggenza. Una visione tragica, quella di Petri, in cui, oggi, in contesto fortemente mutato, forse, tra le righe, pare riconoscersi lo stesso Alfredo Rossi.
Il saggio contiene lettere e scritti di Elio Petri ed interventi di Goffredo Fofi, Franco Ferrini e Oreste de Fornari



