di Sandro Moiso
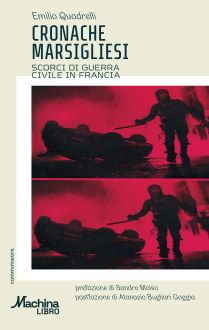 [Per ricordare la figura di Emilio Quadrelli ad un anno circa dalla sua scomparsa, e per gentile concessione della casa editrice, si pubblica qui di seguito la Prefazione alle sue Cronache marsigliesi recentemente raccolte in volume da MachinaLibro, Roma marzo 2025.]
[Per ricordare la figura di Emilio Quadrelli ad un anno circa dalla sua scomparsa, e per gentile concessione della casa editrice, si pubblica qui di seguito la Prefazione alle sue Cronache marsigliesi recentemente raccolte in volume da MachinaLibro, Roma marzo 2025.]
Tra il 6 settembre 2022 e il 22 settembre 2023 vengono pubblicati su Carmillaonline 35 articoli di Emilio Quadrelli, alcuni singoli e altri, la maggior parte, facenti parte di serie diversamente intitolate. Certamente in questi articoli sono presenti tutti i temi della ricerca militante di Emilio: la guerra come pratica comune dell’età dell’imperialismo; il partito (solo e unicamente) dell’insurrezione; la nuova composizione di classe e il ruolo del proletariato migrante al suo interno; la necessaria centralità di Lenin per la riflessione politica antagonista; l’internazionalismo proletario come irrinunciabile riferimento per un movimento di classe, contrario a qualsiasi forma di nazionalismo e di populismo; i “giornali” come forma e fonte di organizzazione politica e del pensiero rivoluzionario; i “barbari” delle periferie metropolitane e internazionali intesi non come ritagli di un passato ormai superato ma, piuttosto, come espressione più avanzata delle contraddizioni sociali causate dalla globalizzazione e, seguito di quest’ultima considerazione, il rifiuto di ogni forma di razzismo e di separazione secondo linee del colore. Anche, e soprattutto, quando questo sia espressione delle forme più retrograde di pensiero ricollegabile all’aristocrazia operaia o ad una classe operaia imbelle e impaurita tout court.
Di questi articoli, ben dodici sono dedicati alla città di Marsiglia, al suo proletariato e alle sue nuove forme di auto-organizzazione. Otto fanno parte delle Cronache marsigliesi uscite tra il 2 aprile 2023 e il 13 luglio dello stesso anno, mentre altri quattro fanno fanno parte della serie Le problème n’est pas la chute mais l’atterrissage. Lotte e organizzazione dei dannati di Marsiglia, titolo che fa esplicito riferimento al film del 1995 La Haine (in Italia L’odio) di Mathieu Kassovitz, usciti tra il 26 marzo e il 22 aprile sempre del 2023. In questi quattro è centrale il ruolo delle palestre come momento di organizzazione dal basso e come luoghi di addestramento alla preparazione fisica e alla disciplina dei militanti.
Marsiglia diventa così per Quadrelli, oltre che un luogo fisico geograficamente determinato, anche un luogo dell’anima. Una sorta di città ideale, laboratorio di nuove forma di lotta e di organizzazione dal basso. Un campo di battaglia sul quale già si sperimentano le contraddizioni e le lotte del futuro.
Le date degli articoli ci trasmettono l’urgenza vissuta da Quadrelli di comunicare e lasciare in eredità ai suoi lettori e compagni, una riflessione in costante evoluzione che egli continuava a svolgere non per amore della filosofia e della sociologia oppure per rivendicare una sorta di primato dell’intelletto e suo sul corso reale degli eventi e delle lotte, ma piuttosto per contribuire all’avvio di un processo di formazione di un partito formale che avrebbe comunque dovuto adeguare le sue forme a quelle espresse dal partito storico. Intendendo con quest’ultimo non soltanto le lezioni acquisite dalla storia del movimento operaio nelle sue differenti fasi e dalle lezioni delle controrivoluzioni, così come era stato inteso dalla Sinistra Comunista, di cui Emilio fu sempre attento lettore e critico, ma anche come l’espressione dell’immediatezza della soggettività di classe una volta che questa si manifesti attraverso le lotte e, soprattutto, le nuove forme che queste dovevano assumere ad ogni tornata storica per rispondere alle modificate condizioni sociali ed economiche, forme del lavoro in primis, create dal capitale nella sua esigenza di superare e infrangere qualsiasi limite al suo sviluppo. In modo da dar corpo e gambe su cui marciare alla dialettica prassi//teoria/prassi necessaria per la comprensione e la direzione del processo rivoluzionario. Perché in Quadrelli, come per Lenin, le rivoluzioni non si fanno, ma si dirigono.
Una riflessione che si pensava e voleva eretica, perché qualsiasi rottura rivoluzionaria non avrebbe mai potuto rappresentare altro che un’eresia nei confronti di pratiche politiche e forme organizzative troppo statiche perché legate a cicli precedenti di lotta. Tipica, da questo punto di vista, la sottolineatura di come l’azione di Lenin, l’uomo di Kamo, e del bolscevismo avesse rappresentato una straordinaria e vincente rottura con le modalità organizzative e di pensie ro dell’ormai corrotta Seconda Internazionale.
In questo senso, quindi, i militanti rivoluzionari non possono far altro, per potersi ritenere tali, che collocarsi sul filo del tempo, altra definizione tratta dalla Sinistra Comunista1. Non farlo significherebbe, per Quadrelli, essere irreparabilmente condannati al fallimento, all’inutilità e a un rapido e meritato oblio.
In un mondo in cui il capitalismo per mantenere il proprio dominio e realizzare i propri profitti deve continuare a rinnovare le condizioni della produzione e rompere con qualsiasi barriera di carattere nazionale, geografico, politico, economico, militare, tecnologico ed economico, approfittando di qualsiasi occasione per rafforzare la propria posizione politica-militare e di mercato, i militanti della rivoluzione devono rimanere al passo coi tempi e cogliere ogni momento in cui una crepa di crisi si apra in maniera significativa.
In questo occorre farsi barbari, non per genuflessione nei confronti dei nuovi stili di vita, organizzazione e lotta creati o importati, spesso tutti e due, da una nuova composizione di classe, ma per forzare la Storia là dove questa, secondo le interpretazioni più deterministiche, tende a farsi ostacolo del rivolgimento sociale e del cambiamento radicale.
In questo il russo Lenin si è fatto barbaro: non per appartenenza, nazionale, linguistica o etnica, ma per aver saputo gcogliere il momento, l’opportunità offerta dagli eventi derivati prima dal 1905, e alla prima disfatta militare dell’impero zarista ad opera della nascente potenza nipponica, e successivamente, e in maniera decisiva, dal disastro prodotto dalla Prima guerra mondiale con il suo corollario di rivolte e diserzioni tra i militari, gli scioperi delle operaie edegli operai di Pietroburgo, il pronunciamento delle guarnigioni della stesa città e il subbuglio nel mondo contadino. Tutti avvenimenti che, come la stessa storia di quegli anni, furono affrontati in maniera differente, e sostanzialmente, controrivoluzionaria, da menscevichi e socialisti-rivoluzionari.
Un Lenin che si fa barbaro agli occhi della tradizione marxista e della seconda internazionale, anche perché sa recuperare gli elementi di soggettività e di forzatura presenti nella passata esperienza del populismo russo2. Superato certamente nelle concezioni politiche, ma non nella capacità di agire, anche apparentemente contro la storia. Processo attraverso cui occorre individuare per tempo la linea di tendenza del moto sociale per definire la linea di condotta necessaria alla sua evoluzione politica e, non dimentichiamolo mai, militare.
E qui, se si vuole, si giunge un po’al nocciolo di quanto generalmente espresso dal comunista genovese: l’azione soggettiva in grado di appropriarsi delle condizioni oggettive non per assecondarle, secondo la tradizione del determinismo più becero, ma per ribaltarle nel loro contrario. Perché in questo deve consistere la Rivoluzione: ribaltare il presente per trasformarlo in un differente e più avanzato futuro. Spronando il ronzino della storia fino a farlo schiantare, come avrebbe saputo meglio riassumere poeticamente Vladimir Majakovskij.
Si tratta di una serie di 136 articoli pubblicati, proprio sotto il titolo Sul filo del tempo, da Amadeo Bordiga tra il 1949 e il 1955, prima sul giornale Battaglia comunista e successivamente, a seguito della frattura avvenuta all’interno del Partito comunista internazionale, su il programma comunista. Tutti attualmente disponibili sul sito N+1 e rintracciabili qui. ↩
A proposito delle simpatie espresse da Marx nei confronti dei terroristi russi si veda E. Cinnella, L’altro Marx. Una biografia, dellaporta editori, Pisa-Cagliari 2024. ↩



