di Sandro Moiso
 All’inizio degli anni novanta a Viareggio, durante una delle prime edizioni del “Noir in Festival”, ebbi occasione di intervistare James Ballard. Di quella video-intervista, della durata di circa un’ora, per una serie di disguidi alla fine non se ne fece nulla, ma sicuramente alcuni dei temi trattati all’epoca con il grande autore inglese sono rimasti scolpiti nella mia memoria.
All’inizio degli anni novanta a Viareggio, durante una delle prime edizioni del “Noir in Festival”, ebbi occasione di intervistare James Ballard. Di quella video-intervista, della durata di circa un’ora, per una serie di disguidi alla fine non se ne fece nulla, ma sicuramente alcuni dei temi trattati all’epoca con il grande autore inglese sono rimasti scolpiti nella mia memoria.
E i tragici avvenimenti svoltisi nei giorni scorsi a Barcellona e in Catalonia sono serviti a farmeli rammentare
In particolare alcuni riguardanti sia l’utilità o meno di scrivere ancora romanzi e racconti di fantascienza in un mondo che sembra avere realizzato molti dei presupposti dei suoi autori originari e più originali, sia una delle sue opere più celebri, osannata e criticatissima allo stesso tempo, portata sullo schermo da David Cronenberg nel 1996: “Crash”.
Lo stesso Ballard, a quell’epoca si dimostrò restio a parlare di un’opera, pubblicata per la prima volta nel 1973, che egli definì, insieme all’altrettanto celebre La mostra delle atrocità, frutto di un periodo particolare della sua vita. Soltanto in seguito, nella sua autobiografia comparsa un anno prima della sua morte avvenuta nel 2009, sarebbe tornato con più dettagli e motivi di orgoglio sulla stessa.1
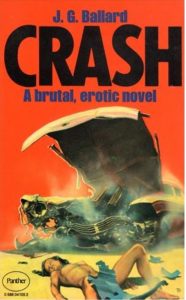 In quel romanzo si rivelava come la differenza che separa la curiosità per gli incidenti d’auto o le tragedie della strada dallo sguardo voyeuristico suscitato dall’erotismo e dalla pornografia sia, a tratti, tanto sottile da risultare irrilevante. In fin dei conti sempre di corpi in pose inaspettate o sorprendenti si tratta, in cui i più intimi umori dei corpi si mescolano con l’asfalto e con l’acciaio, invece che con quelli di altri corpi fatti di carne, ossa e sangue.
In quel romanzo si rivelava come la differenza che separa la curiosità per gli incidenti d’auto o le tragedie della strada dallo sguardo voyeuristico suscitato dall’erotismo e dalla pornografia sia, a tratti, tanto sottile da risultare irrilevante. In fin dei conti sempre di corpi in pose inaspettate o sorprendenti si tratta, in cui i più intimi umori dei corpi si mescolano con l’asfalto e con l’acciaio, invece che con quelli di altri corpi fatti di carne, ossa e sangue.
Nel testo si incrociavano e rimescolavano tanto la volontà di affermazione di alcuni dei suoi protagonisti, attraverso la ricerca di una morte violenta che coinvolgesse altri individui ed altri corpi, quanto la curiosità di spettatori casuali oppure recatisi appositamente sul posto per assistere all’evento.
“ Vaughn sognava di berline di ambasciatori schiantatisi contro autobotti inarcate, di tassì pieni di bambini festosi scontratisi frontalmente sotto le vetrine sfolgoranti di supermercati deserti.[…] Immaginava tamponamenti immani di nemici giurati, morti di esseri odiosi celebrati tra le fiamme del carburante lingueggianti nelle cunette laterali, in un ribollire di vernice sullo sfondo dello smorto sole pomeridiano di città provinciali […] Su queste collisioni, Vaughn elaborava variazioni infinite”2
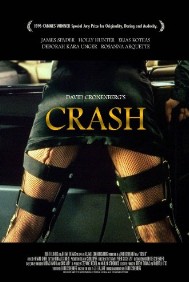 Mentre tutto intorno le macchine vengono circondate “da una cerchia di spettatori, i volti silenziosi fissi […] Lungo la Western Avenue si formò un ingorgo imponente, e si udì un urlio di sirene mentre gli abbaglianti della polizia lampeggiavano contro i paraurti posteriori dei veicoli fermi in coda […] La moglie del morto, sempre sostenuta dalla cintura di sicurezza, stava riprendendo i sensi. Un gruppetto di persone – un autista di camion, un soldato fuori servizio in divisa e una venditrice di gelati – stava con le mani premute contro i finestrini della sua auto, e pareva toccarle parti del corpo […] Per un istante mi parve di essere con lei, il protagonista del momento culminante di un truce dramma di teatro tecnologico improvvisato”3
Mentre tutto intorno le macchine vengono circondate “da una cerchia di spettatori, i volti silenziosi fissi […] Lungo la Western Avenue si formò un ingorgo imponente, e si udì un urlio di sirene mentre gli abbaglianti della polizia lampeggiavano contro i paraurti posteriori dei veicoli fermi in coda […] La moglie del morto, sempre sostenuta dalla cintura di sicurezza, stava riprendendo i sensi. Un gruppetto di persone – un autista di camion, un soldato fuori servizio in divisa e una venditrice di gelati – stava con le mani premute contro i finestrini della sua auto, e pareva toccarle parti del corpo […] Per un istante mi parve di essere con lei, il protagonista del momento culminante di un truce dramma di teatro tecnologico improvvisato”3
Una sensazione che i servizi speciali dei media trasmessi a spron battuto in occasione dell’attacco di Barcellona, o di qualsiasi altro attacco terroristico messo in atto con mezzi di fortuna spesso a quattroruote, hanno contribuito progressivamente ad ampliare. Insieme alla paura dell’imprevisto, dell’altro, del terrorista giunto ormai ad essere incarnazione assoluta del male che minaccia questa società perfetta fatta di svaghi, turismo, relax e corpi da esporre, sia vivi che morti, allo sguardo famelico del pubblico e dei media.
 Un voyeurismo mediatico che, nella sua totale inconsistenza, si incrocia con il delirio autodistruttivo di una generazione cresciuta nelle periferie delle metropoli europee, che del nichilismo ha fatto la propria bandiera e che nell’atto finale, spesso annunciato, spera di trovare il significato di un’intera esistenza segnata dall’alienazione individuale, sociale ed economica.
Un voyeurismo mediatico che, nella sua totale inconsistenza, si incrocia con il delirio autodistruttivo di una generazione cresciuta nelle periferie delle metropoli europee, che del nichilismo ha fatto la propria bandiera e che nell’atto finale, spesso annunciato, spera di trovare il significato di un’intera esistenza segnata dall’alienazione individuale, sociale ed economica.
Lo sguardo delle telecamere sui corpi stesi a terra e sulle vetture della polizia oppure sull’eliminazione e sui cadaveri degli “assalitori” eguaglia la ricerca della perfezione formale della propria morte e di quella delle anonime vittime messa in atto da ragazzi la cui età è quasi sempre compresa tra i venti e i trent’anni, se non meno come nel caso del gruppo che ha agito a Barcellona.
Un’autentica pornografia della morte che fotografa il disfacimento di unna società e di una civiltà che si vorrebbero eterne. E che tali non possono e non hanno mai potuto essere.
Un voyeurismo che dimentica la vita oppure che si accontenta di un simulacro della stessa, sia quando difende la società dello spettacolo e del consumo sia quando sceglie la via del martirio per negarla in nome di un altro ideale. Altrettanto alienante.
Un’esposizione mediatica che in entrambi i casi cerca e crea l’evento: sia che si tratti delle fasulle manifestazioni di riaffermazione della vita sulle piazze delle stragi, sia che si tratti della celebrazione on-line dei propri “martiri” e delle operazioni militari messe in atto dai giovani aspiranti suicidi. Mentre in entrambi i casi il discorso nazionalista o religioso trionfa sulla vita degli individui, ridotti a burattini disarticolati e impauriti oppure assetati di vendetta.
Fin dai suoi inizi come scrittore James Ballard aveva sempre rifiutato la fantascienza dell’outer space per concentrarsi principalmente sull’inner space, lo spazio interiore, e le autentiche catastrofi psichiche e sociali che derivano dall’incontro tra il malessere individuale e le trasformazioni fuori controllo operanti nella società e nell’ambiente che lo circondano. Narrazioni in cui nessuna verità e spiegazione può essere definitiva e il cui destino è quello di continuare ad essere modificata dai processi messi in atto dalla crisi che esplode nel momento in cui individui alienati decidono di affrontare situazioni che si riveleranno ingestibili, non sottomettendosi o ribellandosi alle stesse.
 Certamente, se l’autore inglese ne avesse avuto il tempo, avrebbe arricchito il suo viaggio nello spazio interno di altre variabili. La sua non-fantascienza dopo aver parlato di un pianeta affogato, di incubi di cemento armato, di bambini che diventano terroristi sterminando le proprie famiglie benestanti, di movimenti fascisti che nascono nelle cattedrali della merce che sorgono nelle periferie londinesi, di piccoli borghesi che scelgono l’omicidio come via di fuga dalla banalità dell’esistente e di rivolte armate che scoppiano nei quartieri residenziali si sarebbe arricchita di paesaggi urbani in stato di assedio contro un nemico anonimo, imprevedibile e soprattutto interno.
Certamente, se l’autore inglese ne avesse avuto il tempo, avrebbe arricchito il suo viaggio nello spazio interno di altre variabili. La sua non-fantascienza dopo aver parlato di un pianeta affogato, di incubi di cemento armato, di bambini che diventano terroristi sterminando le proprie famiglie benestanti, di movimenti fascisti che nascono nelle cattedrali della merce che sorgono nelle periferie londinesi, di piccoli borghesi che scelgono l’omicidio come via di fuga dalla banalità dell’esistente e di rivolte armate che scoppiano nei quartieri residenziali si sarebbe arricchita di paesaggi urbani in stato di assedio contro un nemico anonimo, imprevedibile e soprattutto interno.
Così mentre i media si accontentano di definire il nemico come islamico-radicale o fascio-islamista e di cantare la prevedibile fine dell’ISIS sul fronte militare siriano, dimenticano, o forse non immaginano neppure, che il male sia più profondo. Un male sociale che fa blindare le città e che militarizza i comportamenti quotidiani, ma che non può essere affrontato e risolto rimanendo all’interno delle stesse logiche di sfruttamento e di consumismo che l’hanno causato.
Al contrario le istituzioni internazionali si crogiolano invece nell’idea di far dimenticare tutte le proprie malefatte sventolando il vessillo dell’unità contro il terrorismo e il corrotto Rajoy può affermare che “il terrorismo è il problema più grande per l’Europa”, sviluppando narrazioni dei fatti in cui è impossibile rintracciare anche solo un filo di verità o di ricostruzione logica. Gli attentatori erano quattro, cinque, nove, dodici? Sono stati tutti eliminati oppure qualcuno è ancora in fuga? L’uomo assediato che aveva preso con sé degli ostaggi in un ristorante turco della Boqueria subito dopo l’attentato sulla Rambla è davvero esistito? E allora che fine ha fatto? Non chiedetelo, non lo sanno nemmeno gli inquirenti e gli autori delle veline mediatiche. Il cui unico interesse è quello di ridurre l’attenzione degli spettatori ad uno sguardo morboso sui fatti, visti attraverso lo spioncino del body count e del dolore dei parenti delle vittime e dei sopravvissuti piuttosto che aprire una finestra sulla storia e la società per cambiare, finalmente, aria.
 Ossessionati dall’idea del nemico esterno, di altra razza, religione e cultura (magari nord-africano, magrebino, arabo oppure semplicemente di origine marsigliese) i soliti commentatori, i soliti esperti, i soliti docenti universitari si stupiscono che i giovani attentatori, così determinati e quindi pericolosi, ascoltino la musica rap, bevano e possano frequentare gli stessi locali frequentati da altri giovano che poi diverranno le loro potenziali vittime. L’ossessione securitaria e di controllo imperialista nasconde alla vista ciò che è così semplice vedere: vittime e carnefici appartengono allo stesso mondo, sono sinonimi dello stesso paradigma basato sullo sviluppo ineguale. In cui periferie e metropoli non sono più distanti migliaia di chilometri, ma sorgono sullo stesso territorio. Mentre uno dei territori di origine di una parte degli attentatori, il Marocco, non è davvero così pacificato dalla monarchia ed è, allo stesso tempo, fortemente dipendente dal neo-colonialismo della Spagna e dalla sua economia.
Ossessionati dall’idea del nemico esterno, di altra razza, religione e cultura (magari nord-africano, magrebino, arabo oppure semplicemente di origine marsigliese) i soliti commentatori, i soliti esperti, i soliti docenti universitari si stupiscono che i giovani attentatori, così determinati e quindi pericolosi, ascoltino la musica rap, bevano e possano frequentare gli stessi locali frequentati da altri giovano che poi diverranno le loro potenziali vittime. L’ossessione securitaria e di controllo imperialista nasconde alla vista ciò che è così semplice vedere: vittime e carnefici appartengono allo stesso mondo, sono sinonimi dello stesso paradigma basato sullo sviluppo ineguale. In cui periferie e metropoli non sono più distanti migliaia di chilometri, ma sorgono sullo stesso territorio. Mentre uno dei territori di origine di una parte degli attentatori, il Marocco, non è davvero così pacificato dalla monarchia ed è, allo stesso tempo, fortemente dipendente dal neo-colonialismo della Spagna e dalla sua economia.
E’ l’alienazione sociale e identitaria prodotta dalla società dei consumi e dell’estrazione del plusvalore da ogni attività umana ad essere alla base tanto della ricerca di comunità che si esprime nell’attentatore jihadista attratto dalla umma quanto dei comportamenti svagati e inconsapevoli indotti dalle pubblicità della Coca Cola e di tutti gli altri prodotti assolutamente inutili rivolte ai giovani, e meno giovani, consumatori.
Non si tratta dunque di scegliere una delle due immagini riflesse dallo stesso specchio, ma di rompere lo specchio. La difesa della civiltà occidentale e dei suoi sacri valori sembra invece prevalere nei commenti e finisce con l’esaltare comportamenti antagonisti destinati a prolungare nei decenni a venire l’autentica guerra civile in cui abbiamo iniziato da tempo a vivere. Con buona pace di chi pensa che una tale guerra possa essere vinta da qualcuno.
Posso solo ricordare che gli operai della Renault di Flins negli anni sessanta e settanta non si riconoscevano su basi etniche o religiose, ma soltanto sulle basi dell’autonomia di classe che durante le lotte dell’epoca accomunava lavoratori europei e nord-africani. La perdita di quell’identità di classe, di quella comunità di lotta, che ha marcato la vittoria del turbo-capitalismo finanziario degli ultimi decenni, ha anche segnato il divenire di una società in cui la guerra civile tra differenti gruppi, che pur le appartengono, sarà la norma. Come, purtroppo, il successivo attacco in Finlandia ha contribuito a confermare.
 A meno che, come nel magnifico finale de La terra dei morti viventi del grande George Romero recentemente scomparso, gli esclusi e gli oppressi sappiano riconoscersi in quanto tali e, anche senza dover obbligatoriamente collaborare, convivere in contrasto con il loro vero ed unico nemico.
A meno che, come nel magnifico finale de La terra dei morti viventi del grande George Romero recentemente scomparso, gli esclusi e gli oppressi sappiano riconoscersi in quanto tali e, anche senza dover obbligatoriamente collaborare, convivere in contrasto con il loro vero ed unico nemico.
(Si rammenta a tutti i lettori che la responsabilità per le opinioni contenute nel testo è da attribuire esclusivamente all’autore e non alla redazione di Carmilla nel suo insieme – S.M. )



