di Sandro Moiso
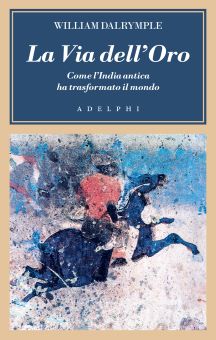 William Dalrymple, La Via dell’Oro. Come l’India antica ha trasformato il mondo, traduzione di Svevo D’Onofrio, Adelphi Edizioni, Milano 2025, pp.555, euro 35,00
William Dalrymple, La Via dell’Oro. Come l’India antica ha trasformato il mondo, traduzione di Svevo D’Onofrio, Adelphi Edizioni, Milano 2025, pp.555, euro 35,00
Con il termina al-Hind i primi scrittori arabi indicarono tutto ciò che si trovava a est del fiume Indo e compresero chiaramente l’unità di una vasta superficie terracquea, estesa dall’Hindu Kush al Pacifico, riconoscendo in essa una regione dalle caratteristiche omogenee. Quella che oggi dovremmo riconoscere, anche qui in Occidente come indosfera, ma che ancora tarda ad essere riconosciuta come tale.
In un momento di declino della centralità economica, politica e culturale dei paesi europei e degli Stati Uniti stessi, spesso si immagina un nuovo ordine multipolare in cui, troppo spesso, sembrano ergersi soltanto, o quasi, altre due aree di significativa influenza, Cina e, per quanto bistrattata, Russia. Tralasciando, e sarebbe qui inutile spiegare ancora una volta le radici coloniali e “razziali” di tale dimenticanza, di comprendere tra queste almeno anche l’India.
Quel sub-continente che ancora oggi, pur comprendendo una porzione significativa della popolazione mondiale e delle attività collegate agli aspetti più avanzati della modernità digitale, spesso è visto soltanto come una vasta area di arretratezza sociale ed economica su cui lo sguardo mediatico e dell’immaginario collettivo sembra posarsi ancora come ai tempi dell’impero coloniale britannico e dei suoi cantori alla Rudyard Kipling oppure, per rimanere più vicini a noi, con gli occhi del Capitano Salgari. Eppure, eppure…
Almeno la letteratura ha iniziato a cogliere gli elementi di novità, spesso di carattere tecnologico, presenti alle spalle degli aspetti più retrogradi del nazionalismo hindu, rappresentato dall’attuale capo del governo, Narendra Damodardas Modi, dalla ancora diffusa violenza sulle donne o del cinema di Bollywood. E lo ha fatto, guarda caso, ancora una volta con generi d’evasione come ai tempi di Salgari, in particolare nell’ambito della fantascienza e della fantapolitica.
Per questo motivo, e per non rubare troppo spazio al proseguimento della recensione del testo di Darlymple, vale la pena di ricordare qui soltanto alcuni testi, più o meno recenti. Il primo è I giorni di Cyberabad di Ian McDonald1, in cui lo scrittore scoto-irlandese immagina e descrive l’India del 2047. Una nuova superpotenza abitata da un miliardo e mezzo di persone nell’era dell’IA, fratturata in una dozzina di stati in cui, accanto allo sviluppo delle attività legate alla programmazione e alla economia della comunicazione digitale, nascono dee-bambine e si celebrano matrimoni tra uomini e IA.
Uno un po’ meno recente è La vacca sacra (Sacred Cow, 1993), un racconto breve contenuto in un’antologia dell’autore cyberpunk americano Bruce Sterling2, in cui lo scrittore immagina, con ironia e senso dell’anticipazione, una compagnia cinematografica indiana intenta a realizzare un film nella ex—potenza coloniale inglese, dove i costi di lavorazione, a causa della decadenza economica e della crisi sociale e politica, sono molto inferiori a quelli dell’India ormai sviluppata e più ricca.
Ma è certamente 2034 di Elliot Ackerman e James Stavridis3 a costituire il motivo di maggiore interesse, anche alla luce dei conflitti che si delineano, con sempre minore possibilità di essere arrestati diplomaticamente, all’orizzonte e sul breve periodo. Stavridis è un ammiraglio con una prestigiosa carriera militare, politica e giornalistica, mentre Ackermann, prima di sfornare best seller, ha prestato servizio nei Marines e nelle Forze Speciali. Insieme immaginano, nell’anno che da il titolo al romanzo, una devastante guerra nucleare tra Stati Uniti e Cina in cui, però, a svolgere un decisivo ruolo dirimente sarà proprio l’India che, anzi, sarà l’unica nazione a uscire rafforzata e vincente dal conflitto tra le altre due superpotenze. Ruolo svolto sia attraverso il soft power che per l’arsenale nucleare rimasto intatto e minaccioso, fatti entrambi valere sulle rovine economiche e politiche di ciò che resta, dopo pochi giorni di guerra, dei due “imperi” nemici.
Visioni, tutte, di un futuro in cui l’India sembrerebbe o potrebbe riprendere un ruolo politico, economico e culturale già avuto per almeno un millennio nella storia del globo o anche soltanto di quella parte che si è qui precedentemente definita come “indosfera”, le cui radici vengono ampiamente analizzate e descritte nel magnifico testo di William Darlymple edito da Adelphi.
Durante gran parte del Basso Medioevo e dell’Età moderna, l’India fu profondamente influenzata da elementi culturali provenienti dall’esterno dei suoi confini. In seguito all’istituzione di una serie di sultanati islamici tra il XII e il XIII secolo, il persiano divenne la lingua ufficiale del governo
in gran parte del Subcontinente e i modelli culturali persiani – nell’arte, nell’abbigliamento, nel galateo – si affermarono persino nelle corti indù dell’India meridionale. Successivamente, nel XIX secolo, con l’ascesa della Compagnia delle Indie Orientali e dell’Impero britannico, l’inglese sostituì progressivamente il persiano e l’India entrò a far parte dell’anglosfera. Per progredire socialmente divenne indispensabile padroneggiare l’inglese e gli indiani che aspiravano a farsi strada dovettero rinunciare, o relegare in secondo piano, aspetti rilevanti della propria cultura, trasformandosi in « Sahib bruni » anglofoni […] Eppure, nel millennio e mezzo precedente, dal 250 a.C. al 1200 d.C. circa, l’India era stata una fiera esportatrice della propria variegata civiltà, fino a creare intorno a sé un impero delle idee – una vera e propria «indosfera» – dove la sua influenza culturale risultava predominante. Durante questo periodo, il resto dell’Asia fu il destinatario consenziente e persino entusiasta di un colossale trasferimento di soft power indiano, in ambiti come la religione, l’arte, la musica, la danza, la tessitura, la tecnologia, l’astronomia, la matematica, la medicina, la mitologia, la lingua e la letteratura.
[…] Dall’India non giungevano soltanto figure pionieristiche di mercanti, astronomi e astrologi, scienziati e matematici, medici e scultori, ma anche santi, monaci e missionari appartenenti a diversi filoni di pensiero religioso: l’induismo (o sanatana dharma, come alcuni preferiscono chiamarlo), nelle sue declinazioni vedica, shivaita e vishnuita, e il buddhismo delle tradizioni theravada, mahayana e tantrica. […] Al giorno d’oggi, più di metà della popolazione mondiale vive in aree in cui le idee religiose e culturali indiane sono, o sono state, preponderanti, e dove un tempo le divinità indiane dominavano l’immaginazione e le aspirazioni di uomini e donne. Al tempo stesso, l’influenza intellettuale dell’India si è estesa verso occidente, consegnandoci non solo nozioni matematiche cruciali, come lo zero, ma anche la forma stessa dei numeri che tuttora utilizziamo – probabilmente la cosa più simile a una lingua universale che l’umanità abbia mai posseduto. Le conoscenze, i saperi e le intuizioni religiose dell’India antica sono una parte fondante del nostro mondo. […] In ambito scientifico, astronomico e matematico, l’India è stata maestra del mondo arabo e, per suo tramite, dell’Europa mediterranea4.
 William Benedict Hamilton-Dalrymple (classe 1965) è uno storico, giornalista, scrittore di viaggi, autore scozzese che vive tra Londra e Delhi ormai da molti anni. Per i suoi saggi sull’India e l’Oriente è stato insignito di numerosi premi letterari ed è membro della Royal Society of Literature e della Royal Asiatic Society. Tra le sue principali opere, pubblicate in Italia da Adelphi, vanno annoverate: Il ritorno di un re. La prima, catastrofica intromissione dell’Occidente in Afghanistan (2015); Nove vite (2020); Anarchia (2022) e, con Anita Anand, Koh-i-Nur. Sulle tracce della pietra ‘maledetta’: il Koh-i-Nur, «La montagna di luce» ( 2020). Mentre per Rizzoli editore ha in precedenza pubblicato: Dalla montagna sacra (1998), Il Milione (1999), In India (2000), Delhi (2001), Nella terra dei Moghul bianchi (2002) e L’assedio di Delhi. 1857 Lo scontro finale fra l’ultima dinastia Moghul e l’impero britannico (2007).
William Benedict Hamilton-Dalrymple (classe 1965) è uno storico, giornalista, scrittore di viaggi, autore scozzese che vive tra Londra e Delhi ormai da molti anni. Per i suoi saggi sull’India e l’Oriente è stato insignito di numerosi premi letterari ed è membro della Royal Society of Literature e della Royal Asiatic Society. Tra le sue principali opere, pubblicate in Italia da Adelphi, vanno annoverate: Il ritorno di un re. La prima, catastrofica intromissione dell’Occidente in Afghanistan (2015); Nove vite (2020); Anarchia (2022) e, con Anita Anand, Koh-i-Nur. Sulle tracce della pietra ‘maledetta’: il Koh-i-Nur, «La montagna di luce» ( 2020). Mentre per Rizzoli editore ha in precedenza pubblicato: Dalla montagna sacra (1998), Il Milione (1999), In India (2000), Delhi (2001), Nella terra dei Moghul bianchi (2002) e L’assedio di Delhi. 1857 Lo scontro finale fra l’ultima dinastia Moghul e l’impero britannico (2007).
Pur non essendo certo ispirata dai post colonial studies, all’interno della sua opera, oltre a ricostruire anche da storico dell’arte quale è lo splendore della civiltà indiana passata, non manca mai l’occasione di sottolineare le violenta trasformazione e lo sfruttamento imposto dall’impero britannico e dalla Compagnia delle Indie sulla società, la cultura, l’economia e le tradizioni politiche e religiose del sub-continente indiano. Un’attenzione che, un po’ come quella di Rudyard Kipling, decisamente più ispirata però da una percezione di stampo ancora coloniale, deriva dal suo incontro con l’India a partire dalla gioventù.
Il mio primo contatto con Delhi avvenne quando avevo diciotto anni: vi giunsi nella nebbiosa notte invernale del 26 gennaio 1984. […] Non sapevo assolutamente nulla dell’India.
Avevo trascorso l’infanzia nella Scozia rurale, sulle sponde del Firth of Forth, e tra i miei compagni di scuola ero probabilmente quello che aveva viaggiato di meno. I miei genitori erano convinti di vivere nel luogo più bello che si potesse immaginare, e di rado ci portavano in vacanza, a parte un’annuale gita primaverile in un angolo delle Highlands scozzesi, anche più fredde e umide di casa nostra. Forse per questa ragione Delhi ebbe su di me un effetto maggiore e più sconvolgente di quanto avrebbe avuto su adolescenti più cosmopoliti.
[…] Ormai da oltre vent’anni divido il mio tempo fra Londra e Delhi, e la capitale indiana resta la mia città preferita. E’ soprattutto il rapporto della città con il suo passato che continua ad affascinarmi: tra le più grandi città del mondo, solo Roma, Istanbul e Il Cairo possono pretendere di rivaleggiare con Delhi per l’ampiezza e il numero dei resti storici5.
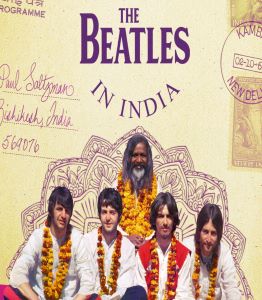 Un interesse che è tutt’altro che organizzato intorno all’esotismo o alla nostalgia di un passato che non c’è più, ma tutto rivolto a collegare la storia di un paese immenso, che già attrasse l’attenzione e le velleità espansionistiche di Alessandro Magno, con le sue proiezioni sul presente, soprattutto sulla cultura occidentale e asiatica. Senza, naturalmente, passare attraverso le curiosità di stampo new age o hippy che troppo spesso hanno suscitato la vacua attenzione del pubblico occidentale.
Un interesse che è tutt’altro che organizzato intorno all’esotismo o alla nostalgia di un passato che non c’è più, ma tutto rivolto a collegare la storia di un paese immenso, che già attrasse l’attenzione e le velleità espansionistiche di Alessandro Magno, con le sue proiezioni sul presente, soprattutto sulla cultura occidentale e asiatica. Senza, naturalmente, passare attraverso le curiosità di stampo new age o hippy che troppo spesso hanno suscitato la vacua attenzione del pubblico occidentale.
Così come l’autore fa nell’ultimo testo pubblicato da Adelphi, ma uscito in lingua originale nel 2024, in cui le dieci storie che compongono gli altrettanti capitoli seguono le rotte marittime che per secolo permisero la diffusione della cultura e della scienza indiana, insieme alle ricchezze del sub-continente, di diffondersi nel resto del mondo attraverso la Via dell’Oro che dà il titolo all’opera.
Grazie ai venti del monsone asiatico, l’India si trova al centro di una vasta rete di rotte marittime e commerciali navigabili. Ogni estate, il riscaldamento dell’altopiano tibetano genera un’area di bassa pressione che attira i venti freschi e umidi dal Golfo del Bengala. Ogni inverno, al contrario, venti freddi e secchi spirano dalle nevi dell’Himalaya verso i caldi mari circostanti. La penisola indiana è situata nel mezzo di questo vortice di venti che soffiano in una direzione per sei mesi all’anno e si invertono nei sei mesi successivi. La regolarità e la prevedibilità di questo fenomeno naturale danno origine ai monsoni, che per millenni hanno permesso ai marinai indiani di spiegare le vele e lanciarsi negli oceani circostanti, per poi rientrare in sicurezza quando i venti si invertivano.
Gli antichi mercanti indiani sfruttavano le vie marittime dell’Asia monsonica per viaggiare in due direzioni. Molti si dirigevano a ovest, approfittando dei venti invernali, fino alle coste orientali dell’Africa e ai prosperi regni dell’Etiopia. Qui si trovavano dinanzi a una scelta: seguire il ramo settentrionale, che attraverso il Golfo Persico conduceva in Iran e in Mesopotamia, oppure il ramo meridionale, che attraverso il Golfo di Aden li portava nel Mar Rosso e in Egitto. I mercanti diretti a ovest arrivavano con gli alisei all’inizio dell’estate e tornavano in India con il monsone estivo in agosto. Con i venti a favore, la navigazione dalla bocca del Mar Rosso al Gujarat richiedeva appena quaranta giorni. Tuttavia, perdere i venti poteva prolungare il viaggio di andata e ritorno fino a un anno, costringendo i mercanti a una lunga vacanza forzata in riva al Nilo. Il percorso terrestre equivalente, attraverso l’Afghanistan con carovane di cammelli, richiedeva almeno il triplo del tempo.
Per circa tre secoli, a partire dalla battaglia di Azio del 31 a.C. e dalla successiva integrazione dell’Egitto nel sistema imperiale romano, le principali arterie commerciali tra Oriente e Occidente non furono le rotte terrestri, spesso sbarrate dal conflitto tra Roma e i Parti, bensì la Via dell’Oro dei mari aperti, che solcava le turbolente acque del Mar Rosso e dell’Oceano Indiano (W. Dalrymple, op. cit., pp. 17-18. )).
Una storia, quella ricostruita da Dalrymple che, per motivi diversi e con modalità narrative differenti, si affianca a quella della Via della Seta, tra Cina e Occidente, che è stata ricostruita da Peter Frankopan, docente di Storia bizantina all’Università di Oxford, senior research fellow al Worcester College e direttore dell’Oxford Centre for Byzantine Research, in tempi quasi altrettanto recenti (2015)6. Due ricostruzioni utilissime per comprendere come la pretesa centralità politica ed economica, oltre che culturale, dell’Occidente non rappresenti altro che una momentanea illusione di stampo coloniale una volta messa a confronto con i tempi lunghi e lunghissimi della storia planetaria.
Motivo per cui, avvicinandosi il momento della necessaria chiusura di questa recensione, vale almeno la pena di ricordare la storia narrata, a partire dallo sperduto sito archeologico di Mes Aynak, tra le cui grotte si era nascosto in tempi più recenti Osama Bin Laden, nel terzo capitolo di La Via dell’Oro, intitolato Il grande re, re dei re, figlio di dio, di un antico impero formatosi tra le montagne dell’attuale Afghanistan, ad opera di un popolo nomade di pastori, quello dei Kushana, che costituì una fondamentale occasione per la diffusione del buddhismo dall’India verso la Cina e uno snodo importante per i rapporti dell’Asia centrale con l’impero romano.
I Kushana in origine erano un popolo di pastori nomadi indoeuropei che si spostavano tra le oasi desertiche dell’Asia centro-orientale. Gli antichi imperi cinesi li conoscevano inizialmente come Yuezhi. I loro autoritratti su monete e sculture li raffigurano come uomini di corporatura robusta, all’apparenza di ceppo iranico. […] Intorno al 160 a.C. gli Yuezhi/Kushana migrarono verso sud, forse a causa dell’espansione dell’Impero cinese Han, e si stabilirono nell’odierno Afghanistan. Qui finirono col sopraffare gli ultimi greci di Battriana, i discendenti dei macedoni che erano rimasti bloccati nella regione dopo la prematura morte di Alessandro Magno e la disgregazione del suo impero.
[…] Col passare del tempo, i Kushana si lasciarono definitivamente alle spalle le loro radici tribali scitiche e nomadiche e adottarono diversi aspetti dell’ellenismo stanziale dei loro predecessori greci di Battriana, le cui monete iniziarono presto a imitare. Al tempo stesso, i Kushana si ispirarono anche alle tradizioni dei Parti, che allora dominavano le pianure della Persia orientale. In tal modo, finirono con l’abbracciare un pantheon insolitamente ampio, come testimoniano le loro monete che raffigurano più di trenta divinità provenienti dalle diverse tradizioni religiose presenti nei loro domini. E a misura che i Kushana si espandevano verso sud, il loro culto pubblico si orientava sempre più verso le divinità, le religioni e le filosofie dell’India.
Paradossalmente, l’ascesa del buddhismo indiano in Asia Centrale sembra essere iniziata proprio nel momento in cui gli eserciti kushana marciavano verso sud in direzione dell’India. Le conquiste dei Kushana, infatti, anziché isolare il Subcontinente, aprirono i passi un tempo invalicabili dell’Hindu Kush, permettendo ai monaci buddhisti di attraversarli nella direzione opposta e, col tempo, di costruire cappelle, stupa e monasteri, convertendo gradualmente le popolazioni locali alla propria fede. Alla fine, sarà proprio il patrocinio kushana del buddhismo a consentirgli di diffondersi in tutta l’Asia Centrale e fino in Cina.
[…] Fu solo con la conquista dei passi dell’Hindu Kush da parte dei Kushana tra il I e il II secolo d.C. e la conseguente intensificazione degli scambi commerciali attraverso le montagne, tra il Tagikistan e il porto fluviale di Barbarikon, presso l’odierna Karachi, che i mercanti buddhisti indiani iniziarono a stabilirsi nella regione in numero significativo7.
Proprio il prospero porto di Barbarikon, situato alla foce dell’Indo, avrebbe poi costituito un momento centrale degli scambi tra l’Asia Centrale e l’impero di Roma, bypassando il regno dei Parti che costituì sempre un severo ostacolo militare sia per l’espansione romana che dei regni e imperi dell’Asia centrale. Così, dopo l’incontro tra ambasciatori “indiani” e l’imperatore Traiano, ancora ricordato sulla Colonna Traiana dove gli emissari asiatici sono rappresentati mentre indossano turbanti e pantaloni, e dopo la promessa dei Romani di pagare i prodotti dei Kushana in oro, gli scambi tra l’Egitto romano e il regno afghano si svilupparono in maniera decisamente significativa.
Dai porti kushana come Barbarikon cominciò a transitare una gran quantità di beni di lusso occidentali, tra cui oro e vino romani, provenienti da Alessandria e dai porti del Mar Rosso; da lì risalivano l’Indo e raggiungevano le capitali settentrionali dei Kushana, come Taxila, Pushkalavati presso Peshawar, e Bagram, nelle pianure a nord di Kabul. A Pushkalavati è stata rinvenuta un’intera cantina vinicola colma di anfore romane, curiosamente situata accanto a un santuario buddhista8.
Dando via ad una sorta di globalizzazione dei commerci e delle conoscenze ben più antica di quella promossa con tanta enfasi negli ultimi decenni a partire dall’Occidente. Con buona pace dei suoi estimatori e dei suoi mentori politici e mediatici che ne sottolineano da sempre la “novità”.
Ed. originale: I. McDonald, Cyberabad Days (2009) ora tradotto in italiano nella collana «Urania Jumbo» n° 28, Mondadori Libri S.p.a., Milano febbraio 2022. ↩
B. Sterling, Un futuro all’antica, collana «Solaria» n° 9, Fanucci Editore, Roma, settembre 2000 (titolo originale: A Good Old-fashioned Future, 1999). ↩
Edito in Italia nel 2021 da SEM Editore. ↩
W. Dalrymple, L’indosfera, in La Via dell’Oro. Come l’India antica ha trasformato il mondo, Adelphi Edizioni, Milano 2025, pp. 14-17. ↩
W, Dalrymple, Introduzione a Delhi 1857. Lo scontro finale fra l’ultima dinastia Moghul e l’impero britannico, RCS Libri S.p.a., Milano 2007, pp. 16-18. ↩
Peter Frankopan, Le vie della seta. Una nuova storia del mondo, Mondadori, Milano 2017. ↩
W. Dalrymple, op. cit., pp. 102-106. ↩
Ibidem, p. 109. ↩



