di Paolo Lago
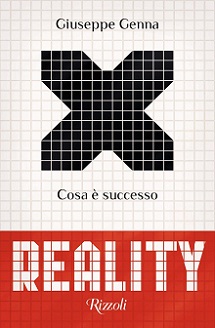 Giuseppe Genna, Reality. Cosa è successo, Rizzoli, Milano, 2020, pp. 317, € 19,00.
Giuseppe Genna, Reality. Cosa è successo, Rizzoli, Milano, 2020, pp. 317, € 19,00.
Un movimento continuo domina la narrazione dell’ultimo, interessantissimo romanzo di Giuseppe Genna, Reality. Cosa è successo: un movimento che si riflette nella struttura stessa del racconto, il quale si distende in una forma neopicaresca. Con “neopicaresco” intendo la ripresa novecentesca e contemporanea del genere picaresco, fiorito nella Spagna del XVI secolo e caratterizzato da uno spostamento continuo dalle tonalità basse e sordide senza un fine predeterminato. Se il neopicaresco novecentesco assume prevalentemente i tratti di un movimento positivo di scoperta – evidente soprattutto in Kerouac e nella beat generation – quello messo in funzione da Genna si caratterizza come uno spostamento a vuoto, declinato verso l’orrore e gli aspetti più terribili e sordidi della realtà. A monte, perciò, è possibile individuare la morfologia neopicaresca che caratterizza il Viaggio al termine della notte (1933) di Louis-Ferdinand Céline. Come quello di Céline, il movimento narrativo inscenato da Genna non conosce vie d’uscita ma carica su di sé l’orrore e la devastazione della realtà più sordida e meschina. Reality srotola una vera e propria cronaca dei momenti più terribili del “tempo virale” che ha investito (e continua a investire) l’Italia, nonché gran parte del mondo. Diverse date che si dipanano da febbraio a maggio, seguite dal numero dei contagiati da Covid e dal numero dei morti, sono poste all’inizio dei vari capitoli. Il “tempo virale” in cui l’Italia e, soprattutto, la Lombardia, era devastata dalla pandemia, nelle pagine di Reality, si trasforma in un vero e proprio tempo distopico. E distopico è anche l’universo tratteggiato. Milano e il suo hinterland, dove si svolge pressoché l’intera narrazione, si trasformano in una sorta di devastato mondo futuro solcato dalla desolazione e dall’orrore.
Il movimento continuo che caratterizza l’aspetto formale del libro è evidente fin dall’incipit, in cui l’allusione al celebre palindromo latino – in girum imus nocte et consumimur igni (“giriamo la notte e veniamo consumati dal fuoco”) – che costituisce anche il titolo di un film di Guy Debord del 1978, è contrassegnata da una prima persona plurale che, forse, rimanda a feriti e piagati notturni sovvertitori di un distopico ordine delle cose piombato improvvisamente sulle nostre vite: “Giriamo la notte divorati dal fuoco, consumati dalla vita e dall’ansia di non essere più noi giriamo e giriamo, per la città concentrica giriamo e facciamo questo: guardiamo. Siamo attoniti”. L’incessante movimento picaresco che caratterizza le azioni dell’io narrante entra in un antitetico contrasto con il regime di lockdown deciso dal potere, incarnato nella figura di Capomastro, il comandante dei gruppi investigativi speciali preposti a monitorare, a Codogno, la situazione dell’iniziale diffusione del virus. Se il lockdown impone immobilità e pervasivo controllo sociale, il narratore, che si presenta come una sorta di alter ego dell’autore, attua un movimento ipertrofico per sfuggire alle dinamiche del controllo.
Il verbo “giriamo”, che caratterizza lo spostamento incessante, si accompagna ad un altro importante verbo che, anche in seguito, marcherà a fuoco la narrazione: “guardiamo”. Poco sotto, infatti, così continua il racconto: “Guardiamo l’uomo, vediamo dio, che è oggettivo. Sono i giorni della piaga, della piaga celeste e terrestre”. Lo sguardo e la percezione caratterizzano in modo pregnante il narratore. Il racconto è infatti svolto tutto in prima persona e assume il valore e il dovere di una testimonianza. Il narratore è il testimone diretto di un tempo infernale, attraversato dalle esalazioni mefitiche di un virus mortale ma anche da più oscure e impalpabili logiche di potere. Significativa, in questo senso, è la risposta che l’io narrante si immagina di dare a Capomastro che gli chiede “che ci fai tu qui?”:
Devo vedere tutto, riportare tutto, ogni parola, ogni gesto compiuto, ogni tattica e ogni azione, comporre il tuo ritratto, descrivere le condizioni interne al carcere, interne ai reparti di terapia intensiva, interne a ogni appartamento di questa città infame, ogni appartamento ricco, ogni appartamento povero, stilare il bilancio, pensare all’oltre, immettermi ovunque, provocare qualsiasi reazione, amare intensamente e più profondamente odiare, confondere le acque e inventarmi una realtà che non c’è, restituire il senso della morte, infittire di parole tutto, tutto ciò che esiste, ogni respiro in affanno, i bronchi saturi di siero, i funerali interdetti, la molecola lunare del virus, le abiezioni prima e durante e dopo il contagio, dissuadere chiunque che esista un dopo il contagio, sollecitare le rivolte e vivere il male fino in fondo, stringere un mercuriale in mano, impersonare il monatto e il delatore e prendere le parti dell’abominio e sacralizzare la vita, le puttane, i preti, i più umili, i più disdicevoli tra noi, tutta l’ostetricia che fa venire alla luce il nuovo mondo, poi cancellarmi da qui, privo di nome e di risguardo, ignoto o ignorato, una sola voce lontana, solo offuscato, e piano piano andarmene.
Il carattere di testimonianza emerge nei gesti e nelle azioni che il personaggio si propone di attuare: una vera e propria ipertrofia di azioni che, nella forma rapida ed ellittica dell’elenco, potrebbero costituire un vero e proprio manifesto di tutto il romanzo, di tutta la cronaca terribilmente reale che l’autore si propone di mettere in scena. Si tratta di una testimonianza che, grazie alla rapidità e, quasi, all’invisibilità che caratterizza la figura dell’io narrante, sfugge repentina alle barriere erette per arginare gli spostamenti. La scrittura di matrice neopicaresca è essa stessa invisibile e sfuggente, in divenire continuo, senza radici, quasi come la scrittura di Kafka di cui parlano Deleuze e Guattari in Kafka. Per una letteratura minore.
Non a caso il titolo suona Reality e in esso possiamo sì incontrare un riferimento alla realtà, la volontà, appunto, di narrare la realtà senza troppi filtri edulcoranti ma anche un rimando ai reality televisivi, alla finta realtà spettacolare propinata agli spettatori delle televisioni. Non a caso, un capitolo si sofferma sulla figura del sindaco di Bergamo nonché sul suo passato di manager Fininvest e di direttore delle reti televisive berlusconiane, emblema dello spettacolo della cosiddetta “Milano da bere”. Il sindaco viene mostrato insonne, piegato dal dolore e dalla morte che ha orrendamente colpito la sua città. Egli stesso sembra diventare il simbolo di uno spettacolo che si è ribaltato nell’orrore, nella devastazione e nella morte, come se orrore, devastazione e morte fossero sempre stati lì presenti, l’altra orrenda faccia della società spettacolare (e sotto sotto qui ritroviamo una nuova allusione a Debord e alla sua Società dello spettacolo): “La tv verità, i reality show, i talent: tutto il diorama di un tempo adeguato alle sirene. Le sirene erano l’altra faccia dello spettacolo che aveva allestito nella vita precedente. Aveva ammaestrato un’intera nazione…”. Sembra che l’emergenza, l’orrore, la morte e la devastazione abbiano improvvisamente risvegliato una nazione addormentata nella diffusa spettacolarizzazione dell’esistenza. La Realtà, con l’iniziale maiuscola, ha fatto improvvisamente irruzione nella finta realtà sciorinata dalle appendici spettacolari che, a partire dagli anni Ottanta (perfetta conseguenza della società consumistica affrescata da Pasolini nei primi anni Settanta) hanno devastato la coscienza degli individui. Il virus, nelle pagine di Genna, funziona quindi come una sorta di meccanismo rivelatore della realtà e delle reali dinamiche sociali, come se fosse stato squarciato un velo di Maia.
Al centro del romanzo vi è anche lo spazio contemporaneo, sullo sfondo di quello spatial turn che connota nel profondo proprio la nostra contemporaneità. Lo spazio è divenuto una sorta di lente privilegiata attraverso cui osservare i più disparati risvolti sociali del nostro tempo. Mettendo in atto un esperimento di geopoetica (cioè una scrittura che presta attenzione ai luoghi e li carica di senso), l’autore pone Milano al centro della narrazione. E sono forse proprio la città di Milano e i suoi dintorni a diventare protagonisti di un tetro teatro narrativo che inscena una vera e propria geopoetica del disastro, il canto del cigno di un territorio devastato e incrudelito da anni e anni di industrializzazione e inquinamento selvaggio. Emblematico, in questo senso, è il ricordo di quando il narratore, da bambino, viene portato in gita alla fabbrica delle caramelle Galatine, a Codogno e quello spazio sembrava già contaminato da una catastrofe inquinante, quasi terribile come il disastro di Cernobil accaduto nel 1986. I bambini, al ritorno, ingozzatisi di Galatine, vomitano (metaforicamente e realmente) nel pullman quello stesso latte in polvere di cui erano fatte le caramelle, emblema del cibo ‘malato’ e industriale degli anni Settanta (non è un caso che il “girone della merda”, nell’apocalittico Salò o le centoventi giornate di Sodoma di Pasolini, alluda, in forma metaforica, proprio al cibo industriale propinato ai consumatori dagli scaffali dei supermercati): “Mi sentivo contaminato nel pullman, era una zona rossa antica, acquitrinosa, mi sembravano morte che vivevano le mucche della Polenghi Lombardo e non volevamo mai più essere lì, nessun bambino voleva essere a Codogno”. All’interno di una società industriale che crea spazi contaminati per mezzo di una ipertrofica produzione di scarti, rifiuti e discariche inquinanti (tema affrontato in modo quasi ‘epicizzante’ da Underworld di Don De Lillo), gli stessi esseri umani si trasformano in scarti: “Tutti noi siamo scarto, rifiuto, buccia annerita, polpa del caco che fermenta in fondo al frigo, ammaccato, sfatto. Siamo questo scialo”.
La scrittura di Genna attua anche un significativo discorso sul potere e sulle sue oscure logiche. La figura che incarna il potere e la sua ambigua e perversa natura è il già ricordato Capomastro, capo dell’intelligence (definito come un “idolo di metallo, che pronuncia una parola metallica, una parola fascista”): “La nostra ultima risorsa è il golpe. Il colpo di Stato è la funzione principale dello Stato […] Siamo un paese in emergenza, in guerra. In guerra. Emaneranno i decreti, ma i decreti non serviranno a nulla, saranno confusi, serviranno a indebolirci e non a rinforzarci. Vanno sospese le libertà, da adesso, subito. I cittadini non seguiranno i decreti. Tra qualche giorno saremo evocati, saremo invocati: venga l’esercito a proteggerci, venga l’esercito a liberarci. Dietro l’ombra della polizia, c’è sempre l’uso della forza primaria, definitiva”. E, poco dopo, il funzionario così continua: “La democrazia è un insulto all’emergenza. L’emergenza è il fattore di rischio della democrazia: non sa come gestirla. Il mondo è uno sconfinato territorio dove si agitano anatre umane. Da qualunque spigolo dell’emergenza urge un fascismo che ci ristora, ci consola, ci accudisce con le sue carezze nere dall’alto, sul nostro capo scontatamente puerile. La realtà è una stia infinita, dove becchettiamo mangime e assumiamo efedrina a ogni emergenza”. Nell’allocuzione di Capomastro il colpo di stato è l’essenza stessa dello Stato, per mantenere l’ordine e il potere (con molteplici allusioni, probabilmente, alle bombe e alle stragi di stato che hanno insanguinato il recente passato repubblicano): “Non serve a niente, si deve subito arrivare alla conclusione ovvia sul virus, senza neanche effettuare le ricostruzioni: bisogna chiudere tutto. Tutto! I civili vanno confinati in casa. Soltanto noi possiamo farlo. Lo Stato deve abolire lo Stato, diventando l’unica verità: non l’anarchia, non le sinistre, ma soltanto lo Stato. Non ha da esserci altro che lo Stato. Soltanto lo Stato può sconfiggere il virus”.
Il “viaggio al termine della notte” verso il quale ci conduce la sapiente scrittura dell’autore si srotola fra periferie degradate, tangenziali notturne, ospedali trasformati in gironi infernali, locali pubblici, stanze del potere, interni privati serrati nella morsa del lockdown. Alla fine si tocca il fondo venato di orrore di una società dimentica dell’ambiente e di se stessa, preda delle dinamiche economiche e aziendali all’insegna del guadagno facile. Ma si raggiunge anche una profonda dimensione umana che pareva dimenticata: nel dolore, nel lutto, nella perdita, nella ferita lancinante riemerge potentemente una dimensione umana perduta e sepolta. La scrittura di Genna, coraggiosamente, ci prende per mano e ci porta al cospetto di una umanità ferita e devastata, sprofondata nel baratro dell’orrore ma forse proprio per questo ancora più dolorosamente umana.
E, forse, alla fine, c’è ancora spazio per un barlume di speranza. Concluso il lockdown, gruppi di persone prendono i tram per recarsi in aperta campagna e godersi il sole: “C’era lo spazio, c’era il tempo di restare trasognati nell’aria nuova”. L’immagine finale è dedicata a un gruppo di ragazzi che, al termine del percorso in tram, “si alzarono per primi, stirando le giovani membra”. Sembra quasi che si sia compiuta una catarsi: i ragazzi che si alzano e “stirano le giovani membra” mi hanno fatto pensare al finale della Metamorfosi di Franz Kafka. Dopo la morte di Gregor-scarafaggio, i genitori e la sorella prendono il tram e si recano all’aria aperta in campagna, lontano dalla chiusura soffocante dell’appartamento. Alla fine del racconto kafkiano, il gesto compiuto dalla sorella di Gregor è lo stesso dei ragazzi del romanzo: “E fu per loro come una conferma ai nuovi sogni e alle buone speranze, quando alla fine del tragitto la figlia si levò per prima in piedi, stirando il suo giovane corpo”. Dopo la discesa nell’inferno della malattia, dell’abbrutimento, della morte, della chiusura oscura e claustrofobica, quei giovani corpi che si stirano al sole forse ci comunicano che ancora un nuovo inizio è possibile.
Riferimenti bibliografici:
G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Per una letteratura minore, trad. it. Quodlibet, Macerata, 1996.
F. Kafka, Tutti i racconti, trad. it. di E. Pocar, Mondadori, Milano, 1989.



