di Gioacchino Toni
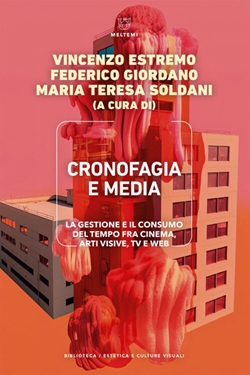 Vincenzo Estremo, Federico Giordano, Maria Teresa Soldani, a cura di, Cronofagia e media. La gestione e il consumo del tempo fra cinema, arti visive, TV e web, Meltemi, Milano, 2024, pp. 240, € 20,00
Vincenzo Estremo, Federico Giordano, Maria Teresa Soldani, a cura di, Cronofagia e media. La gestione e il consumo del tempo fra cinema, arti visive, TV e web, Meltemi, Milano, 2024, pp. 240, € 20,00
All’inizio del Novecento, se Henri Bergson guarda al tempo come a una massa fluida, non collocabile né materializzabile, in cui esistono soltanto azioni, Frederick Taylor si propone invece di rinchiudere queste azioni nel tempo rigido della divisione del lavoro. Due direttrici destinare, un secolo dopo, a convergere nei media a causa dell’ingerenza delle macchine mediali, macchine capaci di ridefinire non solo le rappresentazioni, ma anche le produzioni della società contemporanea. È a tale convergenza che guardano i saggi che compongono Cronofagia e media (Meltemi 2024), volume curato da Vincenzo Estremo, Federico Giordano e Maria Teresa Soldani che si propone come riflessione cross-disciplinare su una convergenza in cui «a essere abbattuta non è più la distinzione tra tempo ciclico della natura e tempo determinato, ma tra tempo libero e tempo del lavoro. Una confusione che oscura l’esperienza socialmente differenziata del tempo vissuto e legittima la fissazione culturale sul controllo del tempo» (p. 8). Lo sviluppo delle tecnologie mediali ha progressivamente modificato la percezione umana del tempo in direzione di una temporalità contraddistinta da accelerazione, immediatezza e istantaneità.
Risulta del tutto evidente il ruolo assunto dalla macchina, a discapito della natura, nell’organizzazione della produzione e della riproduzione. Se nel contesto industriale della seconda metà secolo scorso, il celebre Frammento sulle macchine di Marx è stato interpretato sia in maniera tecnofobica, sia tecno-risolutiva, nel nuovo millennio la sua rilettura si è trovata a fare i conti con un contesto decisamente cambiato, a partire dalla direzione che ha preso lo sviluppo delle macchine e il conseguente livello di astrazione.
In una contemporaneità digitale, in cui tempo di vita e tempo di lavoro tendono a sovrapporsi, «l’automazione si ripropone come un’ottimizzazione tale del tempo della vita, che corrisponde a una sua ingestione» (p. 10). La rivoluzione nel tempo e negli spazi imposta dalla medializzazione, propria di un capitalismo sempre più pervasivo e mimetico, comporta forme inedite di competitività e sfruttamento del tempo incuranti dei limiti biofisici degli esseri umani.
La dislocazione e l’iper-presenza dei media contribuisce a creare degli spazi in cui strumenti allo stesso tempo pervasivi e invisibili, predano il tempo e l’attenzione dell’utente. Spazi che a differenza di quelli in cui avevano luogo le esperienze precedenti, non trasmettono e basta, ma sono predisposti per ricevere e catturare informazioni. In questa modalità si rovescia il rapporto spettatoriale con i corpi non più diretti verso la trasmissione, ma con la trasmissione che raggiunge i corpi ovunque essi siano. Un rapporto che si cementifica grazie alla presunta libertà o scelta di chi vive l’esperienza mediale attraverso feedback continui e ridondanti rispetto all’evento stesso. La medialità contemporanea infatti, attingendo alla sua tradizione di industria dell’intrattenimento, ha ripulito gli aspetti disciplinari dei sistemi industriali, trasformandoli in fenomeni relazionali orizzontali e apparentemente paritari. Ogni esperienza mediale nasconde i propri scopi estrattivi attraverso fenomeni complessi e molteplici che avvengono contemporaneamente. Eventi dinamici che forgiano un tempo segmentato e ridotto – facile da assimilare – ma in continuo fluire (p. 13).
La società contemporanea mira all’alienazione totale del lavoro facendolo percepire come divertimento attraverso l’ambito mediale, un ambito che tende a fagocitare porzioni sempre maggiori di tempo sottraendole ad altre occupazioni. I contributi che compongono il volume indagano dunque la natura cronofaga della medialità contemporanea, mettendone in luce gli aspetti più evidenti, dai processi di automatizzazione del lavoro alle pratiche di vetrinizzazione della vita online, sino alle abbuffate seriali compulsive e alla conseguente condizione di governamentalità algoritmica.
L’obbiettivo è rendere il tempo libero omologo al tempo occupato. Un tempo per essere pienamente libero, ossia svincolato da opzioni che lo eterodirigano e a nostra totale disposizione, deve essere condotto nomadicamente, senza previsioni possibili, nel senso scelto. L’ambizione dell’ipercapitalismo è operare questa precognizione delle scelte dei cittadini-fruitori, e indirizzare le scelte del loisir verso l’ambito mediale, dando la sensazione che queste scelte siano operate liberamente da chi le sta operando (p. 14).
Nel volume non si guarda in maniera apocalittica alla tendenziale sovrapposizione dell’ecosistema mediale con l’intero apparato sociale e agli aspetti cronofagico e biofagico del digitale; ci si muove piuttosto nella convinzione che la consapevolezza del meccanismo cronofagico sia di per sé il presupposto per non assoggettarsi alle logiche della tecno-capitalismo digitale. Insomma, essere consapevoli della cronofagia mediale significa già contrastarla.
In un incrocio fra individuale e collettivo possiamo indirizzare la tecnica nel mettersi al servizio di un lavoro più umano, di un tempo libero davvero liberato, di una equilibrata libertà individuale, di un uso non compulsivo dei media. La neutralità disumana del modello ipercapitalistico che funziona attraverso il macchinico, e usa gli esseri umani come mere risorse economiche, può essere contrastata dallo squarciamento del velo e dall’hackeraggio della tecnica attraverso un movimento intersoggettivo, che si può fare collettivo. Usare meglio la tecnica e il suo portato mediale non è usare meno, ma usare con cura e per la cura degli altri, trasformando Chronos in Kairós – tempo debito –, ossia trasformando il tempo come misura organizzata e mossa da una esterna istanza astratta in autonomia del tempo debito (p. 24).
Il volume Cronofagia e media è composto da due parti. La prima si sofferma sul concetto di cronofagia, sulle concezioni di temporalità e durata, sulle caratteristiche dei dispositivi tecnologici, sugli ambienti mediali e sugli ambiti lavorativi, culturali e artistici: Jean-Paul Galibert riflette sulla colonizzazione dell’immaginario e sullo sfruttamento dei desideri degli utenti da parte delle piattaforme digitali; Jonathan Crary incentra il suo contributo sulle ricadute sugli esseri umani e sul pianeta dello sfruttamento economico attuato attraverso pratiche di produzione, consumo, estrazione, trasporto e circolazione sempre più ciniche e pervasive; Alessandro Simoncini, riprendendo l’idea foucaultiana di biopotere, mette in relazione la gestione del tempo e lo sfruttamento dei dati nelle piattaforme social; Lorenzo Denicolai guarda al rapporto tra gli utenti, le tecnologie digitali e le produzioni culturali nell’odierno orizzonte postmediale soffermandosi sui dispositivi regolanti il tecno-tempo e guardando in particolare alla serie Westworld – Dove tutto è concesso (HBO, 2016-2022) ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy; Vincenzo Estremo guarda ad alcune opere multimediali focalizzandosi sull’immaginario che accomuna il tempo di lavoro, anche artistico, e il tempo libero.
La seconda parte del volume si occupa, invece, delle strategie della cronofagia proponendo una serie di case studies inerenti la produzione, il consumo e la distribuzione di film, serie e videogiochi: guardando al di là delle produzioni hollywoodiane tendenti all’assoggettamento del tempo e delle coscienze degli utenti/consumatori, Maria Teresa Soldani si concentra sulla funzione liberatoria di opere audiovisive non-convenzionali capaci di sottrarsi alla cronofagia nei consumi culturali; Giacomo Nencioni indaga la rappresentazione dei luoghi di lavoro e delle relazioni tra tempo del lavoro e tempo dello svago, tra tempo dei lavoratori e tempo dei proprietari, nelle estremizzazioni proposte da film e produzioni seriali che ricorrono a registri distopici, apocalittici o anche farseschi; Tiziano Bonini si occupa di come l’attenzione sia divenuta a tutti gli effetti una merce di valore nel mercato capitalistico, una merce quantificabile e rivendibile attraverso la datificazione dalle piattaforme digitali; guardando all’universo videoludico, Federico Giordano analizza i meccanismi di promozione, controllo e valutazione delle performance che espongono i gamer a un iperlavoro non retribuito particolarmente profittevole per le aziende; Simone Santilli esplicita come la modalità fotografica introdotta in buona parte dei videogame contemporanei sia uno strumento di gamification utile ad aumentare la longevità del prodotto e a pubblicizzarlo gratuitamente attraverso la condivisione delle fotografie in-game sui social da parte dei gamer.



