di Paolo Lago
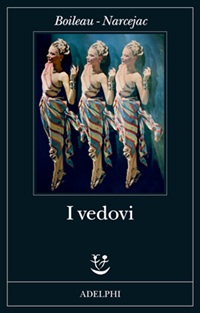 Boileau – Narcejac, I vedovi, trad. it. di Giuseppe Girimonti Greco e Ezio Sinigaglia, Adelphi, Milano, 2025, pp. 172, euro 18,00.
Boileau – Narcejac, I vedovi, trad. it. di Giuseppe Girimonti Greco e Ezio Sinigaglia, Adelphi, Milano, 2025, pp. 172, euro 18,00.
Alla casa editrice Adelphi si deve il merito di aver recentemente riproposto, in traduzione italiana, una serie di romanzi di Boileau-Narcejac, vale a dire Pierre Boileau e Thomas Narcejac, autori di svariati romanzi polizieschi e noir. Si possono ricordare titoli come I diabolici, Le incantatrici, Le lupe, La donna che visse due volte (portato sullo schermo da Alfred Hitchcock). Ma il merito va indubbiamente anche ai bravissimi traduttori che si sono cimentati di volta in volta nella resa italiana delle vicende messe in scena dai grandi scrittori francesi: Federica Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco. Ad affiancare quest’ultimo, nella più recente trasposizione italiana del duo francese offerta dall’editore, I vedovi, incontriamo, sotto la veste di traduttore, Ezio Sinigaglia, che è anche un bravissimo romanziere e poeta, fine facitore di intrecci assolutamente non banali nonché di un intrigante linguaggio a pastiche.
I vedovi, uscito in versione originale nel 1970, si ambienta in un’estate parigina dalle tinte fosche con sullo sfondo un solleone che si tinge di noir. Il protagonista è un giovane aspirante scrittore, Serge Mirkin il quale, oltre a presentarsi come un vero e proprio “mitomane”, è anche tremendamente geloso della bellissima moglie Mathilde, disposto persino ad uccidere a sangue freddo per eliminare ogni possibile rivale. Innanzitutto, chiarisco cosa intendo qui per “mitomane”: si tratta di una definizione utilizzata da Gian Biagio Conte per definire il protagonista io narrante del Satyricon di Petronio (I sec. d. C.), Encolpio, il quale si presenta come un narratore continuamente ingannato dal mito e dalla letteratura alta. Dal momento che si tratta di un colto studente e intellettuale catapultato in un ambiente misero e meschino, non può che vivere ogni situazione frapponendo un filtro fra sé e la realtà, un filtro che gli deriva dalle sue letture ‘elevate’: mito, poesia epica, poesia elegiaca. Fino a credersi, in alcuni momenti, un nuovo Achille o un nuovo Ulisse1. Ebbene, anche Mirkin, come Encolpio, sembra frapporre un filtro letterario fra sé e la realtà. È innanzitutto la gelosia a fargliela vedere completamente stravolta, frutto quasi di un delirio onirico, ma anche la letteratura e il cinema hanno una parte considerevole. All’inizio del romanzo lo vediamo intento a procurarsi una pistola in un sordido bar e così si esprime il personaggio che, esattamente come Encolpio, è l’io narrante dell’intera storia: “Tutto fin troppo facile! Avevo l’impressione di guardare un film di gangster. Anzi, mi muovevo in un film di gangster” (p. 9). L’immaginazione di Mirkin, forse, corre allora a un film come Grisbì (Touchez pas au grisbì) di Jacques Becker, del 1954, che, in quella fine anni Sessanta in cui molto probabilmente si svolge la storia, doveva essere già un classico (tra l’altro, con un attore iconico come Jean Gabin).
Se a Mirkin sembra di muoversi in un film di gangster, è anche vero che egli è completamente separato dalla realtà, come “un pesce nell’acquario”: “Non pensavo più a niente. Ero oltre il confine. Il viale, le auto luccicanti, la luminosità untuosa del tramonto, Mathilde, tutto era lontano; era altrove. Un pesce nell’acquario. Nuota: guarda, un occhio per volta, ora a destra ora a sinistra. Vede delle sagome, le sfiora, immerso nell’indefinito; si dissolve in un sogno liquido; è mostruosamente solo. Ecco. Tutto qui” (p. 10). Lo stesso sfondo parigino assume un aspetto vitreo e indefinito, come avvolto da una perenne nebbia nonostante il caldo estivo. È come se Mirkin si muovesse in una realtà virtuale, in una Parigi da incubo onirico, un universo in cui nemmeno lontanamente si sente l’eco di quel Sessantotto che, pure, doveva essere ben vicino. Per sbarcare il lunario, presta poi la sua voce a personaggi di radiodrammi e sceneggiati ma, in virtù della sua “mitomania”, si trova a pronunciare una frase come questa: “Il vero sceneggiato era quello che stavo vivendo in prima persona” (p. 65). Ma di che sceneggiato si tratta? Naturalmente, qui, non posso svelare più di tanto sulla trama: basti sapere che c’è di mezzo la gelosia e un omicidio compiuto da Mirkin (questo lo posso dire, c’è anche nella seconda di copertina…) spinto proprio da quest’ultima. Il personaggio, frapponendo un filtro letterario fra sé e la realtà, la trasforma come più gli aggrada; gli autori sono abilissimi nel creare questo sfondo di cartapesta allestito apposta per i movimenti scenici di Mirkin: oscuri bar e bistrot, ristoranti di periferia, eleganti palazzi di città e ville di campagna, un appartamento oscuro e livido – quello in cui abita assieme alla moglie – in cui si condensano il suo senso di insoddisfazione e la sua lancinante gelosia, la sua “follia” che “si è trasformata in dolore” (p. 99), il suo sguardo obnubilato sulla realtà circostante, sulle strade che sembrano, appunto, frutto di un “sogno liquido”. Certi angoli, certi interni, certe strade paiono uscite da un romanzo russo, da Le anime morte di Gogol’ o, meglio, da certi romanzi di Dostoevskij. Anche se il nome Mirkin possiede una certa assonanza col Myškin de L’idiota, mi viene in mente soprattutto Delitto e castigo: Mirkin, come un nuovo Raskol’nikov, si muove per le vie di Parigi (che si sostituisce a San Pietroburgo) in preda a un delirio febbrile, a una dolorosa e lancinante angoscia perdendosi in sordidi vicoli e bassifondi.
Nel romanzo di Boileau e Narcejac ha un grande spazio anche la fama letteraria nonché i più meschini sotterfugi cui un individuo può essere disposto per ottenerla: Mirkin è uno scrittore che vorrebbe sfondare a tutti i costi ma, ovviamente, in virtù della sua mitomania, è già convinto di essere bravissimo e geniale (“Sapevo di avere talento! Lo sapevo…”, p. 73). E anche il suo antagonista (ma su questo altrettanto importante personaggio davvero non posso dire di più), il ricco Patrice Garavan, appare intriso di mitomania letteraria: durante una discussione con Mirkin fa riferimento, come se niente fosse, a un personaggio di un romanzo di William Somerset Maugham, “quel funzionario che indossa ogni sera lo smoking per cenare sotto la tenda” (p. 156). Lo stesso Garavan coinvolgerà Mirkin nel lavoro di una trasposizione cinematografica di un romanzo, un lavoro da condurre assieme nella sua isolata villa di campagna, in una situazione molto simile a quella inscenata dalla serie TV Les papillons noir (2022), in cui uno scrittore accetta l’offerta di un misterioso individuo di scrivere un romanzo ispirato alla sua vita altrettanto misteriosa.
Se, nell’universo finzionale de I vedovi, quei diabolici anni Settanta che vediamo nella serie TV, intrisi di violenza gratuita, sono ancora di là da venire, ne percepiamo già le prime avvisaglie: una Parigi spettrale, specchio oscuro di un film di gangster, di un radiodramma o di uno sceneggiato altrettanto oscuro e violento, in cui niente lascia intuire le proteste del vicino maggio francese e in cui si muove un personaggio vittima di una mitomania letteraria e cinematografica, separato dalla realtà, truce epigono e imitatore di vecchi gangster ma unicamente interessato alla sua sfera privata fatta di presunta fama letteraria e gelosia. E se la sfera intima e privata si sostituisce alla realtà e ne prende il posto, in un ribaltamento, una violenza che non guarda in faccia a niente e a nessuno invaderà le strade. I tempi dei veri gangster e del codice d’onore della vecchia malavita sono davvero lontani.
Cfr. G. B. Conte, L’autore nascosto. Un’interpretazione del «Satyricon», Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 11-105. ↩



