di Francesco Festa
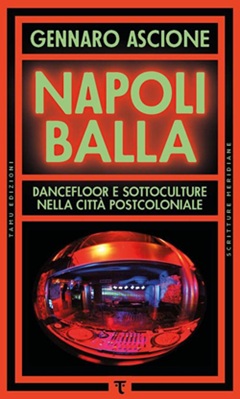 Gennaro Ascione, Napoli balla. Dancefloor e sottoculture nella città postcoloniale, Tamu Edizioni, Napoli 2025, pp. 283, € 18,00
Gennaro Ascione, Napoli balla. Dancefloor e sottoculture nella città postcoloniale, Tamu Edizioni, Napoli 2025, pp. 283, € 18,00
O ciuccio è ferito… ma nun è muorto! Io vi avevo già avvertito: Napoli nun adda cagnà! E perciò chi fa ‘o Festivàl more acciso…
Nel 1982 esce No grazie, il caffè mi rende nervoso, una commedia dai tratti thriller diretta da Lodovico Gasparini e interpretata da Lello Arena e Massimo Troisi. Fra battute, situazioni deliranti, la “parlesia” – la lingua segreta dei musicisti napoletani – proprio Lello Arena veste i panni di un misterioso maniaco che vorrebbe custodire la bellezza di Napoli cristallizzata nella sua immagine oleografica e stereotipata, minacciando di morte ogni velleità di cambiamento e modernità. In particolare la minaccia è una kermesse musicale denominata “Primo Festival Nuova Napoli”, cui avrebbe preso parte anche James Senese se non fosse stato ammazzato.
Ma Napoli è cambiata, ça va sans dire. Senza capo né coda, verrebbe da aggiungere. Ostaggio del turismo a tutti i costi, alla turistificazione è subentrata la gentrificazione, rendendo lo spazio urbano un mondo irriconoscibile, una città che a tratti sembra uscita da un romanzo di Ballard sommersa da un’accozzaglia di ristoranti e take away. Parafrasando Pino Daniele, “Napule è na’ teglia sporca” oltre che “na’ carta sporca e nisciuno se ne importa e ognuno aspetta a’ ciorta”. La sorte è appesa al filo della parodia di sé stessa, della sua storia e del parco giochi a cielo aperto per turisti. Il che è oggi economia e identità sociale della Napoli contemporanea. Vien da chiedersi, ma doveva per forza andare così?
Il libro di Gennaro Ascione, Napoli balla. Dancefloor e sottoculture nella città postcoloniale, sgombera il campo da questa distopia in cui è precipitata la città, illuminando il campo alla visione di un’altra Napoli. Il libro dona luce a realtà ormai sconosciute, fra mondi sotterranei e segreti, che comunque ostinano a vivere.
Il cuore pulsante del libro è la Napoli delle viscere, quella che si nasconde “sotto le botole nel tufo o dietro ai palazzi”, fra vicoli e strade oggi completamente stravolti, dove hanno convissuto scenografie di film, case discografiche, canzoni, musicisti, band e dancefloor. Il libro è un viaggio nella Napoli della cultura musicale, fra Otto e Novecento e fino ai giorni nostri: quella realtà culturale che, forse, non c’è più, ma è più viva che mai nel fermento, nelle resistenze e nelle lotte sociali e culturali.
Premessa di metodo: la cultura non è un campo neutro. Anzi è un terreno di conflitto dove confliggono poteri, identità e rapporti sociali. Il debito di Ascione è verso Stuart Hall, Iain Chambers e verso i Cultural studies, secondo i quali gli aspetti culturali della città lungi dall’essere un insieme fisso di valori, rappresentano invece un processo in continuo movimento, in cui i significati vengono costruiti e contesi all’interno dei rapporti sociali.
In tal modo Napoli balla assume la dimensione di un viaggio stratificato in cui la città, la musica e i corpi si fondono in un racconto che vibra. Vibra di suoni, di memoria e di politica. Ascione guida il lettore in un percorso che sfida i confini del genere saggistico e abbraccia la narrazione ibrida, capace di connettere pratiche urbane, genealogie musicali, conflitti di classe e trasformazioni identitarie. Il testo si configura come una mappa, anche se in realtà è uno spazio aperto al movimento, all’improvvisazione, alla collisione.
Ascione rifiuta l’estetica folcloristica e nostalgica, per restituire una città che “nun adda cagna”, eppure si reinventa costantemente attraverso il metissage ritmico, delle parole e dei suoni, così com’è complessa, stratificata e mai definita la sua storia secolare. Così Napoli ritrova la sua natura situazionista, dove il détournement non è solo un paradigma, ma una pratica quotidiana incarnata nella trilogia: deviazione, eccedenza e creazione.
L’esperienza della lettura potrebbe sembrare multisensoriale. Napoli balla è infatti un libro da ascoltare e da vedere, con passaggi che citano passi di film ed evocano sequenze cinematografiche, ma anche atmosfere psichedeliche, visioni sciamaniche, beat sincopati.
Si tratta di una narrazione dove il ritmo e il lessico imitano la struttura del sound: ripetizioni, campionamenti, break narrativi, alternanze di registri e toni. Il che rende il testo simile a un DJ set con continui riferimenti interdisciplinari, caratteristica dei Cultural studies, in cui la cultura popolare diventa chiave di lettura dei mutamenti sociali.
Curioso è un riferimento a Gramsci e ad alcune sue osservazioni sulla musica jazz, che ritorna spesso nel primo capitolo. Chissà se quelle suggestioni furono anticipazioni lucide – o paranoiche – sul futuro impiego del jazz nella propaganda americana. Resta il fatto che sono curiosamente illuminanti. In una lettera del 1928 a sua cognata Tania, fra coordinate eurocentriche e talvolta razziste, Gramsci esprime il timore che i subalterni, attratti da modelli culturali borghesi come il jazz, si allontanino dalla necessaria coscienza di classe. Tuttavia, questa diffidenza non gli impedisce di cogliere, con sguardo acuto, la forza antropologica del jazz come intreccio indissolubile tra musica e danza. Il ritmo sincopato, la ripetizione dei movimenti, la facilità con cui quel linguaggio penetra nel vissuto psichico collettivo, diventano per Gramsci segnali di una pratica sociale potente, capace di dar forma a uno spazio di esperienza — il dancefloor — che, nell’epoca della decolonizzazione, assume valenza politica.
Uno dei concetti più potenti del libro è la definizione del dancefloor come “spazio sociale della decolonizzazione”. Una tesi ardita, ma affascinante: la pista da ballo diventa il luogo in cui le soggettività subalterne, ibride, meticce, trovano espressione. In una città che è essa stessa postcoloniale – al margine del discorso nazionale, travolta dalle narrazioni mainstream, sospesa tra centro e periferia – la musica diventa prassi politica, archivio emotivo e gesto performativo.
Fra i tratti più riusciti di Napoli balla è la capacità di costruire una genealogia musicale della città e in realtà di tutto il paese. La musica pop ante litteram è nata grazie ai napoletani di stanza in città o in giro per l’Europa. I “posteggiatori” – i suonatori ambulanti di fine Ottocento – accompagnati dalla chitarra cantavano tra i tavoli di osterie e ristoranti, raccogliendo offerte come facevano un tempo menestrelli e saltimbanchi medievali. In questo girovagare nasce la “parlesia”, una lingua che serviva per comunicare fra posteggiatori. E nello stesso mondo nasce il successo di ‘O sole mio. Con una tournée in Russia nel 1897. Il successo si inserisce nel crescente interesse per la canzone napoletana, diffusa anche grazie ai flussi migratori dopo l’Unità d’Italia. È in questi mondi sovrapposti che Napoli assume una dimensione “post‑italiana”, cioè, uno spazio in cui si frantumano le retoriche identitarie omogenee, e dove si materializzano nuove soggettività culturali.
La cifra della dimensione post-identitaria è riscontrabile nel dopoguerra, quando i soldati afroamericani di stanza in città ascoltano il jazz, il blues, il R&B. Alla devastazione dei bombardamenti e alla fame della guerra, la musica dei militari statunitensi – veicolata attraverso radio militari, vinili “victory disc” e jam session improvvisate – entra nella vita quotidiana, innestandosi nei circuiti culturali e trasformando la stessa idea di musica.
A differenza degli Stati Uniti, dove il jazz nero è confinato nei ghetti, a Napoli viene accolto nei locali clandestini, nelle taverne, nelle radio. Ascione racconta di come, negli anni Quaranta e Cinquanta, si assiste ad una contaminazione imprevista: il lirismo melodico napoletano si mescola con i suoni sincopati afroamericani, generando ibridazioni sonore che preparano il terreno per il funk dei Napoli Centrale, per il Neapolitan power di Pino Daniele, ma anche per l’estetica urban contemporanea di Liberato.
Questa ibridazione non è soltanto musicale: è politica e simbolica. I corpi dei soldati neri – discriminati in patria, accolti come “liberatori” nella città partenopea – diventano veicoli viventi di un’altra idea di modernità. Una modernità nera, diasporica, Black Atlantic – come scritto da Paul Gilroy. Nota Ascione che è attraverso quei suoni che la città inizia a pensarsi come parte del mondo postcoloniale, come crocevia di memorie e resistenze, come luogo di rifondazione culturale. Si tratta, in fondo, di un processo che rilegge la sua stessa storia in chiave “transatlantica”, e che riconfigura la musica come pratica di sopravvivenza e di desiderio collettivo.
Interessante è la relazione fra lotta di classe e parole. Qualcosa di inimmaginabile nei testi delle canzoni coeve. Nelle pagine di Napoli balla si legge lo stridore in queste relazioni, mai pacificate, fra storie, memorie e narrazioni che si sovrappongono. Dai giorni gloriosi e misconosciuti della casa discografica BBB, alle lotte sociali degli anni Sessanta e Settanta ove le fratture si scavano fra lavoratori salariati, operai e disoccupati, chi scolarizzato e chi no, chi emigrante e chi no, in uno spazio urbano in corso di de-industrializzazione distribuito fra industrie, fabbrichette ed ’“economica del vicolo”. James Senese sublima in musica tale frattura nel brano Chi fa l’arte e chi s’accatta
Fino a quando esisterà
chi fa l’arte e chi s’accatta
chi fa il braccio e chi la mente
chi tene troppo e chi nun tene niente?
Fino a quando esisterà
chi fotte e chi è fottuto
chi nun vò e chi nunn’è voluto?
Fino a quando, ’ncopp’a terra ne resta uno ca se lamenta
ne resta uno ca se lamenta!
Fino a quando tutti quanti nun ci facimme ’o culo tante pe’ ll’ammore e l’eguaglianza nuje nun simme ancora niente.
Chisto munno nun vale niente chisto munno nun vale niente! (p. 63)
In questo paesaggio sonoro si iscrive una delle esperienze più radicali della Napoli musicale: il Neapolitan Power. Più che un movimento musicale, una vera insurrezione sonora e culturale. Emerso alla fine degli anni Settanta, il Neapolitan Power ha cercato di scardinare l’immagine stereotipata di Napoli, imposta dai circuiti mediatici e dal turismo culturale, costruendo una lingua musicale nuova, fatta di jazz, funk, dialetto, e tensione sociale.
Gli artisti come James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, ma anche Pino Daniele, si pongono come guastatori del discorso nazionale: reinventano la napoletanità contaminandola con l’Africa, con il Mediterraneo, con l’Atlantico. La musica non è più solo espressione culturale, ma diventa lotta di classe suonata: una “traduzione in versi della rabbia e della bellezza” (p. 57). E dietro ogni riff, ogni break di batteria, ogni urlo rauco del sax di Senese, c’è una città che lotta per restare viva nella sua complessità.
Il libro dedica pagine importanti ai luoghi della marginalità culturale, la “Napoli segreta”, ovvero quei territori urbani dove si sperimentano nuove forme di socialità e di produzione simbolica. È in queste “infraculture” – come le definisce Ascione – che si consuma la rottura con la Napoli turistica: luoghi dove la cultura non è spettacolo da esibire ma materia da vivere. E la cultura underground è anti-museale per costituzione, è archivio del presente: dove si contaminano pratiche postcoloniali, memorie subalterne e resistenze quotidiane. Questa città non si può vedere da fuori, bisogna entrarci, mescolarsi, lasciarsi trasformare.
Napoli segreta altro non è che la sembianza contingente e transitoria che l’anima sfuggente della città ha assunto in forma di musica funk, disco, boogie, afrobeat, wave e balearica, cantata in napoletano, tra la seconda metà degli anni ’70 e la prima metà degli anni ’80 del ’900. Prima che i campionatori colonizzassero l’immaginario acustico globale. (p. 116)
Altro aspetto metodologico adoperato da Ascione è l’intervista o la voce diretta dei protagonisti – a tratti richiama la tradizione operaista dell’“inchiesta a caldo” – cioè osservare i soggetti nel loro contesto, raccogliere le loro parole senza filtri, lasciarli parlare proprio nel vivo dell’attività. Così vengono fuori “autobiografie in movimento” che compongono una narrazione collettiva.
In HyperNapoli. Movimenti, suoni e visioni, vi sono le voci di alcuni protagonisti contemporanei, con focus su artisti come Liberato, Nu Genea, Enzo Dong, Night Skinny, Nicola Siciliano, collettivi come Napoli Segreta, Chico Trujillo e progetti estetico-sonori e post-identitari – menzione speciale per “Fabrizio Sorrentino aka il papa, Officina99”. Sono proprio i “corpi che danzano nella notte” – i raver, i DJ, gli occupanti dei centri sociali, i sound designer, gli studenti fuori sede, i punk invecchiati e i clubber della Napoli nord – a raccontare una verità che sfugge ai sociologi da scrivania.
In un mondo segnato da confini e muri, Napoli balla ci parla di una città porosa, ibrida, post-coloniale. E quest’opera riesce a essere al tempo stesso saggio, memoir, ma anche manifesto politico. Sfugge a qualsiasi classificazione. Proprio com’è Napoli. E d’altronde l’identità si costruisce solo nel movimento e nella lotta.



