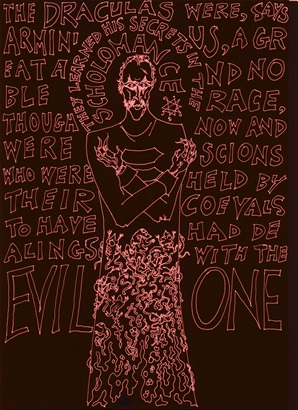di Franco Pezzini
In altra sede si osservava come a dettare periodizzazioni nell’immaginario del (neo)gotico, più che la letteratura siano stati gli schermi, e in particolare il tema-Dracula: riproposto tanto ossessivamente da assurgere a buon misuratore di un’evoluzione dell’immaginario, con cicli grosso modo trentennali, cioè con un arco che corrisponde più o meno a una generazione. Guardiamoci indietro e prendiamo in esame in termini panoramici questa evoluzione.
L’età che dalle origini del cinema corre fino al 1930 – quella cioè del Drakula halála (1921), e del Nosferatu di Murnau (1922) – è in questo senso per forza di cose ancora poco strutturata: il cinema si sta organizzando, ma si è ben lungi dall’immaginare un target per i film del fantastico come poi troveremo. Per quanto nell’ambito dell’espressionismo tedesco si sviluppi infatti la prima “fabbrica dei mostri” – a preludere alle successive Universal e Hammer – il pubblico va a vedere Nosferatu e la settimana dopo una commedia rosa: e questa situazione si riproporrà all’inizio anche in America, dove a partire dagli anni Trenta le grandi platee iniziano ad accedere in modo organizzato alla celebrazione dei riti gotici su schermo.
Da allora si dipana approssimativamente una situazione di questo genere:
anni Trenta (dal 1931, Dracula di Browning, “età di Lugosi”): crescita del gotico;
– anni Quaranta: assestamento e sfilacciamento;
– – anni Cinquanta: contrazione/eclissi;
anni Sessanta (dal 1957, The Curse of Frankenstein di Fisher, “età di Lee”): nuova crescita del gotico;
– anni Settanta: assestamento e sfilacciamento;
– – anni Ottanta: contrazione/eclissi;
anni Novanta (dal 1992, Bram Stoker’s Dracula di Coppola, “età neogotica”): nuova crescita del gotico;
– anni Zero: assestamento e sfilacciamento;
– – anni Dieci (dallo spegnersi del boom dei vampiri attorno al 2012): contrazione/eclissi.
Una serie di studi si sono attestati qui. Ma nel frattempo è accaduto dell’altro. Da un lato l’impatto, ma non la vera rivoluzione recata al tema-Dracula dalle serie televisive: né la pur brillantissima Penny Dreadful (2014-16), che pure ridisegna in modo originale il profilo del vampiro, né l’attesissima e senz’altro interessante serie Dracula BBC/Netflix di Mark Gatiss e Steven Moffat (2020) si sono imposte su un immaginario diffuso fino a costituire dei punti di riferimento per il tema-Dracula. Persino l’effettiva uscita di un film per tanto tempo favoleggiato quasi da appartenere unicamente ai sogni dei cultori, The Last Voyage of Demeter (Demeter – Il risveglio di Dracula, 2023) di André Øvredal, e alla fine rivelatosi una pellicola di tutto decoro, non ha cambiato le cose in termini di impatto sull’immaginario collettivo.
Tempo addietro (25 maggio 2017), si scriveva su questo sito:
Possiamo aspettarci una nuova fase “up” (indicativamente) negli anni Venti? Difficile dire se il trend trentennale troverà ulteriori conferme, e difficile anche immaginare i connotati di una rinnovata crescita del gotico – che per esempio dovrà fare i conti con l’effetto-Legione dei fantasmi dell’era di internet, indefinitamente frantumati in sciami di grumi psichici come già adesso nei romanzi di [Danilo] Arona. I nuovi dottori potranno fronteggiare sempre più frequentemente simili emergenze, con un piede in Matrix e l’altro in The Exorcist: ma di più al momento è difficile dire.
Oggi è probabilmente possibile confermare. In grazia di due eventi che sembrano aver recato elementi di novità. Nel primo caso una novità forzata, cioè la vicenda pandemica (2020-23) che per un certo numero di motivi ha proiettato all’orizzonte dei nostri pensieri fantasie di vampiri e zombie. Nel secondo caso, il successo persino inatteso del Nosferatu di Robert Eggers, 2024: inatteso a fronte di una storia non particolarmente originale benché gestita in modo brillante, ma tale da far moltiplicare tanto epidemicamente e compulsivamente le voci a commento (infiniti i post sui social, innumerevoli i video su YouTube) da costringere a chiedersi se non desse forma ad altro. Cioè probabilmente una crisi epocale fatta di covid, guerre, brutture politiche, sgomitare di sozzi tycoon e presa d’atto delle depressioni di un mondo: e insieme il nosferatu è riconosciuto come un grande incubo, un agglutinato di grumi psichici, un’ombra junghiana da esorcizzare e morirci.
Con ciò non si vuol affermare che questa nuova stagione sia l’“età di Skarsgård” come altre erano state l’età di Lugosi e di Lee: si tratta di epoche del cinema completamente diverse, e del resto la precedente non è stata l’“età di Oldman”, a dispetto della bravura dell’interprete del Conte (che da un lato non ne è stato mai assorbito, dall’altro non ha dettato all’immaginario collettivo una maschera tanto connotante come i due illustri predecessori – anche, va detto, per una certa distanza dal modello letterario). Del resto gli entusiasmi neogotici di quegli anni – chiusi dallo sbrilluccicare dei vampiri in salsa romanticismo sexy, con accento ora sul sostantivo, ora sull’aggettivo – sono ormai lontani, siamo in una fase successiva: anche di storia del mondo, ci ricorda il cinema di Dracula, che in qualche modo è un’ottima cartina al tornasole di crisi e desideri confessati e inconfessabili di singole epoche. Piuttosto, memori dei connotati del nosferatu di Eggers, potremmo chiamare la nuova età avviata come “età degli incubi”: e forse, a prescindere dal cinema, con qualche buon motivo.
L’annunciato arrivo di un altro Dracula, di Besson – c’era davvero bisogno di riproporlo in chiave di A Love Tale? andiamo… – e un fiorire di apocrifi come Dracula: Rise of the Vampire di Dean Meadows (di prossima apparizione), The Reincarnation of Dracula di Nicholas Malden (2024) o Abraham’s Boys: A Dracula Story di Natasha Kermani (2025), la minaccia stessa di un Dracula Untold 2 (fortunatamente non confermato, il primo deludeva terribilmente anche per il clamoroso miscasting che penalizzava un bravo interprete come Luke Evans) allo stato attuale non dicono molto di più d’un prevedibile interesse da parte del pubblico. Potremmo arrivare a ipotizzare uno sviluppo del genere per questa nuova età cinematografica?
anni Venti (dal 2024, Nosferatu di Eggers, “età degli incubi”): nuova crescita del gotico;
– anni Trenta: assestamento e sfilacciamento;
– – anni Quaranta: contrazione/eclissi.
Difficile dire: a differenza del Conte, che tra paletti e coltelli nel cuore, bagni fatali di sole, affogamenti nel fossato gelato del castello e altre amenità continua a emergere come un passato che non passa – dicendo così tanto del mondo in cui viviamo – noi siamo confitti nel tempo. Dunque, augurando a noi stessi lunga vita, saranno forse i nostri figli a confermare o meno la bontà del prospetto. Mentre per ora, benvenuti nell’età degli incubi.