di Gioacchino Toni
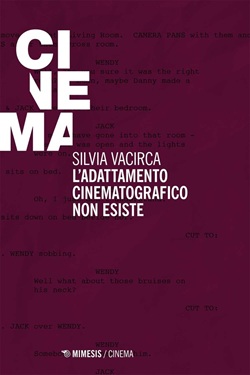 Silvia Vacirca, L’adattamento cinematografico non esiste, Mimesis, Milano-Udine 2025, pp. 152, € 14,00
Silvia Vacirca, L’adattamento cinematografico non esiste, Mimesis, Milano-Udine 2025, pp. 152, € 14,00
Palesandosi sin dalla sua comparsa come luogo di confluenza fra l’ambito tecnologico e quello artistico-creativo, il cinema degli esordi, come già era successo alla fotografia, si è trovato a subire l’ostracismo degli ambienti più conservatori dalle arti tradizionali che gli imputano la ricerca dell’estetica attraverso un atto tecnologico. Se per accreditarsi in ambito artistico o, più genicamente, culturale, la fotografia delle origini ha tentato imitare le messe in scena dei dipinti o ha accettato di sottoporsi al ritocco pittorico, attenuando e contraddicendo così le proprie capacità di “riproduzione oggettiva” del reale, il cinema ha tentato di rendere accettabile la riproduzione meccanica che lo contraddistingue riprendendo sintassi e temi della narrativa romanzesca, dunque si è trovato di fronte al problema dell’adattamento cinematografico dei più nobili romanzi, racconti, pièce teatrali ecc.
I fiumi di inchiostro versati per stabilire le modalità con cui ottenere un “buon adattamento” cinematografico di un’opera letteraria o teatrale si sono dovuti presto confrontare con la presa d’atto che, come scrive Silvia Vacirca nel volume L’adattamento cinematografico non esiste (Mimesis, 2025), sarebbe stato meglio ragionare in termini «di “nuova creazione”, di rinascita dell’opera sotto altra forma, dotata di una coerenza e di una forza proprie, e soggetta a strumenti espressivi, regole, dinamiche, stilemi, risorse, e a volte persino intenzioni, del tutto autonome» (p. 9). La conclusione a cui giunge la studiosa al termine della sua disamina è sintetizzata dal titolo: L’adattamento cinematografico non esiste.
Al di là delle vocazioni più o meno artistiche dei primi realizzatori di film, il cinema è però una macchina costosa che non può prescindere dal fare i conti con gli introiti al botteghino, dunque è stato probabilmente inevitabile guardare alla produzione narrativa per ricavarne sintetiche versioni popolari stravolgendo le opere originali.
Ma questo è il cinema del XX secolo, della prima metà, soprattutto, il cinema popolare, il cinema basato sui classici, ispirato dai classici. Negli ultimi anni, e nel nuovo secolo, l’adattamento si è evoluto in una forma del tutto nuova che se non sposa tra loro comunque avvicina molto letteratura e film, in nome del mercato e quindi del vantaggio reciproco. Un libro di successo è subito tradotto per immagini, diventa film, serie tv, e a differenza di quello che avveniva un tempo il pubblico dei lettori del libro sarà certamente anche quello che lo vedrà su uno schermo. E viceversa. L’adattamento in questi casi è facilitato dalla consuetudine di molti scrittori contemporanei di partire da idee già adatte per il cinema e per giunta espresse letterariamente in modo altrettanto “cinematografico” (p. 11).
Rispetto al cinema delle origini, le cose si sono via via fatte più complesse circa il rapporto tra il cinema e i testi ad esso preesistenti: se da un lato il cinema ha saputo/voluto semplificare sempre più i suoi soggetti derivati da altri linguaggi, dall’altro, affinando il suo linguaggio e i suoi strumenti, ha saputo/voluto guardare ad essi interpretandoli in maniera del tutto originale ricavandone opere di qualità capaci di smarcarsi dal banalizzare-semplificare i testi già esistenti.
I primi capitoli del volume di Silvia Vacirca sono dedicati alle riflessioni sull’adattamento cinematografico che si sono succedete nel tempo e alle teorie sorte a proposito di esso. Per quanto sin dalla sua nascita il cinematografo abbia oscillato tra la valorizzazione dell’attrattività delle immagini e quella delle capacità narrative con cui riesce a coinvolgere lo spettatore, tra la finire del primo e l’inizio del secondo decennio del Novecento il cinematografo inizia a confrontarsi con il rapporto che intrattiene con le opere letterarie sviluppando una riflessione destinata a fare i conti con l’evolversi di tale rapporto alla luce dell’avvento del sonoro sul finire degli anni Venti.
Nel cinema sonoro hollywoodiano sono numerosi gli adattamenti cinematografici, non di rado realizzati da scrittori, di romanzi di cui si sfrutta la popolarità o il prestigio che godevano non solo tra il pubblico più colto, che magari ha conoscenza diretta delle opere letterarie, ma anche tra il pubblico più popolare a cui comunque giunge l’eco dell’importanza del titolo del romanzo e dello scrittore.
Se il nesso tra la produzione cinematografica neorealista italiana del secondo dopoguerra e la letteratura americana moderna di cui ha parlato André Bazin risulta tutto sommato circoscrivibile ad un numero limitato di casi, è innegabile l’importanza degli scrittori italiani su tale cinematografia. Un momento di riflessione importante circa il rapporto tra cinema e letteratura, ricorda Vacirca, si ha con il dibattito sorto attorno al principio della caméra stylo enunciato da Alexandre Astruc che vede confrontarsi numerosi critici e cineasti francesi. Successivamente, scemando la netta distinzione tra la “letteratura alta” con quella “di genere”, il rapporto tra cinema e narrativa ha assunto modalità del tutto inedite.
Circa le teorie degli adattamenti che si sono venute a formare nel corso del tempo, la studiosa ripercorre le riflessioni che, a partire dal problema della “fedeltà” al testo letterario da parte del cinema, di cui si sono occupati, tra gli altri, André Bazin, Viktor Šklovskij, Jean Mitry, Jean Epstein, Christian Metz, Dudley Andrew, Umberto Eco, Brian McFarlane, Francis Vanoye, Patrick Cattrysse, Thierry Gronsteen, Charles Eidsvik e, soprattutto, Jurij M. Lotman.
Sempre nell’ottica del rapporto tra cinema e letteratura, oltre a ricostruire il ruolo assegnato alla sceneggiatura nella produzione cinematografica nel corso del tempo, Vacirca si sofferma anche, con numerosi esempi, sul ruolo dei costumi nei due diversi linguaggi e sul problema della fedeltà negli adattamenti.
Per approfondire la questione dall’adattamento cinematografico di un romanzo, nella seconda parte del volume Vacirca analizza dettagliatamente il film Il ladro di orchidee (Adaptation, 2002) di Spike Jonze, incentrato sulle difficoltà del protagonista tenuto ad adattare al cinema un testo letterario, e i due diversi adattamenti del romanzo Shining di Stephen King del 1997 ad opera di Stanley Kubrick, per l’omonimo film del 1980, e dello stesso scrittore, per la serie televisiva del 1997 diretta da Mick Garris. In Appendice trova spazio un’intervista allo sceneggiatore Bernardino Zapponi realizzata da Gabrielle Lucantonio.



