di Franco Pezzini
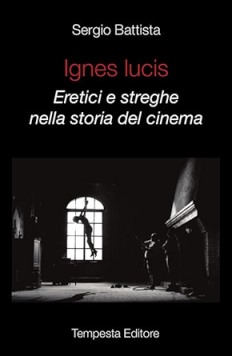 Sergio Battista, Ignes lucis. Eretici e streghe nella storia del cinema, pp. 209, € 18, Tempesta, Trevignano Romano RM 2024.
Sergio Battista, Ignes lucis. Eretici e streghe nella storia del cinema, pp. 209, € 18, Tempesta, Trevignano Romano RM 2024.
Che gruppi minoritari e indotti a un’esistenza segreta dalle più varie contingenze storiche o sociali – eretici, streghe, membri di società segrete… – siano stati presentati dagli schermi cinematografici e televisivi come entità socialmente pericolose (la setta come mostro plurale: cfr. qui e qui) o invece come vittime sulla base di accuse demonizzanti è fenomeno ampiamente diffuso, e in grado di offrire alle trame un più forte motore drammatico. Talvolta il gruppo è in realtà presente uti singuli, in riferimento a un singolo esponente di cui si insegua la storia: e ovviamente si tratta di un panorama vastissimo.
Ora, un taglio intelligente per affrontare una materia tanto sovrabbondante è offerto da Sergio Battista in Ignes lucis: un lavoro monografico impegnativo con un esito di estremo interesse. Il panorama affrontato è assai ampio, guardando a oggetti che, anche dal punto di vista meramente cinematografico, potrebbero costituire materia di più monografie: connotati narrativi di fenomeni sociali e antropologici come eresia e stregoneria, singoli processi eccellenti dal medioevo al Novecento (Giovanna d’Arco, Giordano Bruno, Galileo, ma anche Bonhoeffer), loro mitopoiesi. Merito dell’autore essere riuscito a ben governare un insieme oggettivamente complesso, e – aspetto da rimarcare, in un saggio – di averlo fatto con uno stile narrativo ricco e felice.
Il tema abbraccia situazioni storiche lontane l’una dall’altra, affrontandole in ordine (solo tendenzialmente) cronologico. Si parte da una riflessione sul concetto di eresia definita dal consolidarsi di un’ortodossia cristiana e da una marginalizzazione della presenza femminile, difforme dalla prassi delle origini che vedevano una certa varietà di situazioni: un passo che avrà ulteriori ricadute nella costruzione (soprattutto tarda) della figura della strega. Spazio particolare è qui riconosciuto allo gnosticismo, anche per il diverso ruolo attribuito alla donna.
Dall’introduzione si passa a cenni sull’eresia pauperista, sull’inquisizione, sulle “donne del diavolo” – cioè sulla guerra alle streghe: ma fin qui restiamo a cenni di cornice, ovviamente, per la vastità dell’orizzonte considerato e per poter fornire singole chiavi utili all’analisi di prodotti filmici.
“Il cinema fin dalle origini non poteva non interessarsi al fenomeno dell’Inquisizione e del suo campo d’azione”: così inizia dunque il capitolo Ricerche storiche e immaginari cinematografici, che prende atto dell’impatto anche visivo di alcuni temi. A partire dal meraviglioso film svedese Häxan – La stregoneria attraverso i secoli di Benjamin Christensen (1922), con il suo sontuoso ricorso a fonti artistiche – Bosch, Goya eccetera – e la sua pietà umana, e che avrebbe dovuto rappresentare la prima pala di un trittico, seguita da Helgeninde (La santa) e Ander (Gli spiriti). Ma scarso successo e censure ne impedirono lo sviluppo. D’altra parte non si tratta del primo film a stigmatizzare certi fenomeni, e l’autore ricorda non solo il danese Pagine dal libro di Satana di Carl Theodor Dreyer (Blade af Satans Bog, 1920) ma altri precedenti, indietro fino a Méliès.
Ed è da questa stagione primeva del cinema che la figura di Giovanna d’Arco e la tragedia del suo rogo trovano spazio con relativi atti di accusa al potere: un soggetto di enorme successo di cui in questa sede si mappano le produzioni principali – compresa naturalmente la grande versione con Ingrid Bergman (Giovanna d’Arco al rogo di Roberto Rossellini, 1954) – a sopperire alla scarsezza di raffigurazioni credibili dell’eroina. Le diverse letture sgranano così quel che Battista definisce un primo piano sul potere (in particolare in La passion de Jeanne d’Arc di Carl Theodor Dreyer, 1928), e con un utilizzo dei documenti processuali come sceneggiatura (Procès de Jeanne d’Arc di Robert Bresson, 1962). Ovviamente il tema verrà ancora ripreso, sia per la fascinazione del mistero che la vicenda trattiene, sia per il suo carattere paradigmatico.
Da Giovanna, l’autore torna però mille anni indietro con la vicenda di Ipazia come riletta in Ágora di Alejandro Amenábar (2009), un film interessante al netto di alcune libertà, e che richiama in scena il tema dell’opposizione tra un potere religioso ormai catafratto da una rigida ortodossia e una figura “deviante” femminile.
Con un’ulteriore capriola cronologica, la sezione successiva riguarda scene emblematiche di caccia alle streghe. A partire dal caso di Salem nel contesto puritano 1692-1693 e dall’imbarazzata memoria trattenutane nel mito fondativo americano: anche in questo caso una storia gravida di ricadute artistiche – si pensi al rapporto con La lettera scarlatta di Hawthorne, che modificò il proprio cognome per allontanarlo da quello di un antenato John Hathorne magistrato a Salem – e cinematografiche fin dal 1926, compresa la versione del 1996 La seduzione del male di Nicolas Hytner ispirata a The Crucible di Arthur Miller (1953) memore della caccia ai comunisti. Una coda a questa sezione è dedicata però a Matthew Hopkins, il grande inquisitore – come lo definisce il titolo italiano, in modo non del tutto filologico – del raggelante film di Michael Reeves (1968) con un Vincent Price molto anomalo e per una volta privo di simpatiche gigionerie.
La sezione che segue verte ancora sulle streghe. Si parte con il capolavoro Dies Irae di nuovo di Dreyer (1943), grandioso teatro del conflitto interiore tra tensione spirituale e pulsioni istintuali, liberamente ispirato alla tragica vicenda della norvegese Anne Pedersdotter, arsa viva per stregoneria nel 1590. Si prosegue con il poco noto e terribile Forfølgelsen di Anja Breien (1981), sul tema dell’ignoranza dell’amore in una comunità superstiziosa, per passare al paradigmatico caso cinquecentesco – emerso solo negli anni Ottanta – di Gostanza da Libbiano, oggetto di uno studio storico di Franco Cardini (Laterza, 1989) e del film di Paolo Benvenuti (2000) con Lucia Poli. Meno diffusamente conosciuti sono altri processi portati su grande schermo ed esaminati in sequenza da Battista, quello a Caterina Ross, 1697, nel film di Gabriella Rosaleva (1982), e quello delle streghe dello Sciliar, 1506-1510, nel film eponimo di Andrea Dalfino (2021), con gli echi di un antico culto matriarcale.
La sezione successiva del saggio, Visioni eretiche, prende in esame le trasposizioni su schermo di alcuni casi celebri di eresia (etimologicamente, “scelta”), del Menocchio studiato da Carlo Ginzburg ne Il formaggio e i vermi (Menocchio di Alberto Fasulo, 2018), di Cecco d’Ascoli (L’eretico – Un gesto di coraggio di Piero Maria Benfatti, 2005), naturalmente di Giordano Bruno (il film eponimo di Giuliano Montaldo, 1973, con Gian Maria Volonté e un grande cast, a proseguire un itinerario del regista sul tema dell’intolleranza) e dello stesso Galileo. Soggetto di pellicole fin dal 1909 (Galileo Galilei di Arturo Ambrosio e Luigi Maggi), poi protagonista della lettura di Brecht portata ovviamente a teatro (emblematica la versione di Strehler al Piccolo Teatro, 1963, con pressioni cardinalizie per bloccarla) e più volte sullo schermo fino al censuratissimo Galileo di Liliana Cavani (1968) e oltre. Con scelta molto interessante, la sezione si chiude con Bogre – La grande eresia europea di Fredo Valla (2021), un grande documentario di viaggio – soprattutto interiore – sulle tracce di catari e bogomili.
L’ultima sezione, Eretici moderni, affronta anzitutto le pellicole prodotte sul pastore e teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, giustiziato dai nazisti per la sua collaborazione all’attentato a Hitler (in particolare Bonhoeffer: Agent of Grace di Eric Till, 2000, e i documentari Hanged on a Twisted Cross di T.N. Mohan, 1996 e Bonhoeffer di Martin Doblmeier, 2003). Battista spiega così l’inserimento di Bonhoeffer nel suo studio:
è stato quello che definisco un eretico moderno, vale a dire colui che ha fatto una “scelta” di campo ben precisa, in un periodo dove era più semplice seguire l’omologazione, ovvero ricalcare le scelte fatte dalla maggioranza, che ricordiamo, non ha sempre ragione.
Il passo successivo riguarda opere teatrali degli anni Sessanta che vedono un profondo ripensamento delle esperienze di un Novecento tragico e ambiguo – come L’istruttoria di Peter Weiss e Il Vicario di Rolf Hochhuth con il film trattone Amen di Costa-Gavras (2002); e poi le vicende di Dovlatov – I libri invisibili di Aleksey German Jr. (2018), dove nel grigiore dell’Unione Sovietica brezneviana lo scrittore non allineato non finisce materialmente al rogo ma cancellato, marginalizzato, censurato.
Come l’autore rimarca nella postfazione, il volume non ha pretese di completezza enciclopedica (non vi trovano spazio, per dire, I diavoli di Ken Russell, 1971, o La visione del sabba di Marco Bellocchio, 1988), e riguarda quasi in tutti i casi film cosiddetti “storici” a prescindere dalle libertà eventualmente presenti: “storici” nel genere di approccio ma anche spesso nella loro realizzazione, che segna svolte nell’immaginario cinematografico e coinvolge grandi registi e attori. Dove il titolo Fuochi di luce evoca non solo la messa in luce e divulgazione collettiva di alcune storie emblematiche, con l’evidenziazione di taluni clamorosi meccanismi legati al rapporto col potere, ma anche nel riferimento – materiale o metaforico – al rogo come strumento del potere stesso, cui si oppone colui che compie una “scelta”.
La natura ibrida del testo (le due piste storica e filmica sono oggettivamente complesse da armonizzare) e la scelta di evitare una chiave cronologica stretta rendono la sfida interessante e originale. Il tema d’altronde è immenso, e meriterebbe da parte dell’autore supplementi d’indagine settoriali, in particolare nell’ampio bacino della narrazione popolare di genere. Se il vecchio gotico nasceva in polemica con il passato papista di inquisitori e roghi, le riflessioni di queste pellicole possono toccare provocatoriamente temi assai più vicini a noi.



