di Sandro Moiso
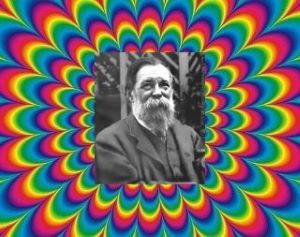 German A. Duarte (a cura di), «I reietti dell’altro pianeta». Un’Ambigua Utopia e le società del futuro, Postafazione di Diego Gabutti, Carlo Pagetti e Giuliano Spagnul, DeriveApprodi, Bologna 2024, pp. 480, 30 euro.
German A. Duarte (a cura di), «I reietti dell’altro pianeta». Un’Ambigua Utopia e le società del futuro, Postafazione di Diego Gabutti, Carlo Pagetti e Giuliano Spagnul, DeriveApprodi, Bologna 2024, pp. 480, 30 euro.
Le utopie invecchiano in fretta, spesso anche se ambigue. Ogni età, almeno dalla fine del Medio Evo ad oggi, ha avuto le sue formulazioni ideali di mondi migliori e società possibili: dalla originale Utopia di Thomas More alla Città del sole di Tommaso Campanella fino ai falansteri di Charles Fourier, solo per citarne alcune delle più note. E tutte, inevitabilmente, si sono rivelate insufficienti (nell’analisi), irrealizzabili o superate nel volger di poco tempo, nonostante contenessero talvolta apprezzabili elementi di critica sociale. Così, già nel 1880, Friedrich Engels poteva sottolineare come:
In Francia [prima della Rivoluzione] tutto fu vagliato dalla critica più spietata (religione, concezione della natura, società, governo); tutto doveva giustificare la sua esistenza ante il tribunale della ragione o esser annientato. […] Tutte le forme sociali e statali fino allora esistite, tutte le concezioni tradizionali furono gettate in soffitta come cose irrazionali. […] Ora finalmente sorgeva la luce della Ragione; d’ora in poi la superstizione, l’ingiustizia, il privilegio e l’oppressione sarebbero stati elisi dalla verità eterna, dalla giustizia eterna, dall’uguaglianza fondata sulla natura, dagli inalienabili diritti umani.
Ora noi sappiamo che tal regno della Ragione fu solo il regno della borghesia idealizzato, che la giustizia eterna fu realizzata solo come giustizia borghese; che l’uguaglianza andò a finir nell’uguaglianza borghese ante la legge; che la proprietà fu proclamata come il principale diritto umano; e che lo Stato conforme a ragione (il contratto sociale di Rousseau) si realizzò come repubblica democratica borghese (e solo così poteva realizzarsi). Come i loro predecessori, i grandi pensatori del ‘700 non poterono oltrepassare i limiti imposti loro dalla loro epoca.
[…] Nella lotta contro la nobiltà, con diritto la borghesia si proclamò rappresentante delle varie classi lavoratrici di ogni tempo; eppure in ogni grande movimento borghese scoppiavano dei moti autonomi di quella classe che fu l’antecessore più o meno sviluppato del proletariato moderno (la Guerra dei contadini degli anabattisti e Thomas Münzer durante la Riforma tedesca; i Livellatori durante la Gloriosa rivoluzione inglese; Babeuf durante la Prima rivoluzione francese). Tali sommosse rivoluzionarie d’una classe ancora indefinita si espressero pure teoricamente: nel ‘500 e nel ‘600, utopistiche descrizioni di regimi sociali ideali; nel ‘700 teorie già comuniste (Morelly e Mably).
[…] La prima forma della nuova dottrina fu un comunismo ascetico ricalcato su Sparta (spregiatore di tutti i godimenti della vita). Poi seguirono tre grandi utopisti: Saint-Simon; Fourier; Owen. […] Però, al loro tempo la produzione capitalistica (e con essa l’antagonismo fra borghesia & proletariato) era assai poco sviluppata. La grande industria nata in Inghilterra era ancora ignota in Francia. E solo la grande industria sviluppa quei conflitti (nonché fra classi, fra le forze produttive e le forme di scambio) che rendono necessario un mutamento del modo di produzione, l’elisione del suo carattere capitalistico. [Ma] nel 1800 i conflitti scaturiti dal nuovo ordine sociale erano solo sul nascere, così come i mezzi per risolverli.
[…] Tale situazione storica segnò i fondatori del socialismo: a produzione e lotta di classi imperfette corrisposero teorie imperfette. Finché celata nei rapporti economici arretrati, la soluzione della questione sociale doveva uscir dal cervello. La società offriva solo incongruità: eliderle toccava alla ragione pensante. Serviva inventar un nuovo e più perfetto ordine sociale ed imporlo alla società dall’esterno colla propaganda e magari con l’esempio di colonie-modello. Tali nuovi sistemi sociali erano condannati ad esser utopie: più essi erano elaborati nei loro particolari, più dovevano risultar fole.
[…] La concezione degli utopisti segnò a lungo le idee socialiste dell’800, e in parte le domina ancora. […] Il socialismo è per tutti loro l’espressione delle assolute Verità, Ragione, Giustizia. […] Ma la verità, la ragione e la giustizia assolute sono diverse per ogni caposcuola [Da ciò] poteva venir fuori solo un socialismo medio eclettico, quale effettivamente regna oggi nelle menti della maggior parte degli operai socialisti francesi e inglesi; una miscela che ammette varie sfumature, che risulta dalle invettive critiche meno polemiche, da princìpi di economia e immagini della società futura dei vari fondatori di sette; miscela che si ottiene tanto più facilmente quanto più, durante la discussione, sono smussati gli angoli acuti della precisione dei singoli componenti, come ciottoli levigati nel torrente. Per far del socialismo una scienza, serviva anzitutto porlo su una base reale1.
Il lettore interessato alla fantascienza a questo punto si sarà già chiesto a che dovrebbe servire una così lunga citazione, vecchia ormai di quasi centocinquant’anni, in un contesto in cui, almeno apparentemente, l’attenzione dovrebbe rivolgersi principalmente agli autori e alle correnti critiche di tale genere letterario, eppure, eppure…
 E’ proprio l’efficace introduzione di German A. Duarte al volume che raccoglie gran parte dei materiali pubblicati sulla rivista «Un’ambigua utopia» (d’ora in avanti citata come UAU) a dimostrare come anche i migliori tentativi di anticipazione sociale, politica e culturale siano, in qualche modo, tutti destinati a fallire. Proprio per l’imprevedibilità dei processi storici che, pur mantenendo spesso caratteristiche unitarie all’interno di un medesimo modo di produzione, possono riformularsi, espandersi e prendere strade che gli esercizi previsionali precedenti non potevano nemmeno immaginare.
E’ proprio l’efficace introduzione di German A. Duarte al volume che raccoglie gran parte dei materiali pubblicati sulla rivista «Un’ambigua utopia» (d’ora in avanti citata come UAU) a dimostrare come anche i migliori tentativi di anticipazione sociale, politica e culturale siano, in qualche modo, tutti destinati a fallire. Proprio per l’imprevedibilità dei processi storici che, pur mantenendo spesso caratteristiche unitarie all’interno di un medesimo modo di produzione, possono riformularsi, espandersi e prendere strade che gli esercizi previsionali precedenti non potevano nemmeno immaginare.
German A. Duarte, nato a Bucaramanga (Colombia) nel 1983, dopo aver frequentato la Scuola di Cinema e Nuove Tecnologie di Lione (ARFIS) si è trasferito in Italia, dove attualmente è ricercatore presso la Libera Università di Bolzano. I suoi interessi di ricerca si muovono tra il cinema, le nuove tecnologie, la fantascienza, la produzione di valore nell’era digitale. Tra le sue pubblicazioni: Fractal Narrative. About the Relationship Between Geometries and Technology and Its Impact on Narrative Spaces (Transcript, 2014), La scomparsa dell’orologio universale (Mimesis, 2009); ha curato Reading Black Mirror. Insights into Technology and the Post-media Condition (Transcript, 2021). Ha inoltre pubblicato su «Carmillaonline»: West World: la valle della disrupzione, diviso in tre parti uscite nel marzo/aprile 2023.
Per DeriveApprodi ha curato questo «I reietti dell’altro pianeta». Un’Ambigua Utopia e le società del futuro, rendendo più agile la consultazione di una rivista che, inizialmente in formato di fanzine, tra il 1977 e il 1982, in soli nove numeri, diede vita ad una riflessione sul ruolo della fantascienza nel ridefinire oppure soltanto definire un’immagine del futuro anticipatrice dei cambiamenti oppure della continuità dell’esistente e del modo di produzione di cui era espressione.
La rivista era già stata ristampata integralmente in due volumi dalle edizioni Mimesis nel 20092, ma quella attuale (che pure contiene ancora una postfazione di Spagnul in appendice) risulta di più facile consultazione, sia per la scelta di testi operata che per il fatto di non essere in “copia anastatica” come quella precedente, piuttosto difficile da consultare visto il carattere di fanzine ciclostilata dei primi numeri della stessa. Ma al di là degli aspetti puramente formali, è proprio il discorso di “indirizzo” sviluppato dal curatore a rendere interessante questa nuova edizione.
Il volume che avete tra le mani […] sofferma lo sguardo sui modi in cui l’era industriale ha immaginato l’era post-industriale al fine di contribuire a rendere intelligibili alcuni elementi di quello che abbiamo chiamato al di là della prassi. Il testo aspira a fare luce su alcuni aspetti del meccanismo che permette, in maniera collettiva, di immaginare un futuro che non è chiaramente tracciato o inserito in una serie lineare di causa-effetto. In altre parole, il testo vorrebbe esplorare quell’entità astratta che chiamiamo immaginario e i modi in cui, attraverso questo, sia possibile territorializzare un futuro non tracciato, un futuro che sembra sfuggire una sorta di sequenzialità apparente. È da lì che nasce l’interesse per le esperienze degli anni Settanta.
[…] UAU è senza dubbio una testimonianza rilevante della forma in cui i movimenti di sinistra si sono appropriati delle narrazioni popolari di questo genere con l’intenzione di «occupare l’immaginario». Eppure, occupare l’immaginario non era altro che il tentativo di immaginare il futuro; immaginare un futuro non tracciato. Bisogna ricordare che nel secolo delle ideologie l’unico tempo modificabile era il passato; il futuro era semplicemente un virtuale ormai coniugato dal presente. Lo mostrava chiaramente Orwell nel suo fondamentale 1984. Di conseguenza l’occupazione dell’immaginario sostenuta dal movimento coincideva nella pratica con una agrimensura di un nuovo immaginario che si sovrapponeva a quello che aveva prodotto l’età industriale. Inoltre, l’occupazione dell’immaginario richiedeva il completo abbandono delle ideologie novecentesche e della loro visione di progresso (da lì il desiderio di voler «distruggere la fantascienza»). Usando la fantascienza come serbatoio di immagini e di fenomeni non ancora esistenti, UAU finì per mettere in luce i limiti di tutto l’apparato teorico ereditato dal Novecento.
Infatti, il radicale materialismo storico del collettivo lo poneva di continuo di fronte all’impossibilità di capire le relazioni sociali che il nuovo contesto tecnologico iniziava a delineare3.
Sostanzialmente, attraverso i nove numeri della rivista, è possibile analizzare sia la generosità di un periodo di lotte, penetrato in profondità nell’immaginario culturale e nella critica che ne scaturiva, che i limiti di ciò che più volte, nel corso del Novecento e, talvolta, già nell’Ottocento, ha voluto definirsi come avanguardia. Termine cui proprio l’editoriale del primo numero della rivista rinviava più meno indirettamente. In quel tentativo di modificare il futuro (della società, dell’arte o dell’immaginario non importa) distruggendo il presente condiviso e il passato degli stessi fattori. Dai quali, sostanzialmente, modificandone l’ordine, non si sarebbe dovuto ottenere lo stesso risultato. Ideale che ha animato tutti i movimenti d’avanguardia, e i loro manifesti, dal Manifesto del Partito Comunista del 1848 fino al Surrealismo e alle successive neo-avanguardie, ma che ne ha segnato irriducibilmente la caducità.
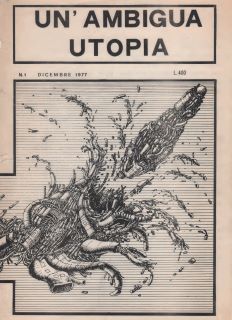 Nell’Editoriale di quel primo numero, pubblicato nel dicembre del 1977 e a cui avevano collaborato Marco Abate, Giancarlo Bulgarelli, Gerardo Frizzati, Danilo Marzorati, Giugliano Spagnul, Michelangelo Milani e Vittorio Curtoni, si affermava:
Nell’Editoriale di quel primo numero, pubblicato nel dicembre del 1977 e a cui avevano collaborato Marco Abate, Giancarlo Bulgarelli, Gerardo Frizzati, Danilo Marzorati, Giugliano Spagnul, Michelangelo Milani e Vittorio Curtoni, si affermava:
Apriamo questo editoriale del primo numero di «Un’ambigua utopia», ponendoci una domanda d’obbligo. Definire cos’è la fantascienza [ma] lo diciamo già da subito, le nostre risposte a questa e ad altre domande, le nostre critiche, analisi, sono di parte. Non cerchiamo la verità assoluta, il Santo Graal. Cerchiamo di fornire una risposta di classe. Una risposta che parte dalle nostre esigenze, dalla nostra scelta di lavorare per l’una o per l’altra classe.
A seconda del proprio pensiero politico allora? Ma cosa c’entra la fantascienza con la politica? […]
Non sono le scommesse sul futuro quelle che ci interessano […] è una scommessa sull’oggi. Scienza, strumento, indagine per riappropriarci della fantasia, della creatività, del godimento. Ecco, ci siamo. Questa è la nostra verità, la verità che ci interessa. La nostra fantasia, la creatività, la spontaneità, il gioco, il piacere il godimento. Tutto questo è stato occultato, seppellito, represso dalla scienza ufficiale, che ha assunto il proprio idolo nel cosiddetto «principio di realtà».
La fantascienza è invece portavoce del «principio del piacere». In pratica i bisogni del capitale, contro i bisogni dell’uomo.
Il capitale deve, per sopravvivere e svilupparsi reprimere i veri bisogni dell’uomo, per sostituirli con i suoi bisogni (creare nuovi prodotti e creare l’esigenza di consumarli), con un modello di vita e di società a lui congeniale (la famiglia, la scuola, la caserma, il lavoro salariato ecc. ecc.).
La fantascienza è un segno di rivolta a tutto questo, è la riscossa del principio del «piacere» sul principio di «realtà».
[…] Noi non siamo dei sostenitori della SF, non siamo dei fans. Non vogliamo allargare, far crescere, propagandare la fantascienza. Vogliamo distruggerla.
Nel senso che vogliamo rompere questo involucro questo contenitore che si chiama
fantascienza, e dimostrare che ciò che contiene, ciò che c’è dentro, non è altro
che quello che si trova fuori.
[…] La parola fantascienza sancisce la non veridicità di quello che essa ingloba. La non realtà.
La presenza della parola fantasia, annulla l’ufficialità e pertanto la realtà della scienza. La politica è la vita e perciò la realtà. La fantascienza, essendo la non-realtà, non può quindi essere politica. Quale miglior travestimento per una politica reazionaria.
Se, ad esempio, Heinlein, Anderson, Vance e altri facessero letteratura «normale » o filosofia invece di SF o fantasy, la loro linea politica sarebbe scoperta, palese e il loro pubblico sarebbe solamente quello che già in partenza è d’accordo con loro. Con la copertura della fantascienza, e perciò della neutralità dal politico, essi possono arrivare a un pubblico ben più vasto (anche di sinistra) e propagandare la loro bieca filosofia reazionaria.
[…] E, pertanto, modelli, parametri di interpretazione della realtà, falsi bisogni, vengono introiettati e messi in grado di operare a livello inconscio.
Per i contenuti rivoluzionari o solo progressisti, invece, il discorso è l’opposto. Qualunque proposta di un mondo, di vita alternativa, è fantascientifica.Se l’alternativa rivoluzionaria è ghettizzata nella fantascienza, è perché si può soltanto sognare e non praticare.
[…] Quale in concreto allora il nostro compito?
Noi crediamo che sia il ripercorrere a marcia indietro la strada che intercorre tra una ben precisa ideologia, il pensiero e l’opera di fantascienza, svelando così, da una parte, i contenuti reazionari, e dall’altra contribuendo a realizzare un’analisi scientifica sui problemi di un modo di vita alternativo, per imparare a praticare l’utopia, anziché sognarla 4.
La dichiarazione d’intenti era chiara, ma come ogni manifesto o altra iniziativa tesa a definire un canone o un modello interpretativo, in questo caso di lettura classista del “genere fantascienza”, una volta per tutte, avrebbe finito con lo scontrarsi con la realtà dei fatti. Come sottolinea ancora il curatore nelle pagine finali dell’introduzione.
Il numero nove, apparso nel secondo trimestre del 1982, segnerà la fine di questa esperienza.
[…] Si percepisce in qualche modo che il serbatoio d’immaginario della fantascienza si era ormai esaurito, come il secolo che si stava chiudendo. Come qualche anno dopo avrebbe affermato James Ballard: «Secondo me la fantascienza è morta. È un movimento della metà del XX secolo che ora si è concluso. Credo che abbia vinto. Ha ottenuto una grande vittoria. Ha creato la letteratura popolare più importante del XX secolo. L’immaginario fantascientifico che vediamo nel cinema, nella televisione, nelle pubblicità e così via, è l’immaginario più potente che il XX abbia creato. Si potrebbe dire che la fantascienza è morta proprio perché ha trionfato. Non è morta perché ha perso, è morta perché ha vinto».
Come ben sintetizza Ballard, il successo della fantascienza non è stato nel prevedere un futuro, ma nel generare il nostro presente, oltretutto un presente che il collettivo di UAU rifiutava. Allo stesso tempo, le parole di Ballard ci mostrano che l’obiettivo originale di UAU, «il voler distruggere la fantascienza» si è risolto in un fallimento5.
E questo non soltanto perché quel concetto di scientificità della previsione, già rivendicato nel testo di Engels citato in apertura, avrebbe finito col far nuovamente precipitare nell’Utopia (quindi in ciò che deve essere forzatamente superato dagli eventi e dai conflitti reali) ciò che avrebbe voluto superarla, e neppure per quanto afferma Diego Gabutti, nella seconda delle tre postfazioni, ovvero che:
A descrivere il futuro non provano neanche più le allegorie utopistiche (ma anche distopiche, è lo stesso) d’un tempo più felice, quello dei movimenti radicali e delle teorie politiche ed escatologiche ottimiste, positive. A parlarci di futuro oggi è il cyberpunk, o il ciclo dei Terminator cinematografici, dove il futuro pesa come un incubo sul presente, oppure dove uomo e macchina si fondono tra loro e a chi entra nei mondi virtuali della rete agognando sollievo dal tempo presente conviene lasciare «ogni speranza», come a Dante giunto alle porte dell’inferno. Oggi l’utopia, lungi dall’essere soltanto ambigua, come sui pianeti gemelli di Ursula Le Guin e nella ragion sociale del collettivo e della rivista che qui ricordiamo, è sprofondata in mare, al pari d’Atlantide e Mu e d’ogni altro continente perduto […] A spiegarci quanto sia oggi inimmaginabile e indescrivibile il futuro sono le versioni cinematografiche delle storie di Philip Dick, delle quali (esagerandone un po’ l’importanza) negli ultimi anni si è celebrato il culto: Blade Runner, A Scanner Darkly, Minority Report, Radio Free Abemuth.
Dal futuro, d’un tratto, si deve distogliere lo sguardo, come a Los Alamos dall’orizzonte, prima che esploda la Bomba devastratrice e che Shiva Distruttore di Mondi cominci a danzare sulle rovine del mondo6.
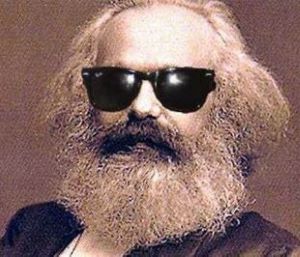 A superare le previsioni del collettivo di UAU sarebbero stati proprio alcuni scrittori italiani che, al contrario del nichilismo che caratterizzava secondo i suoi rappresentanti scrittori come Lino Aldani o Vittorio Curtoni, proprio a partire dagli anni in cui si chiudeva l’esperienza della rivista avrebbero saputo lanciare lo sguardo sul futuro di guerre che oggi ci ha “finalmente” raggiunto e il passato che ha contribuito a determinarlo: Sergio Altieri (meglio conosciuto come Alan D. Altieri)7 e Valerio Evangelisti8.
A superare le previsioni del collettivo di UAU sarebbero stati proprio alcuni scrittori italiani che, al contrario del nichilismo che caratterizzava secondo i suoi rappresentanti scrittori come Lino Aldani o Vittorio Curtoni, proprio a partire dagli anni in cui si chiudeva l’esperienza della rivista avrebbero saputo lanciare lo sguardo sul futuro di guerre che oggi ci ha “finalmente” raggiunto e il passato che ha contribuito a determinarlo: Sergio Altieri (meglio conosciuto come Alan D. Altieri)7 e Valerio Evangelisti8.
Il volume curato da German Duarte si rivela comunque estremamente utile per ripercorrere le tappe di un’esperienza che, per quanto superata, nasconde ancora tra le sue pagine motivi di grande interesse analitico sull’immaginario di un’epoca e allo stesso tempo godibilissime dal punto di vista letterario. Di fatto imperdibile per chiunque si interessi di critica radicale e letteratura d’anticipazione.
F. Engels, L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza (1880), versione di Leonardo Maria Battisti, novembre 2017 (qui) ↩
A. Caronia, G. Spagnul (a cura di), Un’ambigua utopia. Fantascienza, ribellione e radicalità negli anni ’70, Edizione integrale, voll. I e II, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2009. ↩
G. A. Duarte, Un’Ambigua Utopia. Mappatura di un “al di là della prassi”, in G.A. Duarte, (a cura di), «I reietti dell’altro pianeta». Un’Ambigua Utopia e le società del futuro, DeriveApprodi, Bologna 2024, pp. 10-11. ↩
Editoriale, «Un’ambigua utopia» n.1, dicembre 1977, ora in G. A. Duarte (a cura di), op. cit. pp. 20-22. ↩
G.A. Duarte, op. cit, p. 15. ↩
D. Gabutti, Guardando avanti, in G. A. Duarte, op. cit., p. 473. ↩
In particolare con i due romanzi Città oscura (Dall’Oglio, 1981) e L’occhio sotterraneo (Dall’Oglio, 1983) ↩
In particolare con i romanzi del ciclo di Eymerich, iniziatosi con straordinario successo nel 1994 con Nicolas Eymerich, inquisitore (Urania 1241, 2/10/1994.) ↩



