di Diego Gabutti
 Roma, 1984. Sergio Leone – al quale s’accennava la volta scorsa, facendo notare l’impressionante somiglianza tra Feliks Ėdmundovič Dzeržinskij, il capo della Čeka bolscevica, e Lee Van Cleef, «il cattivo» di Il buono, il brutto, il cattivo – una volta mi fece notare quanto fosse strano che l’Urss del 1961 o 1962, dopo pochi giorni di programmazione, avesse ritirato dalle sale I magnifici sette, il classico western di John Sturges importato, dopo lunga riflessione, a sostegno del disgelo. Mai nessuno, nemmeno Ėjzenštejn, aveva girato un film così leninista, mi disse Leone: ci sono le masse oppresse, c’è una classe di sfruttatori a cavallo con sombrero e cartuccera a tracolla, ma soprattutto c’è un partito di pistoleros che, al pari dei rivoluzionari di professione evocati da Lenin, organizzano e amministrano le lotte, come nel Che fare?
Roma, 1984. Sergio Leone – al quale s’accennava la volta scorsa, facendo notare l’impressionante somiglianza tra Feliks Ėdmundovič Dzeržinskij, il capo della Čeka bolscevica, e Lee Van Cleef, «il cattivo» di Il buono, il brutto, il cattivo – una volta mi fece notare quanto fosse strano che l’Urss del 1961 o 1962, dopo pochi giorni di programmazione, avesse ritirato dalle sale I magnifici sette, il classico western di John Sturges importato, dopo lunga riflessione, a sostegno del disgelo. Mai nessuno, nemmeno Ėjzenštejn, aveva girato un film così leninista, mi disse Leone: ci sono le masse oppresse, c’è una classe di sfruttatori a cavallo con sombrero e cartuccera a tracolla, ma soprattutto c’è un partito di pistoleros che, al pari dei rivoluzionari di professione evocati da Lenin, organizzano e amministrano le lotte, come nel Che fare?
Ricordo che all’epoca, mentre finiva di montare C’era una volta in America e ogni tanto lo andavo a trovare, mi disse proprio questo, ma non è di questo che intendo parlare adesso. Voglio parlare del fatto che una volta, passato all’Eur per fare due chiacchiere, lui era preso dal montaggio e io dopo un po’ mi stufai di stare a guardare. C’erano questi fotogrammi che piroettavano avanti e indietro da mezz’ora, De Niro o Joe Pesci (non mi ricordo) che sorrideva (avanti di qualche fotogramma) e poi il sorriso (indietro) che gli si cancellava dalla faccia, un loop, una danza, acceleriamo diceva la montatrice, rallentiamo diceva lui. E così cominciai a leggere il libro che avevo con me. Era I costruttori di Ringworld di Larry Niven (The Ringworld Engineers, 1979). Sedetti in un angolo, accesi una sigaretta e, fin dalla prima riga del primo capitolo, appresi con sgomento che Louis Wu, lo scopritore di Ringworld, era finito «sotto il filo».
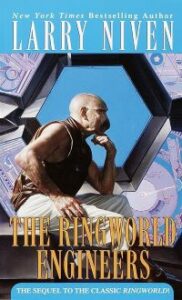 Louis Wu un tossico della corrente! Diavolo! Louis Wu! Non potevo crederci. Che ne era stato dell’eroe senza macchia che, assunto dai Burattinai di Pierson, una specie aliena di codardi congeniti, aveva esplorato in un precedente romanzo (Ringworld, 1970, da noi I Burattinai, e anche Burattinai nel cosmo) un magnifico e terrificante habitat artificiale: Ringworld, il mondo ad anello, la cui superficie era pari, fatti due conti sulle dita, a qualcosa come trenta milioni o miliardi di volte la superficie della Terra.
Louis Wu un tossico della corrente! Diavolo! Louis Wu! Non potevo crederci. Che ne era stato dell’eroe senza macchia che, assunto dai Burattinai di Pierson, una specie aliena di codardi congeniti, aveva esplorato in un precedente romanzo (Ringworld, 1970, da noi I Burattinai, e anche Burattinai nel cosmo) un magnifico e terrificante habitat artificiale: Ringworld, il mondo ad anello, la cui superficie era pari, fatti due conti sulle dita, a qualcosa come trenta milioni o miliardi di volte la superficie della Terra.
Una sonda burattinaia senza equipaggio, monitorando quella particolare regione della galassia per capire se c’era da aspettarsene guai e in questo caso come scansarli o farli spazzar via da qualcun altro, s’era imbattuta in questo strabiliante, esorbitante manufatto alieno. Persino i Burattinai, che avevano trasformato il loro mondo natale e diversi altri corpi astronomici in una sorta di convoglio spaziale in viaggio verso il vuoto intergalattico per scampare a una catastrofe galattica prevista per un futuro remoto, restarono basiti alla vista di Ringworld. Qualcuno – e per il momento ancora non sapevamo chi – aveva edificato l’anello (senza neanche poter ricorrere a un bonus 110 per cento) utilizzando tutta la materia presente in quel particolare sistema solare. Adesso l’anello circondava la stella locale come un’aureola la testa d’un santo.
Dotato di un’atmosfera respirabile da parte delle principali specie della Via Lattea, buona per i polmoni terrestri come per quelli burattinai, buona pure per gli «kzin», sorta di ferocissimi orsi guerrieri originari della stella 61 Ursae Majoris, Ringworld era abitato da colonie di discendenti d’alcune specie galattiche, umani in particolare, ma anche «kzin», trapiantati qui chissà quando e chissà perché. Gli umani di Ringworld, mentre trascorrevano i tempi cosmici, si erano evoluti in un vasto spettro di sottospecie tra loro molto diversificate, ciascuna delle quali occupava una diversa nicchia ecologica. Uomini-topo, uomini-elefante, uomini-vampiro.
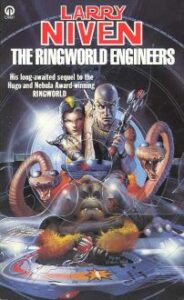 Era qui che Louis Wu, nel primo romanzo, accompagnato da un Burattinaio dotato di coraggio e dunque pazzo, da una ragazza geneticamente predisposta a essere baciata dalla fortuna, da uno kzin non troppo feroce, precipitava con la sua astronave. Avventure, incontri, battaglie, amori. E alla fine, dopo averne esplorato un insignificante zinzino, molto meno della centomiliardesima parte della sia superficie, Louis Wu riusciva a lasciare Ringworld e a tornare sano e salvo nello Spazio Conosciuto insieme al burattinaio, allo kzin e a un’umana di Ringworld. Teela Brown, la ragazza, era rimasta su Ringworld, dove aveva incontrato, assistita dalla fortuna, l’amore della sua vita: un Adone biondo, palestrato e immortale, praticamente un incrocio tra Tarzan, Fred Astaire e James Bond.
Era qui che Louis Wu, nel primo romanzo, accompagnato da un Burattinaio dotato di coraggio e dunque pazzo, da una ragazza geneticamente predisposta a essere baciata dalla fortuna, da uno kzin non troppo feroce, precipitava con la sua astronave. Avventure, incontri, battaglie, amori. E alla fine, dopo averne esplorato un insignificante zinzino, molto meno della centomiliardesima parte della sia superficie, Louis Wu riusciva a lasciare Ringworld e a tornare sano e salvo nello Spazio Conosciuto insieme al burattinaio, allo kzin e a un’umana di Ringworld. Teela Brown, la ragazza, era rimasta su Ringworld, dove aveva incontrato, assistita dalla fortuna, l’amore della sua vita: un Adone biondo, palestrato e immortale, praticamente un incrocio tra Tarzan, Fred Astaire e James Bond.
E adesso il «filo». Che brutta fine! Wu s’era fatto impiantare nel cucuzzolo un «droud» collegato (spiegava sbrigativamente Niven) «col centro del piacere del cervello». Ora gli bastava attaccarsi con un cavo alla prima presa di corrente per darsi alla beanza. Era diventato, lui, un eroe, che nemmeno il Flash Gordon di Dan Barry (ci torniamo) gli fa un baffo, qualcosa come il cavo lightning del mio iPad.
 Mi alzai dall’angolo in cui, poco prima, mi ero seduto a leggere e raggiunsi Leone alla moviola. Joe Pesci (o De Niro che fosse) continuava a sorridere e a non sorridere più. C’era qualcosa d’inquietante in quello spezzone di film. Probabilmente, a quel punto, accesi una sigaretta. Leone non fumava, aveva smesso: problemi cardiaci che qualche anno dopo – ahicinema, ahinoi – gli sarebbero stati fatali. Ai tempi, nei primi ottanta, non era necessario chiedere il permesso di fumare. Ora, quasi quarant’anni dopo, non fumo più, sono quindici anni suonati dall’ultima sigaretta, ma allora consumavo minimo cinquanta sigarette al giorno, sempre attaccato al narghilè come Wu alle prese di corrente (oggi fumare mi costerebbe una fortuna). Allora, quando fumavi, nessuno protestava. Accendevi senza badarci, nessuno faceva caso alla tua sigaretta. Non saprei dire se era meglio o peggio. Forse peggio.
Mi alzai dall’angolo in cui, poco prima, mi ero seduto a leggere e raggiunsi Leone alla moviola. Joe Pesci (o De Niro che fosse) continuava a sorridere e a non sorridere più. C’era qualcosa d’inquietante in quello spezzone di film. Probabilmente, a quel punto, accesi una sigaretta. Leone non fumava, aveva smesso: problemi cardiaci che qualche anno dopo – ahicinema, ahinoi – gli sarebbero stati fatali. Ai tempi, nei primi ottanta, non era necessario chiedere il permesso di fumare. Ora, quasi quarant’anni dopo, non fumo più, sono quindici anni suonati dall’ultima sigaretta, ma allora consumavo minimo cinquanta sigarette al giorno, sempre attaccato al narghilè come Wu alle prese di corrente (oggi fumare mi costerebbe una fortuna). Allora, quando fumavi, nessuno protestava. Accendevi senza badarci, nessuno faceva caso alla tua sigaretta. Non saprei dire se era meglio o peggio. Forse peggio.
Vado a letto presto, come dice Noodles nel film, e così non rivedo C’era una volta in America, che ogni tanto passa in tv, da molto tempo. Pertanto non ricordo se nel film gli attori fumano, ma mi sembra di sì. Tutti fumavano, a Roma-Eur nel 1984, quando Leone stava montando il suo nuovo e ultimo film, esattamente come tutti fumavano anche nel Lower East Side di Manhattan negli anni in cui capitavano tutte le cose turche del film (stupri, rapine, omicidi, tradimenti). Guardavo il segmento di montaggio danzare prima lento e poi veloce nella moviola – sorrido, non sorrido più, sorrido ancora – e intanto provavo a immaginare che specie di film, se mai si fosse convertito agli effetti speciali, cosa naturalmente inimmaginabile, il regista di Giù la testa avrebbe potuto trarre da Ringworld, dai burattinai, da Teela Brown, da Cacciatore, dagli kzin, da Louis Wu.
 Be’, pensai, c’è un anello nel suo terzo western, Il buono, il brutto, il cattivo, l’ultimo della trilogia con Clint Eastwood. Questo film, ammiratissimo, tra la Grande guerra di Mario Monicelli e Via col vento, era stato girato due anni prima che con C’era una volta il west, nel 1968, Leone cambiasse per sempre la storia del cinema, come hanno capito, tra gli altri, Martin Scorsese e Quentin Tarantino, ma andiamo avanti. C’era dunque quest’anello, una polverosa arena circolare all’interno del cimitero militare, ed era lì all’interno dell’anello che il buono, il brutto e il cattivo s’affrontavano in «triello». Gli occhi del brutto schizzavano dal buono al cattivo, la mano del cattivo col dito mozzato s’avvicinava e s’allontanava dal calcio della pistola, la musica di Morricone nell’aria, la perfetta assoluta e gelida calma del buono (chissà quanto sarà durato il montaggio di questa scena, accelera, rallenta, mi chiesi, ricordandola). Dove voglio arrivare? Ecco, voglio arrivare al fatto che anche l’anello di questo film è a suo modo un anello cosmico.
Be’, pensai, c’è un anello nel suo terzo western, Il buono, il brutto, il cattivo, l’ultimo della trilogia con Clint Eastwood. Questo film, ammiratissimo, tra la Grande guerra di Mario Monicelli e Via col vento, era stato girato due anni prima che con C’era una volta il west, nel 1968, Leone cambiasse per sempre la storia del cinema, come hanno capito, tra gli altri, Martin Scorsese e Quentin Tarantino, ma andiamo avanti. C’era dunque quest’anello, una polverosa arena circolare all’interno del cimitero militare, ed era lì all’interno dell’anello che il buono, il brutto e il cattivo s’affrontavano in «triello». Gli occhi del brutto schizzavano dal buono al cattivo, la mano del cattivo col dito mozzato s’avvicinava e s’allontanava dal calcio della pistola, la musica di Morricone nell’aria, la perfetta assoluta e gelida calma del buono (chissà quanto sarà durato il montaggio di questa scena, accelera, rallenta, mi chiesi, ricordandola). Dove voglio arrivare? Ecco, voglio arrivare al fatto che anche l’anello di questo film è a suo modo un anello cosmico.
È più un habitat magnifico e terrificante che una qualsiasi location cinematografica, pensai, montando come al solito (difetto mio, vai a guarirne) la panna delle metafore. Buoni, brutti e cattivi, pensai, sono a loro modo specie diverse. Proprio come gli «kzin», gli umani, i burattinai e le altre specie che popolano lo Spazio Conosciuto, tra cui gli Estranei, i Bandersnatchi, i Trinoc, i Jotoki, anche i buoni e i brutti e i cattivi sono aliens tra loro: la storia del mondo, da Caino e Abele in avanti, è lì a dimostrarlo. Quando dicono, sintetizzando e riepilogando, che la storia è storia di lotte di classe, è questo che intendono Marx ed Engels: che buoni, brutti e cattivi, tra loro incompatibili e nemici, s’affrontano selvaggiamente, a cornate, fin dalla fondazione del mondo per decidere chi vive e chi muore, chi obbedisce e chi comanda, l’«attenti» e il «riposo». È quel che racconta, in forma più allegorica, anche H.G. Wells nella Macchina del tempo (The Time Machine, 1895): Eloi e Morlock, o meglio Morlocchi, come nelle prime traduzioni italiane, stirpi che rispettivamente derivano dalla nostra borghesia e dal nostro proletariato, sono due distinte specie di post-umani, una di mostruosi cannibali, l’altra di graziose merendine autocoscienti, che nel nostro futuro, «802.701 anni da oggi», occupano ciascuno la propria nicchia ev0lutiva, siccome le specie derivate da homo sapiens su Ringworld.
Sono aliens tra loro, in Per un pugno di dollari, il primo western di Sergio Leone, che nel 1964 sbancò ogni botteghino da Roma a Los Angeles, le due famiglie rivali, i Baxter e i Rojo, che si scannano per il controllo di San Miguel, «un tetro villaggio americano di confine» (con un nome da Carosello: «Mama, mama / lo sai che c’è»). «Da una parte i Rojo, dall’altra i Baxter», dice Clint Eastwood, fino a quel momento un anonimo e sgalfo attore di telefilm, d’ora in poi icona del cinema e della destra tardonovecentesca, «e io nel mezzo… uhm, si può fare».
 Bello lui, brutti i Rojo, cattivi i Baxter, o viceversa, brutti i Baxter, cattivi i Rojo, o sia brutti sia cattivi entrambi, che qui per dipanare un tale nodo metafisico «o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo», come diceva nel Pasticciaccio gaddiano il dottor Ciccio Ingravallo riguardo alle cause delle «inopinate catastrofi», ci vorrebbe (lo dico io) un filosofo hegeliano, meglio se pazzotico, diciamo un Louis Althusser… ecco, insomma, per uscire finalmente dallo gnommero ormai quasi inestricabile di questo capoverso, pensai che il cinema di Sergio Leone aveva in fondo a che fare col libro che, quel giorno, prima seduto in una poltroncina della sala montaggio e poi in piedi, a infastidire montatrice e regista al lavoro, avevo iniziato a leggere.
Bello lui, brutti i Rojo, cattivi i Baxter, o viceversa, brutti i Baxter, cattivi i Rojo, o sia brutti sia cattivi entrambi, che qui per dipanare un tale nodo metafisico «o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo», come diceva nel Pasticciaccio gaddiano il dottor Ciccio Ingravallo riguardo alle cause delle «inopinate catastrofi», ci vorrebbe (lo dico io) un filosofo hegeliano, meglio se pazzotico, diciamo un Louis Althusser… ecco, insomma, per uscire finalmente dallo gnommero ormai quasi inestricabile di questo capoverso, pensai che il cinema di Sergio Leone aveva in fondo a che fare col libro che, quel giorno, prima seduto in una poltroncina della sala montaggio e poi in piedi, a infastidire montatrice e regista al lavoro, avevo iniziato a leggere.
 Leone aveva portato per così a espressione, già nel titolo del suo terzo western, dove ne aveva inventariato le caratteristiche a fuoco la natura, che la storia del mondo e la condizione umana sono il campo di battaglia d’una guerra dei mondi. In pratica la medesima War of the Worlds, tra i gentlemen inglesi e «gl’intelletti vasti, freddi e spietati» del pianeta Marte, che si combatte nell’omonimo romanzo di H.G. Wells, sempre lui. Buoni, brutti e cattivi si sfidano eternamente a «triello» anche nelle guerre fuori e dentro Ringworld tra umani e kzin (a queste guerre Larry Niven, insieme ad altri autori che gli si sono affiancati nel tempo, ha dedicato ben quindici volumi di racconti, tra il 1988 e il 2019: il ciclo noto come Man-Kzin Wars). Perché è di noi, naturalmente, che parlano le storie di fantascienza, comprese le più ardite, quelle in cui compaiono mondi ad anello e, come vedremo, oggetti cosmici persino più impressionanti. Ci sono guerre dei mondi in corso sulla Terra anche in questo momento. Sempre la stessa guerra dei mondi, in realtà. Dai poemi omerici in avanti, registrata in tutte le cronache, la guerra eterna tra dispotismo asiatico e società libere non conosce tregua: nessun armistizio, niente prigionieri. Ma tra tutte le guerre la più terribile e brutale è la guerra che oppone il Dr. Jekill a Mr. Hyde e, nel film di Leone, «Tuco» al Biondo, entrambi a Sentenza, l’uomo alla sua parodia.
Leone aveva portato per così a espressione, già nel titolo del suo terzo western, dove ne aveva inventariato le caratteristiche a fuoco la natura, che la storia del mondo e la condizione umana sono il campo di battaglia d’una guerra dei mondi. In pratica la medesima War of the Worlds, tra i gentlemen inglesi e «gl’intelletti vasti, freddi e spietati» del pianeta Marte, che si combatte nell’omonimo romanzo di H.G. Wells, sempre lui. Buoni, brutti e cattivi si sfidano eternamente a «triello» anche nelle guerre fuori e dentro Ringworld tra umani e kzin (a queste guerre Larry Niven, insieme ad altri autori che gli si sono affiancati nel tempo, ha dedicato ben quindici volumi di racconti, tra il 1988 e il 2019: il ciclo noto come Man-Kzin Wars). Perché è di noi, naturalmente, che parlano le storie di fantascienza, comprese le più ardite, quelle in cui compaiono mondi ad anello e, come vedremo, oggetti cosmici persino più impressionanti. Ci sono guerre dei mondi in corso sulla Terra anche in questo momento. Sempre la stessa guerra dei mondi, in realtà. Dai poemi omerici in avanti, registrata in tutte le cronache, la guerra eterna tra dispotismo asiatico e società libere non conosce tregua: nessun armistizio, niente prigionieri. Ma tra tutte le guerre la più terribile e brutale è la guerra che oppone il Dr. Jekill a Mr. Hyde e, nel film di Leone, «Tuco» al Biondo, entrambi a Sentenza, l’uomo alla sua parodia.
C’è una ragione, scopro continuando a leggere, se Wu è diventato un tossico della corrente e una «testa-di-filo»: la donna di Ringworld (che con lui ha lasciato l’anello alla fine del primo romanzo, Wu al confronto un nanerottolo, lei alta e calva e bellissima, persino barbuta se non ricordo male) è stata sequestrata dalle autorità terrestri, che ne vogliono indagare lo gnommero genetico, ma che soprattutto hanno mire sull’anello, che potrebbe diventare il centro dell’impero umano se soltanto si trovasse il modo d’impadronirsene e di difenderlo dai predoni. Wu, che ha cercato di liberare la donna senza riuscirci, e poi ha saputo che questa è morta, è a sua volta ricercato dai servizi segreti terrestri, che vogliono spremergli ogni informazione sull’anello. Depresso, in fuga attraverso la galassia, Wu ha ceduto alla corrente (ma compatitelo, che non è sua la colpa, è della società). Passano non so quanti anni. Poi lo kzin che di nome fa «Speaker-agli-Animali», già suo compagno d’avventura su Ringworld nel primo romanzo, lo rintraccia su un pianeta periferico, lo carica su un’astronave dopo avergli confiscato il «droud» e, per quanto lui supplichi e minacci, non gli permette più d’allacciarsi alla corrente. Sono diretti a Ringworld, la cui orbita è compromessa; con loro, Nessus il burattinaio.
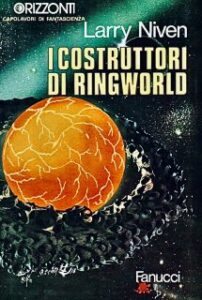 Salterà fuori, prima che The Ringworld Engineers finisca, tutta la storia dell’anello, chi l’ha costruito, in che modo c’entrano gli umani, perché gli kzin, che fine hanno fatto Teela Brown e Cacciatore, come salvare Ringworld dalla catastrofe. Non sto a illustrare tutta la rava e la fava. C’è un’edizione Fanucci che raccoglie l’intera saga: praticamente perfetti (come Mary Poppins) i primi due volumi del ciclo, orrendi i due che seguono. Detto ciò, arrangiatevi, per citare di nuovo Totò. A Roma, quel giorno, non sapevo ancora niente di quel che stava capitando (e sarebbe capitato in futuro) alle incalcolabili moltitudini che popolavano l’anello pur abitandone soltanto una minimissima parte data l’enormità della sua estensione. Soltanto quella sera, tornando a casa, avrei finito di leggere il libro in aereo (che a Roma, in quegli anni, ci andavo per lavoro, mostre da vedere, sbadigli da contenere, tizi da intervistare, robe effimere di cui occuparmi, e adesso che posso scegliere a Roma non ci vado proprio più). Intanto guardavo la moviola, leggiucchiavo, dicevo due parole, Leone annuiva, che aveva altro da fare, e alla fine salutai.
Salterà fuori, prima che The Ringworld Engineers finisca, tutta la storia dell’anello, chi l’ha costruito, in che modo c’entrano gli umani, perché gli kzin, che fine hanno fatto Teela Brown e Cacciatore, come salvare Ringworld dalla catastrofe. Non sto a illustrare tutta la rava e la fava. C’è un’edizione Fanucci che raccoglie l’intera saga: praticamente perfetti (come Mary Poppins) i primi due volumi del ciclo, orrendi i due che seguono. Detto ciò, arrangiatevi, per citare di nuovo Totò. A Roma, quel giorno, non sapevo ancora niente di quel che stava capitando (e sarebbe capitato in futuro) alle incalcolabili moltitudini che popolavano l’anello pur abitandone soltanto una minimissima parte data l’enormità della sua estensione. Soltanto quella sera, tornando a casa, avrei finito di leggere il libro in aereo (che a Roma, in quegli anni, ci andavo per lavoro, mostre da vedere, sbadigli da contenere, tizi da intervistare, robe effimere di cui occuparmi, e adesso che posso scegliere a Roma non ci vado proprio più). Intanto guardavo la moviola, leggiucchiavo, dicevo due parole, Leone annuiva, che aveva altro da fare, e alla fine salutai.
 Non era chiaro, anche se continuavo a pensarci tornando verso il centro, se la mia riflessione sulla natura cosmica del cinema di Leone aveva un qualsiasi senso. In Via del Corso, dove presi un caffè, ammisi con me stesso che non ne aveva nessuno, e a questo particolare garbuglio ontologico, che non aveva nessun fondamento, neppure estetico, smisi per un po’ di pensare.
Non era chiaro, anche se continuavo a pensarci tornando verso il centro, se la mia riflessione sulla natura cosmica del cinema di Leone aveva un qualsiasi senso. In Via del Corso, dove presi un caffè, ammisi con me stesso che non ne aveva nessuno, e a questo particolare garbuglio ontologico, che non aveva nessun fondamento, neppure estetico, smisi per un po’ di pensare.
Chissà, comunque, se a Leone non sarebbero piaciute le storie dello Spazio Conosciuto: il buco nero al centro della galassia, le supertecnologie, gli anelli, le specie che non avevano due ma sette o nove sessi (sai girare, con questo cast, una scena osé, ridacchiai). Ne dubitavo. Fortemente. Una volta avevo caldeggiato con lui l’idea, che già un po’ aveva carezzato, di dedicarsi a una riduzione cinematografica in stile Giù la testa della Condizione umana di Malraux. Mi aveva risposto che sì, perché no, ma c’era un problema, che i cinesi sono tutti eguali, vai a distinguerli l’uno dall’altro. Figurarsi gli alieni, gli estranei, gli kzin, i burattinai, gli uomini-pipistrello.
 Aprii I costruttori di Ringworld al bancone del bar per andare avanti di qualche capoverso intanto che soffiavo sulla tazzina di caffè per raffreddarla. Leggevo e pensavo a Jekill e Hyde, ai poemi omerici, al dispotismo asiatico e alle società libere, pensavo ai buoni e ai brutti e ai cattivi. Pensavo a Kurt August Wittfogel. Mai letto niente di suo, né allora né dopo, salvo qualche assaggio qua e là, ma lo stesso pensavo al titolo bello rotondo della sua opera principale: Die Orientalische Despotie. Ahiahi. Era tornato lo gnommero.
Aprii I costruttori di Ringworld al bancone del bar per andare avanti di qualche capoverso intanto che soffiavo sulla tazzina di caffè per raffreddarla. Leggevo e pensavo a Jekill e Hyde, ai poemi omerici, al dispotismo asiatico e alle società libere, pensavo ai buoni e ai brutti e ai cattivi. Pensavo a Kurt August Wittfogel. Mai letto niente di suo, né allora né dopo, salvo qualche assaggio qua e là, ma lo stesso pensavo al titolo bello rotondo della sua opera principale: Die Orientalische Despotie. Ahiahi. Era tornato lo gnommero.



