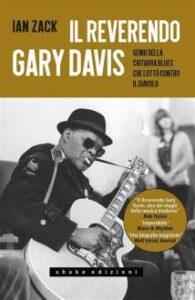di Sandro Moiso
Ian Zack, Il reverendo Gary Davis. Genio della chitarra blues che lottò contro il diavolo, ShaKe Edizioni, Milano 2023, pp. 325, 22 euro
E’ talmente dura dover essere cieco
Sono qui nel buio e procedo a tentoni
E nessuno bada a me (Rev. Gary Davis)
E’ stato sicuramene uno dei maestri della chitarra blues, prova ne sia che musicisti del calibro di Bob Weir (Grateful Dead), Jorma Kaukonen (Jefferson Airplane, Hot Tuna), Stefan Grossman (maestro incontrastato del fingerpicking), Dave Van Ronk, Bob Dylan, Happy Traum, e incalcolabili altri ancora, si sono dichiarati suoi allievi oppure gli hanno pagato più di un tributo interpretando molte canzoni e numerosi brani del suo repertorio. Eppure il reverendo Gary Davis non è certo in cima alla lista dei bluesmen più conosciuti anche nell’ambito degli appassionati oltre che del grande pubblico.
Ian Zack, giornalista newyorkese che ha scritto per il «Washington Post«», il «New York Times», «Forbes» e «Acoustic Guitar» e che ha lavorato come organizzatore di concerti per uno dei più vecchi locali folk della Grande Mela, il Good Coffeehouse, gli ha dedicato un lavoro che ha richiesto anni di ricerche, interviste e ascolti di registrazioni musicali edite e inedite che ha vinto il premio per l’Historicaal Research in Recorded Blues, Gospel, Soul or R&B.
Say No to the Devil, questo il titolo originale dell’opera ora pubblicata in Italia dalle edizioni ShaKe, ricostruisce il percorso di vita, conclusasi il 5 maggio 1972, e musicale del bluesman originario della contea di Laurens nel South Carolina, dove nacque il 30 aprile del 1896. Un percorso difficile, aspro, segnato dalla cecità fin dall’infanzia nella regione del Piedmont che fu, allo stesso tempo, patria di un ben definito stile di blues e arpeggio della chitarra, il Piedmont Style, e un ambiente dai durissimi caratteri razziali e razzisti. Come ricorda l’autore della biografia:
I neri più anziani della contea di Laurens nel South Carolina ancora ricordano molto bene un vecchio traliccio ferroviario, dal quale penzolava da decenni un tratto di corda marcita. A sentir loro, era stata utilizzata l’ultima volta nel 1913 da una masnada di bianchi che avevano linciato un negro accusato di stupro. Il traliccio e la corda sono ormai solo vaghi frammenti di memoria, ma permangono altri spiacevoli ricordi del durissimo ambiente in cui è cresciuto Gary Davis, in particolare il Museo del Ku Klux Klan con annesso Redneck Shop, ospitati in quello che una volta era un cinema segregato. Tra gli oggettini che si possono acquistare allo “shop” ci sono mantelli con cappuccio, adesivi del Klan e fotocopie dei cartelli segregazionisti “Riservato ai bianchi”1.
Ambiente, però, difficile non solo dal punto di vista razziale, ma anche della sopravvivenza quotidiana, sicuramente determinata dal primo, se è vero che Gary fu uno dei due superstiti degli otto figli partoriti da Evelina Davis, di cui sei morirono prima dell’età adulta. Lei e il marito John erano mezzadri e cercavano di vivere del lavoro su terre possedute da altri mentre Gary, il primogenito, nacque quando la madre aveva diciassette anni.
 Se si vuole è un quadro classico quello dipinto da Zack per delineare la prima parte della vita del musicista, che sembra uscito dalle pagine di Caldwell e Faulkner o di altri scrittori, bianche e neri, del Sud degli Stati Uniti. Un quadro in cui la madre, che probabilmente ebbe i figli con uomini diversi, non poteva aver tempo da dedicare alle cure di tutti o anche solo a quello che viene tradizionalmente definito come “amore materno”, in realtà spesso riservato a chi già gode di ben altri “diritti” razziali, economici e sociali. Come se tutto ciò già non bastasse, il padre di Gary, come lo stesso musicista ricordava, era stato ucciso, a colpi di arma da fuoco, quando lui aveva dieci anni, dallo sceriffo di Birmingham in Alabama.
Se si vuole è un quadro classico quello dipinto da Zack per delineare la prima parte della vita del musicista, che sembra uscito dalle pagine di Caldwell e Faulkner o di altri scrittori, bianche e neri, del Sud degli Stati Uniti. Un quadro in cui la madre, che probabilmente ebbe i figli con uomini diversi, non poteva aver tempo da dedicare alle cure di tutti o anche solo a quello che viene tradizionalmente definito come “amore materno”, in realtà spesso riservato a chi già gode di ben altri “diritti” razziali, economici e sociali. Come se tutto ciò già non bastasse, il padre di Gary, come lo stesso musicista ricordava, era stato ucciso, a colpi di arma da fuoco, quando lui aveva dieci anni, dallo sceriffo di Birmingham in Alabama.
Davis non avrebbe potuto ricevere carte peggiori nella partita della vita e, in seguito, avrebbe attribuito la propria sopravvivenza «alla mano del Signore»: gli era stata tolta la vista, ma aveva ricevuto in cambio qualcosa di molto speciale.
Infatti, già da molto giovane, Davis aveva iniziatoa cantare nella chiesa battista di Gray Court sempre in South Carolina, accompagnato dalla chitarra suonata nello stile fingerpicking che egli contribuì a definire, pizzicando le corde con l’indice e il pollice, canzoni e temi tratti dal blues, gospel, ragtime insieme ad altri provenienti dal repertorio tradizionale oppure di sua invenzione su un tempo in quattro parti.
A metà degli anni 1920, si trasferì a Durham, nella Carolina del Nord, un importante centro della cultura nera dell’epoca. Lì insegnò a Blind Boy Fuller e collaborò con un certo numero di altri artisti della scena blues del Piedmont. In seguito, J. B. Long presentò Davis insieme a Fuller all’American Record Company. Quelle sessioni di registrazione del 1935 segnarono l’inizio della carriera di Davis. Divenuto cristiano e ordinato ministro battista Davis iniziò a preferire la musica gospel al blues, notoriamente ritenuto “la musica del diavolo”.
.
 Trasferitosi a New York nel 1940, dove si esibiva in qualità di musicista itinerante e di predicatore agli angoli delle strade, avrebbe vissuto anni nella più nera miseria a fianco della moglie Annie, che avrebbe fatto di tutto per tenerlo lontano dal blues, dalle donne e dall’alcol.
Trasferitosi a New York nel 1940, dove si esibiva in qualità di musicista itinerante e di predicatore agli angoli delle strade, avrebbe vissuto anni nella più nera miseria a fianco della moglie Annie, che avrebbe fatto di tutto per tenerlo lontano dal blues, dalle donne e dall’alcol.
Così mentre, nei primi anni Sessanta la scena rinnovata del folk revival avrebbe riportato in auge bluesmen come Missisippi John Hurt, Skip James, Furry Lewis e Son House, che avevano inciso dischi a 78 giri in gommalacca negli anni ’20 e ’30 per poi ripiombare nell’oscurità di lavori quotidiani umili, spesso legati alla terra, colui «che era stato con ogni probabilità il più grande di ttti i chitarristi blues immortalati su disco prima della Seconda guerra mondiale era già fortunato se poteva crogiolarsi alla tenue luce della sua cerchia di ammiratori.»2
Peter, Paul e Mary registrarono la versione di Davis di Samson and Delilah, conosciuta anche come If I Had My Way, una canzone di Blind Willie Johnson, che Davis aveva reso popolare. I diritti d’autore risultanti da quel successo permisero a Davis di comprare una casa, cui Davis si riferiva sempre come alla “casa che Peter, Paul e Mary costruirono”, nella quale visse insieme alla moglie per il resto della sua vita, fino all’infarto che lo stroncò nel maggio del 1972.
Ma nonostante ciò e il fatto che, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, molte altre sue canzoni fossero rese celebri da musicisti e cantanti di largo successo tra i giovani e nei festival folk e blues, la relativa oscurità che circonda la sua figura e il suo ruolo seminale nell’uso della chitarra blues
dipende in larga misura dalle sue scelte di vita. Per quanto sia rimasto fino agli ultimi giorni della sua esistenza uno dei più grandi, se non il più grande, di tutti i chitarristi tradizionali blues e ragtime, in quanto uomo di chiesa si rifiutò cocciutamente per gran parte della carriera di eseguire il blues, ossia suonarlo e cantarlo alla propria maniera su un palco o in sala di registrazione […] In un certo senso Davis rovescia la leggenda di Robert Johnson: non ha venduto l’anima al diavolo, come si vocifera abbia fatto Johnson, per acquisire una sovrumana abilità alle prese con la chitarra blues. Invece Davis ha rinunciato alla musica blues nel fiore degli anni per dedicare la vita a Dio in veste di predicatore. Proprio quando le incisioni blues stavano per spalancargli nuove porte professionali o il portafoglio dei discografici, il suo biglietto di sola andata dalla miseria, Davis rifiutò, e anche più di una volta3.
 In realtà questa sua scelta fu ampiamente e spesso contraddetta dallo stile di vita e dalle passioni che lo accompagnarono fino alla fine dei suoi giorni: quella per le giovani ammiratrici e l’alcol. Una battaglia che il Reverendo fu costretto a combattere non solo contro il principe dell’oscurità, ma anche contro i suoi personalissimi demoni.
In realtà questa sua scelta fu ampiamente e spesso contraddetta dallo stile di vita e dalle passioni che lo accompagnarono fino alla fine dei suoi giorni: quella per le giovani ammiratrici e l’alcol. Una battaglia che il Reverendo fu costretto a combattere non solo contro il principe dell’oscurità, ma anche contro i suoi personalissimi demoni.
Passioni che l’ambiente giovanile, alternativo e hippie che spesso lo circondò di attenzioni negli ultimi anni, non fece altro che alimentare. Talvolta con esiti deleteri vista la frequenza con cui Gary Davis finì col salire sul palco ubriaco, incapace o quasi di suonare oppure dedito soltanto ad improvvisare lunghissimi e strampalati sermoni sul peccato e il significato della salvezza davanti ad un pubblico che spesso si annoiava e finiva con l’abbandonare le sue esibizioni.
Una sorta di destino triste, solitario e final che è ben narrato nelle pagine del libro di Zack e che accomuna la vita e l’esperienza del Reverendo a quella di molti altri interpreti afro-americani di blues e soul ciechi. Per i quali, quando non è stato l’alcol, spesso è stata l’eroina a svolgere un ruolo devastante nel corso della carriera.
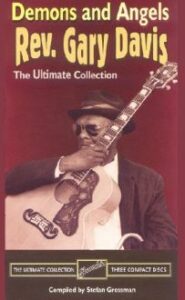 Per l’obbiettività, l’attenzione e il costante amore per il soggetto trattato, nonostante tutto, che lo contraddistinguono, il testo dedicato da Zack al Reverendo Gary Davis può rivelarsi prezioso, a tratti commovente e sicuramente utile, se non imperdibile, per chiunque ami il blues e la cultura afroamericana del ‘900.
Per l’obbiettività, l’attenzione e il costante amore per il soggetto trattato, nonostante tutto, che lo contraddistinguono, il testo dedicato da Zack al Reverendo Gary Davis può rivelarsi prezioso, a tratti commovente e sicuramente utile, se non imperdibile, per chiunque ami il blues e la cultura afroamericana del ‘900.
Un unico appunto va fatto al traduttore, forse non troppo esperto dell’argomento, visto che confonde gli Staple Singers, uno dei più influenti gruppi vocali soul e gospel, impegnati sulla scena dei diritti civili degli anni ’60, con un gruppo vocale femminile scambiando il suo fondatore e patriarca Roebuck “Pops” Staples, grande cantante e chitarrista nello stile swamp blues, per una donna. Forse confondendolo con l’unica superstite del gruppo a base famigliare ancora viva e presente sulla scena musicale e discografica odierna: Mavis Staples, figlia di Pops e sorella degli altri membri del gruppo.
Errore veniale per un testo comunque indispensabile in ogni biblioteca musicale attenta al blues e alla sua influenza sulla scena del rock alternativo americano