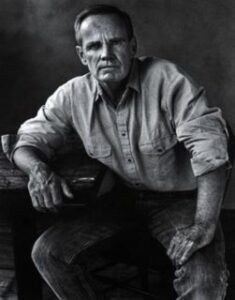di Sandro Moiso
Una volta nei torrenti di montagna c’erano i salmerini. Li potevi vedere fermi nell’acqua ambrata con la punta bianca delle pinne che ondeggiava piano nella corrente. Li prendevi in mano e odoravano di muschio. Erano lucenti e forti e si torcevano su se stessi. Sul dorso avevano dei disegni a vermicelli che erano mappe del mondo in divenire. Di una cosa che non si poteva rimettere a posto. Che non si poteva riaggiustare. Nelle forre dove vivevano ogni cosa era più antica dell’uomo, e vibrava di mistero. (“La strada” – Cormac McCarthy)
Il 20 luglio di quest’anno Cormac McCarthy avrebbe dovuto compiere 90 anni.
Per uno di quegli insondabili moti degli orologi biologici individuali così non è stato e lo scrittore americano se n’è andato il 13 giugno, nella sua casa nei pressi di Santa Fe, nel Nuovo Messico. Tornando a quel mistero, di cui la morte individuale è la massima espressione e manifestazione, di cui parlava nell’ultima riga di uno dei suoi romanzi più conosciuti.
Se la letteratura americana migliore è impregnata del mistero della morte, in tutte le sue possibili forme, Cormac McCarthy ne è stato forse il cantore più coerente e inflessibile.
Morte per violenza, soprattutto, ma anche morte come fine di tutto: di una vita, di un ciclo, di un mondo, talvolta, come in Non è un paese per vecchi, del senso e di qualsiasi tentativo di dare un significato alle azioni degli uomini.
In un mondo che, invece, ha cercato di allontanare da sé la morte, pur producendola in maniera esagerata, continua e con qualsiasi mezzo, trasformandola narrativamente in un accidente, magari irrimediabile, ma pur sempre tale. Un intoppo nel percorso di vite destinate all’eternità non solo spirituale ma anche fisica e alla realizzazione di sé attraverso il consumo e la produzione di ricchezza (quest’ultima decisamente meno egualitaria della morte che, almeno e nonostante gli sforzi di conservazione criogenica della carcassa individuale, in attesa di un futuro migliore, arriva sempre e comunque per tutti).
Come scriveva già il sottoscritto, qualche anno fa, l’ossessione ricorrente nella maggior parte della migliore letteratura americana certo è
quella della morte. E del male. Che spesso la precede e sempre l’accompagna.
Sarà l’origine puritana di gran parte della cultura “bianca” statunitense, ma da Herman Melville a William Faulkner, da Edgar Allan Poe a Ernest Hemingway e da Jack London fino a John Williams la grande mietitrice aleggia su gran parte delle vicende narrate. Anzi si potrebbe forse dire che il “vitalismo” che sembra aver contraddistinto alcuni dei suoi capolavori non avrebbe senso se non fosse accompagnato dalla sua ombra costante.
Eppure quanta profondità, quanto nichilismo, quanta disperata solitudine, quanta assenza di qualsiasi forma di salvezza contengono quelle pagine. Dai racconti western di Bret Harte a Mark Twain e da Howard P.Lovecraft a Larry McMurtry, solo per citarne alcuni e di epoche diverse.
L’umorismo della frontiera nascondeva quasi sempre la solitudine dell’uomo sulle Grandi Pianure e, per default, la sua eterna solitudine davanti all’universo e alla morte. Mentre l’orrore cosmico non costituiva altro che il suo logico corollario.
Morte mai consolatoria, come il cattolicesimo, inavvertitamente, ha invece spesso suggerito anche ai romantici più agguerriti della letteratura italiana. Male privo di salvezza che, nella migliore tradizione luterana, non poteva e non potrà mai trovare consolazione in alcunché.
Vite e vicende senza speranza, senza significato, senza via d’uscita o possibilità di redenzione. Da Jim Thompson a David Goodis, dal Charles Bukowski di Pulp alla grandissima, eppur cattolicissima, Flannery O’Connor di Un brav’uomo è difficile da trovare1.
McCarthy ha sempre suonato il controcanto del fasullo vitalismo americano e per fare ciò ha smontato ogni mito, a partire da quello della Frontiera e se Morte e Male costituiscono i due caratteri dominanti della grande letteratura d’oltre oceano, allora Cormac McCarthy ne rappresentato la summa. Non solo epocale o generazionale ma, forse, definitiva, tracciando, romanzo dopo romanzo, la storia della morte americana.
Morte e non Storia, soprattutto degli ultimi due secoli. Quelli di solito più celebrati dalla cinematografia di Hollywood e dalla letteratura mainstream. Quelli che hanno visto liberarsi al massimo le forze produttive degli Stati Uniti e, contemporaneamente, anche la loro più violenta forza distruttrice e la più determinata volontà di dominio e rapina. La morte e il male appunto.
Che in Cormac McCarthy sono tutt’altro che metafisici. Sono ben radicati negli individui e nei loro talvolta diabolici oppure talvolta stupidi o, ancora, talvolta soltanto raffazzonati progetti. Vendicarsi, arricchirsi, levarsi al di sopra degli altri uomini oppure semplicemente cercare di sopravvivere o di “essere giusti”: tutto porta alla morte e con sé, inevitabilmente, il male e il dolore.
 Da coloro che cercano di usare a proprio vantaggio lo spietato killer di Non è un paese per vecchi, fino allo sceriffo che rinuncia ad inseguirlo, perché sarebbe soltanto inutile, pericoloso e fallimentare, al killer stesso che sopravvive solo in attesa di portare ancora morte e dolore. Al padre che cerca di proteggere il figlio dai pericoli di un mondo già morto nel romanzo La strada; da Meridiano di sangue, ambientato alla metà dell’ottocento, in poi tutto traccia soltanto il declino, privo di qualsiasi ascesa precedente, del sogno americano. Che, in sostanza, finisce per rivelarsi soltanto per quello che è: un lungo incubo e nient’altro.
Da coloro che cercano di usare a proprio vantaggio lo spietato killer di Non è un paese per vecchi, fino allo sceriffo che rinuncia ad inseguirlo, perché sarebbe soltanto inutile, pericoloso e fallimentare, al killer stesso che sopravvive solo in attesa di portare ancora morte e dolore. Al padre che cerca di proteggere il figlio dai pericoli di un mondo già morto nel romanzo La strada; da Meridiano di sangue, ambientato alla metà dell’ottocento, in poi tutto traccia soltanto il declino, privo di qualsiasi ascesa precedente, del sogno americano. Che, in sostanza, finisce per rivelarsi soltanto per quello che è: un lungo incubo e nient’altro.
Come afferma Malkina, la dark lady di origine argentina che si staglia al centro della vicenda di The counselor (Il procuratore, Einaudi 2013), mentre confessa provocatoriamente i propri impulsi sessuali irrefrenabili ad un parroco vile e spaurito, esaltando la grazia e la bellezza e la ferocia dei grandi felini.
Vedere la selvaggina ammazzata con eleganza mi tocca profondamente […] Una cosa del genere è sempre sessuale. Ma la grazia . La libertà. Il cacciatore ha una purezza di cuore che non esiste da nessuna altra parte. Credo che a definirlo non sia tanto quello che è diventato quanto tutto quello che è riuscito a non essere. Non puoi assolutamente distinguere quello che è da quello che fa. E quello che fa è uccidere. Noi naturalmente siamo un’altra storia. Sospetto che siamo inadatti per la strada che abbiamo scelto. Inadatti e impreparati. Vorremmo stendere un velo su tutto questo sangue e questo terrore. Che ci hanno portati qui. La nostra debolezza di cuore rischia di chiuderci gli occhi su tutto questo, ma facendo ciò fa il nostro destino. Forse non sarai d’accordo. Non so. Ma non c’è niente di più crudele di un codardo, e probabilmente il massacro che verrà supera la nostra immaginazione2.
D’altra parte la stessa Malkina è in qualche modo prodotto e conseguenza di una narrazione letteraria e politica che nasconde la menzogna e la violenza che sono servite a mantenere inalterato il volto perbenista di una società che dopo aver artificialmente rimosso il Ricordati che devi morire della tradizione latina, muore giorno dopo giorno nel dolore di cui, troppo spesso, è essa stessa causa e di cui non vuole sentir nemmeno parlare e in cui la morte e il male sono portati alle estreme conseguenze, mentre solo chi ha già molto sofferto può tentare di sopravvivere. «Non li ho mai conosciuti i miei genitori. Li hanno buttati giù da un elicottero nell’Oceano Atlantico quando avevo tre anni»3.
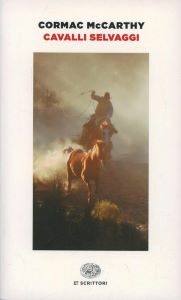 Scorrendo tutte le pagine dell’opera di McCarthy, per certi versi unico vero erede del lato più tragico e provocatorio di William Faulkner, non è difficile capire perché, proprio un attimo prima del raggiungimento del successo con il romanzo All the Pretty Horses (1992 – Cavalli selvaggi, Guida 1993 – Einaudi 1996) che vinse il National Book Award nel 1992, tutte le sue opere precedenti (fino ad allora cinque) fossero uscite dal catalogo della Random House nonostante il successo di critica, non accompagnato però da un adeguato risultato nelle vendite e presso il pubblico. Compreso quello che sarebbe stato poi considerato uno dei suoi capolavori, se non proprio il capolavoro, Blood Meridian, del 1985 (Meridiano di sangue, Einaudi 1996).
Scorrendo tutte le pagine dell’opera di McCarthy, per certi versi unico vero erede del lato più tragico e provocatorio di William Faulkner, non è difficile capire perché, proprio un attimo prima del raggiungimento del successo con il romanzo All the Pretty Horses (1992 – Cavalli selvaggi, Guida 1993 – Einaudi 1996) che vinse il National Book Award nel 1992, tutte le sue opere precedenti (fino ad allora cinque) fossero uscite dal catalogo della Random House nonostante il successo di critica, non accompagnato però da un adeguato risultato nelle vendite e presso il pubblico. Compreso quello che sarebbe stato poi considerato uno dei suoi capolavori, se non proprio il capolavoro, Blood Meridian, del 1985 (Meridiano di sangue, Einaudi 1996).
L’autore americano aveva iniziato la sua carriera nel 1965, all’età di 32 anni. Era un dropout dell’Università del Tennessee, privo di agente letterario, quando aveva sottoposto il dattiloscritto del suo primo romanzo proprio alla Random House. Manoscritto che per puro caso finì sulla scrivania di Albert Erskine, colui che aveva fatto pubblicare Ralph Ellison, Robert Penn Warren e lo scrittore che sembra aver maggiormente ispirato McCarthy: William Faulkner. Erskine apprezzò il “manoscritto” e così la Random House pubblicò il primo romanzo, The Orchard Keeper (Il guardiano del frutteto, Einaudi 2002), un debutto ruvido, strano e decisamente non commerciale, che però già conteneva alcuni dei temi tipici di tutte le sue opere successive.
Se ne sono andati tutti, ormai. Scappati, banditi nella morte o nell’esilio, perduti, rovinati. Sole e vento percorrono ancora quella terra, per bruciare e scuotere gli alberi, l’erba. Di quella gente non rimane alcuna incarnazione, alcun discendente, alcuna traccia. Sulle labbra della stirpe estranea che ora risiede in quei luoghi, i loro nomi sono mito, leggenda, polvere4.
Eccone qui il primo esempio: il Mito della Frontiera e dei suoi uomini liberi e indipendenti, indifferenti alle leggi del progresso e abitatori di una terra selvaggia non è altro che polvere ancor più che polverosa leggenda. Come si afferma nel risvolto di copertina della prima edizione italiana, le vicende «hanno come sfondo un paesaggio arcaico, descritto con una prosa dalle cadenze bibliche che rimanda alla tradizione faulkneriana. I personaggi di McCarthy convivono con una natura che non ha nulla di idilliaco, ma è capricciosa e ostile proprio come i suoi abitanti.»
Un altro dei temi di McCarthy è infatti proprio la Natura, indifferente al destino degli uomini e alle loro storie e la cui sacralità è definita non dall’idillio, ma dalla sua crudeltà e impenetrabilità. Non a caso gli sfondi più spesso descritti dall’autore non sono quelli di colline e paesaggi ameni, ma piuttosto quelli di deserti soleggiati e ricchi di tempeste di polvere, di rocce granitiche e di pianure riarse dal sole. Per precipitare poi, in uno degli ultimi e più noti romanzi, The Road (2006 – La strada, Einaudi 2007) in uno scenario di ceneri e alberi bruciati. In cui la specie muore insieme al mondo che ha finto di poter dominare, soltanto per distruggerlo.
 Erskine smosse mari e monti per promuovere il libro, sollecitando autori come Truman Capote, James Michener e Saul Bellow affinché lo leggessero, ma nonostante questi sforzo promozionale il romanzo vendette poco. Così come il successivo del 1968, Outer Dark (Il buio fuori, Einaudi 1997).
Erskine smosse mari e monti per promuovere il libro, sollecitando autori come Truman Capote, James Michener e Saul Bellow affinché lo leggessero, ma nonostante questi sforzo promozionale il romanzo vendette poco. Così come il successivo del 1968, Outer Dark (Il buio fuori, Einaudi 1997).
Una storia scandalosa e crudele in cui un giovane insegue la sorella, da cui ha avuto un figlio che lui ha cercato di uccidere subito dopo la nascita, attraverso gli stati del Sud degli Stati Uniti all’inizio del ‘900. Una storia di incesto e povertà cui si sovrappone la violenza di un mondo spietato e, come sempre, tinto di rosso cremisi. Con un epilogo di inimmaginabile crudeltà, come se l’entità che sembrerebbe presiedere nella più totale indifferenza le vicende umane avesse finalmente deciso di svelare il proprio ghigno grondante sangue.
Quando la Random House chiese a McCarthy se avesse qualcuno a cui inviare il suo terzo romanzo, Child of God (1973 – Figlio di Dio, Einaudi 2000) la storia di un assassino seriale e necrofilo che terrorizza una contea del Tennessee, l’autore, con una lettera, rispose: «Ed McMahon del Tonight Show, è un conoscente. Siamo stati a pescare insieme a Bimini la primavera scorsa e poi a bere al Cat Cay (fino a quando è caduto dal molo e hanno dovuto portarlo in aereo a Lauderdale per ricorrere alle cure ospedaliere). Provate a fargli giungere una copia del mio libro. Dovrebbe leggerlo (non come beve, certamente, ma più o meno)5.»
 Quel romanzo, ancora una volta, raccontava il trionfo assoluto del Male, incarnato nella figura di Lester Ballard, uno dei tanti white trash che popolano le catapecchie del Sud rurale, le campagne ferme nel tempo in cui la Storia è scandita dai linciaggi e dalle pubbliche impiccagioni, dove la promiscuità e l’incesto costituiscono la regola, dove la miseria e l’abiezione sommergono qualsiasi forma di società strutturata secondo i canoni della modernità. Un mondo destinato a produrre mostri e su cui sembra campeggiare, come in ogni altro romanzo di McCarthy, l’avviso: No politically correct, please.
Quel romanzo, ancora una volta, raccontava il trionfo assoluto del Male, incarnato nella figura di Lester Ballard, uno dei tanti white trash che popolano le catapecchie del Sud rurale, le campagne ferme nel tempo in cui la Storia è scandita dai linciaggi e dalle pubbliche impiccagioni, dove la promiscuità e l’incesto costituiscono la regola, dove la miseria e l’abiezione sommergono qualsiasi forma di società strutturata secondo i canoni della modernità. Un mondo destinato a produrre mostri e su cui sembra campeggiare, come in ogni altro romanzo di McCarthy, l’avviso: No politically correct, please.
Se la casa editrice contattò o meno McMahon non è dato sapere, però anche quel romanzo vendette poco o nulla. Così come il quarto Suttree, pubblicato nel 1979 (Suttree, Einaudi 2009). Romanzo che il critico Stanley Booth definì come il «libro più esilarante di McCarthy, ma anche il più insopportabilmente triste.» Popolato da una schiera di ladri, derelitti, miscredenti, paria, poltroni, furfanti, spilorci, balordi, assassini, giocatori, ruffiani, troie, sgualdrine, briganti, bevitori, ubriaconi, trincatori e quadrincatori, zotici, donnaioli, vagabondi, libertini e debosciati vari.
E’ il mondo di Knoxville, Tennessee, nel 1951 ed è quello in cui vive e sopravvive Cornelius “Buddy” Suttree, il pescatore protagonista delle vicende narrate. L’altra faccia dell’America perbenista narrata dall’immaginario dell’American way of life dunque.
 In quell’occasione l’autore aveva ottenuto il riconoscimento di autorevoli premi letterari e borse di studio finanziate dall’American Academy of Arts and Letters, dalla Fondazione Guggenheim e dalla Fondazione Rockfeller, mentre nel 1981 ne ottenne anche una dalla MacArthur che, come avrebbe scritto ad un amico, rappresentava una piccola “manna” che gli avrebbe permesso «di rimanere nel “business” ancora per un po’.»
In quell’occasione l’autore aveva ottenuto il riconoscimento di autorevoli premi letterari e borse di studio finanziate dall’American Academy of Arts and Letters, dalla Fondazione Guggenheim e dalla Fondazione Rockfeller, mentre nel 1981 ne ottenne anche una dalla MacArthur che, come avrebbe scritto ad un amico, rappresentava una piccola “manna” che gli avrebbe permesso «di rimanere nel “business” ancora per un po’.»
Nel 1976 si era trasferito a El Paso dove si sarebbe in seguito documentato e avrebbe iniziato a scrivere il suo quinto romanzo, Blood Meridian. Un libro violentissimo, l’unico in cui compaiano i nativi americani colti nel momento in cui guerreggiano selvaggiamente contro i bianchi che invadono i loro territori sempre più in profondità e mentre un branco di mercenari, comandati da uno dei personaggi più infernali usciti dalla mente di McCarthy, il giudice, scorrazza sulle pianure del Texas e del Sud-ovest, uccidendo e scalpando i membri delle tribù distribuite a cavallo del confine tra Stati Uniti e Messico.
E’ la storia di un ragazzo che a quattordici anni lascia la casa paterna nel Tennessee e si dirige avventurosamente, disperatamente, coraggiosamente e incoscientemente verso l’Ovest, verso il West. Ma il lettore non si aspetti un romanzo di formazione. L’America, come avverrà poi nel terzo e ultimo romanzo della trilogia della Frontiera, Cities of the Plain (1998 – Città della pianura, Einaudi 1999), non cresce o educa i suoi figli: li divora. In Vietnam come in tante altre inutili guerre ai confini del suo impero, negli slums delle metropoli come sulle pianure secche e aride del West. Tom Sawyer in un romanzo di McCarthy non avrebbe mai avuto il tempo di diventare saggio o adulto, avrebbe avuto soltanto il tempo di morire. Possibilmente in maniera ingiusta e violenta.
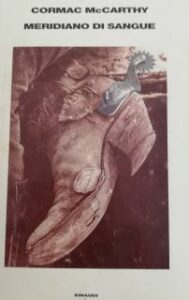 E anche i nativi non sono da cartolina. Non sono soltanto pacifici rappresentanti di un mondo in estinzione davanti all’avanzata dell’uomo bianco. Non espongono la bandiera a stelle e strisce come avviene in Soldato blu6 nel tentativo di non essere massacrati. Combattono, aggrediscono, uccidono, scalpano e stuprano (anche le “giacche blu”), riservando ai bianchi ciò che questi ultimi hanno perpetrato su di loro. Non per nulla Blood Meridian è stato definito, dal critico statunitense Harold Bloom, come «il western definitivo».
E anche i nativi non sono da cartolina. Non sono soltanto pacifici rappresentanti di un mondo in estinzione davanti all’avanzata dell’uomo bianco. Non espongono la bandiera a stelle e strisce come avviene in Soldato blu6 nel tentativo di non essere massacrati. Combattono, aggrediscono, uccidono, scalpano e stuprano (anche le “giacche blu”), riservando ai bianchi ciò che questi ultimi hanno perpetrato su di loro. Non per nulla Blood Meridian è stato definito, dal critico statunitense Harold Bloom, come «il western definitivo».
La brigata intanto si era fermata e vennero sparati i primi colpi e il fumo grigio dei fucili ondeggiò tra la polvere mentre i lancieri rompevano le file. Il ragazzo sentì il cavallo crollare sotto di sé con un lungo sospiro compresso. Aveva già fatto fuoco col suo fucile e adesso si sedette a terra e armeggiò con la giberna.[…] Dappertutto c’erano cavalli a terra e uomini carponi, e ne vide uno intento a caricare il fucile col sangue che gli colava dalle orecchie, e vide uomini col revolver smontato che cercavano di infilare al posto giusto il tamburo di riserva carico di pallottole, e vide uomini i ginocchio che si piegavano di lato ad abbracciare la propria ombra sul terreno, e vide uomini infilzati dalle lance e afferrati per i capelli e scalpati in piedi, e vide i cavalli da combattimento calpestare i caduti e un piccolo pony dal muso bianco con un occhio chiuso emerse dal buio e cercò di morderlo come un cane e poi scomparve7.
E’ sempre una scrittura visionaria quella dell’autore statunitense, in questo senso biblica per la forza delle immagini che sembrano andare in sovrimpressione, soprattutto nella mente di chi legge. Ma nonostante ciò, o forse proprio in virtù di tutto questo, anche il quinto romanzo vendette poco, o nulla. Così a partire dalla seconda metà degli anni ’80 le prospettive di carriera dello scrittore si annunciavano ormai come tetre e desolate.
Nel 1987 Erskine lasciò il suo posto alla Random House per andare in pensione e McCarthy, nel 1989, ebbe modo di scrivere ad un amico: «Sono stato uno scrittore professionale per 28 anni e non ho mai ricevuto un assegno per i diritti d’autore. Penso sia davvero un record.» Ciò significava, al di là dei riconoscimenti ricevuti e della successiva fortuna editoriale, che lo stesso avrebbe dovuto cambiare il modo di presentare i suoi libri agli editori. Soprattutto dopo il ritiro di Erskine.
 E così fu. In un contesto in cui le grandi corporation, proprio a partire dagli anni Ottanta, avevano iniziato ad assorbire un grande numero di case editrici, grandi, medie e piccole, che erano state messe in ginocchio dall’aumento dei prezzi determinato dall’inflazione degli anni settanta che a parità di salari aveva fatto sì che il costo dei libri aumentasse e i lettori diminuissero. Da lì in avanti alla direzione delle case editrici più grandi furono messi uomini che non venivano dalla “letteratura” (come agenti o editori), ma dal marketing,
E così fu. In un contesto in cui le grandi corporation, proprio a partire dagli anni Ottanta, avevano iniziato ad assorbire un grande numero di case editrici, grandi, medie e piccole, che erano state messe in ginocchio dall’aumento dei prezzi determinato dall’inflazione degli anni settanta che a parità di salari aveva fatto sì che il costo dei libri aumentasse e i lettori diminuissero. Da lì in avanti alla direzione delle case editrici più grandi furono messi uomini che non venivano dalla “letteratura” (come agenti o editori), ma dal marketing,
Nel frattempo McCarthy aveva scritto a Lynn Nesbit (che rappresentava, tra i tanti altri, autori come Joan Didion, Toni Morrison e Tom Wolfe) in cerca di un agente. Per farlo, le aveva scritto le seguenti parole: «Non ho mai avuto un agente prima d’ora, ma penso che sia giunto il momento di averlo e così, se è interessata a parlarmi, può chiamarmi prima di mezzogiorno, ora delle Montagne Rocciose (Rocky Mountain time).»
La Nesbit passò la lettera ad una sua protetta, Amanda “Binky” Urban, che aveva letto Suttree e lo aveva trovato stupefacente. Così Amanda Urban prese in carico lo scrittore e progettò il suo passaggio dalla Random House alla Knopf, dove un nuovo direttore editoriale, Sonny Metha, aveva bisogno di un buon colpo iniziale. Quando la Urban gli propose McCarthy, stimato borsista della MacArthur che però non aveva ancora venduto, con un francesismo, un cazzo, Metha rispose: «Già lo amo».
La stessa Urban, in seguito, avrebbe affermato: «Non potevo credere di stare per prendere in mano il telefono e chiamare un autore che fino ad allora aveva venduto al massimo 2500 copie». Ma in quel frangente si aprirono le porte del successo per Mc Carthy, con il romanzo Cavalli selvaggi, che non è certo tra i suoi migliori, ma da cui fu tratta una versione cinematografica, anch’essa risibile rispetto a quelle tratte da La strada e Non è un paese per vecchi, interpretata da un giovane Matt Damon.
 Romanzo che apriva però quella trilogia della frontiera cui si è già accennato e di cui il secondo, The crossing (1994 – Oltre il confine, Einaudi 1995), costituisce forse la summa della visione tragica e nichilista della vita contenuta in tutta la sua opera. Ancora una volta la storia di un giovane, Billy Parham, che lascia la casa di famiglia per addentrarsi, alle soglie del secondo conflitto mondiale, “oltre il confine” nel Messico. Tra deserti, montagne, cavalli, fantasmi di uomini e rivoluzioni, fotografie sbiadite e zingari alla ricerca dei proprietari delle stesse perché si riconoscano prima di svanire anche loro nel tempo o più semplicemente nel nulla.
Romanzo che apriva però quella trilogia della frontiera cui si è già accennato e di cui il secondo, The crossing (1994 – Oltre il confine, Einaudi 1995), costituisce forse la summa della visione tragica e nichilista della vita contenuta in tutta la sua opera. Ancora una volta la storia di un giovane, Billy Parham, che lascia la casa di famiglia per addentrarsi, alle soglie del secondo conflitto mondiale, “oltre il confine” nel Messico. Tra deserti, montagne, cavalli, fantasmi di uomini e rivoluzioni, fotografie sbiadite e zingari alla ricerca dei proprietari delle stesse perché si riconoscano prima di svanire anche loro nel tempo o più semplicemente nel nulla.
A farla da padrone è ancora una volta il paesaggio metafisico, ma concretissimo, che assume il ruolo di testimone muto e spietato che vedrà due fratelli cercarsi, perdersi, trovarsi e perdersi ancora su un confine, quello del Sud-ovest, che più che una linea divisoria tra gli stati sembra tracciare quella tra tra il mondo reale e quello narrato, tra la Vita e la Morte, l’Essere e il Nulla.
Dovevano ancora venire altri romanzi, tutti di successo soprattutto negli Stati Uniti, ma già in un’intervista dl 1992, rilasciata al settimanale tedesco «Der Spiegel», McCarthy avrebbe dichiarato: «Le classifiche dei bestseller non hanno nulla a che fare con la letteratura. Ha mai guardato i titoli che sono in classifica? Pensa che sia lusinghiero essere in quella compagnia?». E poi, a proposito dell’America: «Più di ogni altro paese sulla terra, l’America è una provvisorietà. Un’invenzione senza storia». In quell’occasione l’intervistatore ebbe modo di osservare come l’autore, che abitava ancora a El Paso «dove la città dei morti sembra provvisoria come la città dei vivi:
E’ affascinato dalla prospettiva in cui l’astrofisica colloca la storia umana, l’insensato arrancare dell’umanità e la sua sofferenza. Ci sono molti elementi che suggeriscono, dice, che l’esperimento umano sarà presto finito. E stranamente, come i predicatori dei suoi romanzi, Cormac McCarthy è un moralista. Meno fanatico, più rassegnato. Quando parla di sventura, non parla di catastrofi ecologiche o economiche, ma della morte interiore dell’uomo, della morte del significato. «Come si può vivere senza morale?», dice ad un certo punto.[…] Ha sottotitolato il suo romanzo Meridiano di sangue il “rosso della sera dell’Occidente”, un libro che, come i dipinti di Hieronymus Bosch, fornisce metafore per la caduta dell’umanità8.
 Certo un moralista, come lo sono stati Leopardi o Céline, eccessivi perché perfettamente consci della condizione umana e delle menzogne di un secol superbo e sciocco. Consci che l’ingiustizia, la violenza, il dolore fanno parte di tale condizione e che non saranno le fregnacce liberali, new age, politically correct e della cancel culture (tutte varianti di un unico perbenismo già morto e sepolto) a modificarla. Anzi tali fregnacce son proprio ciò che è necessario continuare a diffonder per nascondere la realtà. Non a caso uno (Céline) è stato demonizzato, l’altro (Leopardi) sminuito a pessimista gobbo e quasi cieco e Mc Carthy spesso inquadrato in un canone americano di difesa di valori che non ha mai sicuramente apprezzato.
Certo un moralista, come lo sono stati Leopardi o Céline, eccessivi perché perfettamente consci della condizione umana e delle menzogne di un secol superbo e sciocco. Consci che l’ingiustizia, la violenza, il dolore fanno parte di tale condizione e che non saranno le fregnacce liberali, new age, politically correct e della cancel culture (tutte varianti di un unico perbenismo già morto e sepolto) a modificarla. Anzi tali fregnacce son proprio ciò che è necessario continuare a diffonder per nascondere la realtà. Non a caso uno (Céline) è stato demonizzato, l’altro (Leopardi) sminuito a pessimista gobbo e quasi cieco e Mc Carthy spesso inquadrato in un canone americano di difesa di valori che non ha mai sicuramente apprezzato.
Proprio per questi motivi, in tempi di guerra e di crisi autentica dell’Occidente e dei suoi “valori fondativi”, è consigliabile che il lettore non si adagi sulle false sicurezze e le false speranze, distribuite a piene mani sia da destra che da sinistra, e faccia piuttosto un salto di paradigma iniziando subito a sprofondarsi nella lettura dell’opera di McCarthy. Possibilmente integrale.
C. McCarthy, The counselor– Il Procuratore, Einaudi 2013, pp. 114 – 115 ↩
op. cit., pag. 51 ↩
C. McCarthy, Il guardiano del frutteto, Einaudi 2002 ↩
Fonte: Dan Sinykin, A career that couldn’t happen now, The New York Times International Edition, 21 giugno 2023 ↩
Soldier Blue è un film statunitense del 1970, diretto da Ralph Nelson e liberamente ispirato al romanzo storico di Theodore V. Olsen, Arrow in the Sun, anch’esso liberamente ispirato ai reali eventi del massacro di Sand Creek del 1864. ↩
C. McCarthy, Meridiano di sangue, Einaudi 1996, pp. 56-57 ↩
«Der Spiegel», 30 agosto 1992 ↩