di Gioacchino Toni
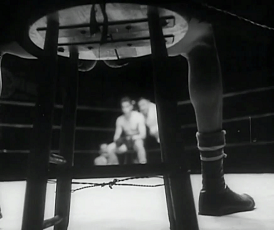 Facendo il punto sugli studi su più recenti a proposito dell’opera di Stanley Kubrick, Ruggero Eugeni, nell’introduzione al libro di Saverio Zumbo, La trappola del testo. Sul primo Kubrick (Mimesis, 2018), individua la presenza di due filoni principali: il primo indirizzato verso studi empirici basati sui materiali preparatori ai film del regista e il secondo tendete a leggere il cineasta come parte integrante della cultura novecentesca. Se la prima tendenza, sostiene Eugeni, ha il merito di mettere in luce la complessità e la variabilità stilistica e tematica dell’autore, la seconda tende a sostituire l’idea che lo voleva un «regista splendidamente e gelidamente isolato» con «il profilo di un artista in grado di giungere a sintesi estremamente dense tanto della modernità (e talvolta della postmodernità) culturale quanto del modernismo estetico novecenteschi» (p. 7).
Facendo il punto sugli studi su più recenti a proposito dell’opera di Stanley Kubrick, Ruggero Eugeni, nell’introduzione al libro di Saverio Zumbo, La trappola del testo. Sul primo Kubrick (Mimesis, 2018), individua la presenza di due filoni principali: il primo indirizzato verso studi empirici basati sui materiali preparatori ai film del regista e il secondo tendete a leggere il cineasta come parte integrante della cultura novecentesca. Se la prima tendenza, sostiene Eugeni, ha il merito di mettere in luce la complessità e la variabilità stilistica e tematica dell’autore, la seconda tende a sostituire l’idea che lo voleva un «regista splendidamente e gelidamente isolato» con «il profilo di un artista in grado di giungere a sintesi estremamente dense tanto della modernità (e talvolta della postmodernità) culturale quanto del modernismo estetico novecenteschi» (p. 7).
È proprio a questo ultimo filone che deve essere ricondotto il contributo di Saverio Zumbo che nel suo recente libro riprende il suo lavoro precedente: R. Lasagna, S. Zumbo, I film di Stanley Kubrick (Falsopiano, 1997).
Zumbo ritiene che se le primissime opere del regista risultano contraddistinte sia da uno sperimentalismo in linea con la lezione modernista votata all’autoriflessività, che da un costante riferimento alla psicanalisi junghiana, successivamente le cose cambiano e il connubio tra sperimentalismo linguistico e i modelli interpretativi proposti da Jung si allenta: così come l’inclinazione autoriflessiva della prima produzione, pur non venendo mai meno nelle opere successive, sembra via via diradarsi e perdere in incisività, anche il riferimento profondo alla psicanalisi junghiana sembra attenuarsi lasciando il posto a rimandi freudiani.
Scrive Zumbo che Il modernismo di Kubrick deriva tanto dalla sua partecipazione alle spinte neoavanguardiste dell’epoca in cui lavora che dalla sua conoscenza delle avanguardie storiche.
 «Modernismo, dunque, anche nel senso, se così si può dire, più “classico” del termine. In riferimento al fenomeno che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ha attraversato le arti avendo come trait-d’union la riflessività. In letteratura, con T. S. Eliot e James Joyce come massimi teorici, oltre che esponenti di spicco, col funzionalismo in architettura, con lo “straniamento” del teatro epico brechtiano, con le sperimentazioni della musica contemporanea, con l’astrattismo nelle arti figurative. Sintomatica, nell’ambito di queste ultime (ma nel quadro di una ricognizione estetica più generale che trascende le stesse), l’elaborazione teorica di Clement Greenberg, che afferma la necessità di una riflessione, da parte di ciascuna arte, sul medium che le è proprio, sulla sua “opacità”» (p. 15).
«Modernismo, dunque, anche nel senso, se così si può dire, più “classico” del termine. In riferimento al fenomeno che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ha attraversato le arti avendo come trait-d’union la riflessività. In letteratura, con T. S. Eliot e James Joyce come massimi teorici, oltre che esponenti di spicco, col funzionalismo in architettura, con lo “straniamento” del teatro epico brechtiano, con le sperimentazioni della musica contemporanea, con l’astrattismo nelle arti figurative. Sintomatica, nell’ambito di queste ultime (ma nel quadro di una ricognizione estetica più generale che trascende le stesse), l’elaborazione teorica di Clement Greenberg, che afferma la necessità di una riflessione, da parte di ciascuna arte, sul medium che le è proprio, sulla sua “opacità”» (p. 15).
Pertanto, il primo Kubrick andrebbe a collocarsi «tra l’onda lunga delle avanguardie storiche e la riscoperta neoavanguardistica delle stesse da parte della modernità cinematografica. Non stupisce quindi che il belga Raymond Haine […] rilevi, nell’intervistare il regista per i “Cahiers”, uno “stile d’avanguardia estremamente datato” nel Bacio dell’assassino. Il tutto da inquadrarsi, ironia della sorte, in prossimità del terremoto che il neo-brechtismo godardiano innescherà di lì a poco. È questo Kubrick che, a differenza di altri analisti, ritengo incarni lo spirito più genuino del modernismo, ovvero la sua caratteristica tendenza a demistificare e problematizzare la rappresentazione. Là dove il Kubrick “consacrato” apparirà maggiormente preoccupato della solidità del mondo diegetico. Sempre più concepito come storia, come realtà di cui penetrare il senso profondo. Sempre meno come discorso. Dal mondo del testo, se vogliamo, al testo del mondo» (pp. 15-16).
Circa l’approccio psicanalitico, sostiene Zumbo che questo «vada modulato, a secondo dei casi, in riferimento a matrici e correnti diverse, dalla psicoanalisi in senso stretto alla psicologia “del profondo” o analitica. Fear and Desire, ancora, presentando forme e tematiche che sono, a mio avviso, di indubbia derivazione junghiana, ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare l’evoluzione del mio sguardo su Kubrick. All’analisi enunciativa, che rimane tutt’oggi la più adatta allo studio delle emergenze metadiscorsive, si unirà perciò, in senso lato, la psico-analisi dei testi filmici. Non tanto perché alla prima si affianchi la seconda, ma soprattutto perché, nelle configurazioni più stimolanti, autoriflessione e “psichicità”, come mi sforzerò di mostrare, saranno “facce della stessa medaglia”, andranno di pari passo. Stando allo sguardo analitico scorgere l’una o l’altra. O preferibilmente, ritengo, entrambe ad un tempo » (pp. 13-14)
Secondo Eugeni il libro di Zumbo ha il merito di rilanciare gli studi sull’opera di Kubrick su un duplice versante: favorire un’analisi junghiana della sua opera e proporre una discussione a proposito delll’appartenenza moderna e/o modernista del cineasta. Anche se le opere posteriori a Lolita (1962) risentono maggiormente del paradigma freudiano e i riferimenti junghiani risultano scissi dalle scelte linguistiche adottate dal regista, lo studioso ritiene che il lavoro di Zumbo possa comunque favorire una rilettura dell’opera di Kubrick in chiave junghiana e ciò risulterebbe importante visto che, nonostante tutto, ritiene Eugeni, anche nel suo cinema maturo persistono elementi junghiani.
 «Anzitutto è profondamente junghiano il tema della difficoltà (e spesso l’impossibilità) per l’individuo di condurre un cammino verso il sé che gli permetta di superare il riassorbimento in un inconscio e/o in una coscienza collettivi e impersonali: la collettività, in Jung come in Kubrick, incombe sul soggetto e rende precari, scivolosi, perfino profondamente dolorosi i percorsi di individuazione del sé. Parimenti junghiana è l’idea ben presente in Kubrick di una Storia pensata come patrimonio di immagini dalla esistenza sincronica e trans-temporale: immagini che possono invadere il soggetto e all’interno delle quali questi deve imparare a vivere e a orientarsi – un tema che aprirebbe peraltro una riflessione sui rapporti tra Kubrick, Jung e Aby Warburg. Proprio la figura ricorrente dell’invasione improvvisa e devastante dell’immaginario nel simbolico (per usare una terminologia lacaniana ricorrente negli studi kubrickiani) è un ulteriore elemento che lega a mio avviso Jung a Kubrick: come non pensare a Shining leggendo l’allucinazione del giovane Jung che “prevede” lo scoppio della prima guerra mondiale nell’inverno del 1913 vedendo l’Europa invasa da “sangue, sangue a fiumi”» (pp. 9-10).
«Anzitutto è profondamente junghiano il tema della difficoltà (e spesso l’impossibilità) per l’individuo di condurre un cammino verso il sé che gli permetta di superare il riassorbimento in un inconscio e/o in una coscienza collettivi e impersonali: la collettività, in Jung come in Kubrick, incombe sul soggetto e rende precari, scivolosi, perfino profondamente dolorosi i percorsi di individuazione del sé. Parimenti junghiana è l’idea ben presente in Kubrick di una Storia pensata come patrimonio di immagini dalla esistenza sincronica e trans-temporale: immagini che possono invadere il soggetto e all’interno delle quali questi deve imparare a vivere e a orientarsi – un tema che aprirebbe peraltro una riflessione sui rapporti tra Kubrick, Jung e Aby Warburg. Proprio la figura ricorrente dell’invasione improvvisa e devastante dell’immaginario nel simbolico (per usare una terminologia lacaniana ricorrente negli studi kubrickiani) è un ulteriore elemento che lega a mio avviso Jung a Kubrick: come non pensare a Shining leggendo l’allucinazione del giovane Jung che “prevede” lo scoppio della prima guerra mondiale nell’inverno del 1913 vedendo l’Europa invasa da “sangue, sangue a fiumi”» (pp. 9-10).
Per quanto riguarda l’appartenenza moderna e/o modernista del regista, continua Eugeni, anche se «l’interesse di Kubrick si sposta dalle strutture del linguaggio cinematografico e da quelle del testo filmico alle strutture del mondo e dei soggetti che lo abitano» (p. 10) sembra possibile individuare una qualche forma di continuità nella differenza.
Riprendendo l’opinione di Philippe Fraisse, espressa in Le cinéma au bord du monde. Une approche de Stanley Kubrick (Gallimard, 2010), che individua «un Kubrick in qualche modo surrealista e bretoniano», scrive Eugeni, «giungiamo a un’ipotesi ulteriore: lo spostamento di cui ci parla Zumbo dal testo al mondo è conseguente alla intuizione profonda che il mondo funziona esattamente come il testo: con i suoi rapporti liberi di forme e di forze; con i suoi giochi di rime, simmetrie, casualità, doppi e ombre; con le sue catastrofi, le sue derive e soprattutto il suo scorrere implacabile delle immagini nel tempo» (pp. 10-11).



