di Gioacchino Toni
 Paolo S.H. Favero, Dentro e oltre l’immagine. Saggi sulla cultura visiva e politica nell’Italia contemporanea, Meltemi, Milano 2017, pp. 150, € 15,00
Paolo S.H. Favero, Dentro e oltre l’immagine. Saggi sulla cultura visiva e politica nell’Italia contemporanea, Meltemi, Milano 2017, pp. 150, € 15,00
«Le immagini e il campo del visivo in generale sono da sempre arene profondamente politiche, spazi in cui si riversano questioni legate alla gestione del potere e alla divisione delle risorse» (Paolo S.H. Favero, p. 12)
Secondo Michel Foucault (Sorvegliare e punire, 1975) se in epoca pre-moderna l’essere guardati e descritti è un privilegio del potere, in particolare del re che si concede, di tanto in tanto, agli occhi del popolo, nella modernità le cose sembrano invertirsi e l’atto del guardare diviene sinonimo di controllo e disciplinamento operato dal potere nei confronti degli individui. Oggi, sostiene l’antropologo Paolo S.H. Favero, riprendendo il concetto di “ipertrofia visiva” così come è espresso da Lucien Taylor (Visualizing Theory, 1994), le immagini hanno un ruolo centrale nel modo di vivere dell’essere umano che ne è sia consumatore che oggetto di monitoraggio visivo. Secondo lo studioso la commistione tra visivo e digitale non ha però condotto alla dissoluzione della realtà materiale ma a rendere le immagini parte della concretezza della materialità quotidiana collegando la vita online con quella offline. In sostanza le immagini non avrebbero allontano l’individuo dal reale ma si sarebbero fuse con il quotidiano.
Se Marshall MacLuhan (Gli strumenti del comunicare, 1967 – orig. 1964) sosteneva che i mezzi elettronici erano diventati protesi del nostro corpo, oggi occorrere «chiedersi se i nostri corpi non stiano diventando protesi dei mezzi di rappresentazione visiva. La progressiva fusione tra tecnologia e corpo e l’immersività che caratterizza il mondo della produzione d’immagini porta a chiederci se forse non siamo entrati nell’era del Plenopticon (una sorta di post Panopticon), un’era nella quale non abbiamo più bisogno di un re che ci osservi, ma in cui siamo noi stessi a osservarci reciprocamente nella nostra orgiastica produzione di co-presenza visiva» (p. 16).
Nel corso del tempo la fotografia sembra aver via via preso il posto della parola come portatrice di testimonianze grazie probabilmente a quel «potere affettivo delle immagini [capace di] generare quel surplus che in qualche modo ci riesce a commuovere, a collocare la nostra sensibilità all’interno di un evento avvenuto in tempi e luoghi lontani da noi» (p. 18). Sull’onda delle riflessioni di Roland Barthes (La camera chiara, 2003 – orig. 1980) che vogliono le immagini fotografiche capaci di evocazione, oltre che di descrizione, nel loro contenere qualcosa (punctum) capace di colpire l’osservatore tirandolo dentro l’immagine, si può allora, secondo Favero, individuare nel visivo una chiave utile a comprendere il contesto politico in cui si vive e il volume Dentro e oltre l’immagine si propone proprio di riflettere su tale questione applicata al contesto dell’Italia contemporanea.
Nel contesto italiano le immagini «sono intrinsecamente politiche e ci offrono soprattutto una possibilità di attuare una decostruzione di rappresentazioni comuni sulle quali si fonda la vita pubblica» (p. 19). Una parte importante dell’analisi dello studioso deriva da una ricerca sul campo attuata a Roma nel quartiere Esquilino tra il 2005 ed il 2007, coincidente con un momento in cui le storie del luogo vanno a collocarsi in un contesto nazionale in cui i media, sotto le vesti dell’intrattenimento celavano messaggi “ri-producenti” «una distanza (a volte proprio ontologizzata) fra “italiani” e “immigrati”, tra “uomini” e “donne”, tra “eterosessuali” e “non-eterosessuali”. Spesso si coglievano anche messaggi apertamente razzisti, omofobici e sessisti» (p. 19). Le strade dell’Esquilino all’epoca abbondavano di scritte contro rom, immigrati, omosessuali e slogan fascisti in diversi casi in onore del boia nazista Priebke mentre i media nazionali sostenevano le politiche ostili ai migranti presentandoli attraverso immagini di orde anonime di invasori e la televisione, a reti unificate, inondava i programmi «di ricchi décolleté e “lati B” di ignote soubrette (la solita riduzione della donna a collezione di dettagli anatomici). Questa era anche l’era in cui la visibilità si affermava come un fine a se stante. Momento nel quale personaggi del Grande Fratello diventavano opinion makers e nel quale una soubrette televisiva (ex partecipante a Miss Italia e protagonista di copertine di riviste per uomini) riusciva a realizzare una vertiginosa carriera “politica” e a diventare Ministro per le pari opportunità. Questi erano anche gli anni dell’ambiguo “sdoganamento” della politica e nei quali ministri e uomini d’affari si inserivano nelle case dei cittadini tramite i programmi di cucina e di calcio» (p. 20).
Presto sarebbero arrivati gli anni in cui Berlusconi avrebbe sentenziato che “in Italia non ci sono mai stati campi di concentramento, ma solo campi di villeggiatura”, in cui le battute sui Kapó si sarebbero inserite in un contesto ove termini come “frocio”, “negro”, “terrone” e “zoccola” venivano ormai tranquillamente utilizzati anche dai media come semplici e innocenti “modi di dire”, dove i cori razzisti negli stadi sarebbero stati indicati come “cori a sfondo territoriale” e dove la Federazione di calcio avrebbe eletto un presidente capace di sostenere, tra le altre cose, che i calciatori di colore prima di far parte delle squadre italiane erano semplici mangiatori di banane.
«Dentro e oltre l’immagine entra in questa particolare epoca della storia e vuole offrire una serie di riflessioni sul significato nonché sul ruolo politico e sociale della cultura popolare visiva nell’Italia contemporanea. Basato su ricerche etnografiche in campi quali il cinema, la televisione, il documentario, la fotografia e la cultura (materiale e visiva) di strada, il libro affronta l’arena della visualità come un campo nel quale si possono decodificare continuità e rotture politiche ed ideologiche» (p. 21). Tutto ciò viene indagato dall’autore nella sua posizione di insider/outsider, di colui che conosce bene la cultura e la società italiane essendo di famiglia italo-svedese, ma che vive e lavora all’estero, capace dunque di avere un’osservazione sufficientemente esterna per restare colpito da ciò in cui si imbatte ma anche di trovarsi in una posizione abbastanza interna al mondo indagato per indignarsi e voler cambiare le cose.
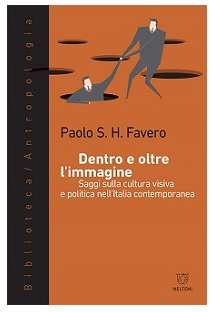 Il volume raccoglie sei diversi saggi scritti in momenti diversi, in alcuni casi pubblicati originariamente su riviste internazionali. Gli scritti possono essere divisi in due grandi blocchi con i primi tre che affrontano criticamente quella che viene indicata dall’autore come una delle rappresentazioni fondanti della cultura italiana, ossia la nozione di “italiano buono”. In questi primi tre interventi viene mostrato come tale rappresentazione, oltre ad essere parte della storia della cultura popolare italiana, sia uno strumento fondamentale per la costruzione dell’identità nazionale dell’Italia contemporanea. Nei successivi tre saggi viene invece indagata la cultura popolare visiva italiana focalizzando l’analisi sui rapporti tra società italiana e culture altre con cui questa viene a contatto.
Il volume raccoglie sei diversi saggi scritti in momenti diversi, in alcuni casi pubblicati originariamente su riviste internazionali. Gli scritti possono essere divisi in due grandi blocchi con i primi tre che affrontano criticamente quella che viene indicata dall’autore come una delle rappresentazioni fondanti della cultura italiana, ossia la nozione di “italiano buono”. In questi primi tre interventi viene mostrato come tale rappresentazione, oltre ad essere parte della storia della cultura popolare italiana, sia uno strumento fondamentale per la costruzione dell’identità nazionale dell’Italia contemporanea. Nei successivi tre saggi viene invece indagata la cultura popolare visiva italiana focalizzando l’analisi sui rapporti tra società italiana e culture altre con cui questa viene a contatto.
Nel primo saggio Italiani, “brava gente”? l’autore mostra come tale rappresentazione venga oggi evocata per affrontare questioni inerenti i crimini a sfondo xenofobo e la partecipazione militare italiana ai conflitti internazionali. «L’espressione “italiani brava gente”, usata anche in situazioni colloquiali, implica, schiettamente parlando, che a differenza di altri, gli italiani siano per natura brava gente. Non nuocciono mai a nessuno e la loro storia (almeno per come loro stessi la conoscono) ne è apparentemente la prova. “Brutti eventi” sono ovviamente capitati (e capitano) anche qui, ma si tratta solo d’incidenti; altri popoli e nazioni hanno compiuto atti peggiori dei nostri. Ma gli italiani, non hanno mai realmente voluto nuocere. Nemmeno in epoca fascista» (p. 30).
Fino a qualche decennio fa gli stessi libri di testo nelle scuole non mancavano di rappresentare gli italiani come un popolo sostanzialmente di brava gente finito in balia delle follie mussoliniane e soprattutto straniere, quasi inconsapevolmente e involontariamente. L’onda lunga di tale lettura delle cose, sostiene lo studioso, la si rintraccia nelle maldestre affermazioni di qualche anno fa dell’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi quando ha sostenuto pubblicamente che, in realtà, in Italia non ci sono mai stati campi di concentramento, ma solo “campi di villeggiatura”. «E, in ossequio alla medesima logica, viene oggi detto agli italiani che le “guerre al terrore” alle quali partecipano, sono in realtà “missioni di pace” e che i loro soldati, riconosciuti ovunque come “brave persone”, non sono mai realmente esposti a minacce […]. Nello stesso modo, viene anche fatto credere che xenofobia e omofobia certamente risiedono altrove ma non nel “nostro” paese» (p. 31).
Insomma, il mito dell’italiano buono si rivela, dal punto di vista storico, uno strumento utile a celare eventi drammatici. A tale mito ricorrono spesso sia quei ragionamenti intenzionati a difendere le idee xenofobe e omofobe che quelli volti a giustificare la partecipazione militare italiana alla cosiddetta “guerra al terrore”. Viene dunque mostrato lo stretto legame esistente tra memoria, politica e identità evidenziando come «il concetto di “italiani brava gente” [sia] alla base della costituzione di un’identità nazionale moderna» (p. 50). Sull’argomento risultano frequenti i riferimenti di Favero agli studi di Angelo del Boca, questi ultimi ripresi più volte su Carmilla [1] [2] [3] da Armando Lancellotti.
Nel saggio Il “soldato buono” viene indagata criticamente la rappresentazione del soldato italiano nel cinema nazionale delle ultime quattro decadi mostrando come sia facilmente individuabile una continuità storica di tale rappresentazione. Lo studioso parte dalla presa d’atto che negli ultimi decenni in Italia si è diffuso, grazie ad un lento ma costante lavoro di costruzione, un orgoglio nazionale prima sconosciuto. «Tale processo vedeva coinvolti molti attori (dai media al sistema scolastico, ecc.) ed era fondato sull’inserimento nella cultura popolare di una serie di figure portanti, capaci di infondere fede e rispetto nella nazione, nello Stato e in coloro che lo rappresentavano. In un’epoca caratterizzata dalla partecipazione dell’Italia alla “coalizione dei volenterosi” e dal suo conseguente coinvolgimento nelle missioni di guerra in Iraq e Afghanistan, la figura del soldato, in una sorta di ricorso storico, sarebbero stata rivalutata. È diventata un pilastro portante nella creazione di un orgoglio nazionale» (pp. 54-55). A partire dalla convinzione che la figura del soldato sia davvero uno dei punti focali della costruzione dell’identità nazionale, Favero passa in rassegna la produzione cinematografica italiana del dopoguerra e i più recenti reportage dedicati al coinvolgimento italiano alle cosiddette “missioni di pace”.
Nelle modalità con cui la cultura popolare italiana ha mantenuto viva l’immagine del “soldato italiano buono” vi sono certamente alcune costanti. «Guidato da amore e altruismo, il “soldato buono”, a volte appare un briciolo egoista, codardo, opportunista e forse un po’ pigro. Ma risulta, comunque, assolutamente incapace di far del male e viene pertanto sempre sollevato da qualsiasi responsabilità storica. Questa rappresentazione, trova ampio riscontro nell’immagine dell’“italiano buono” nata per giustificare la prima (fallimentare) impresa coloniale» (p. 55). Dunque, tale autorappresentazione, che ha svolto storicamente, e continua a farlo, un ruolo di “lavanderia” delle vergogne nazionali, è indicata dall’autore come centrale nella creazione della moderna identità nazionale.
È il cinema italiano del dopoguerra ad essersi fatto carico della divulgazione di una rappresentazione del soldato edulcorata e familiarizzata: «Spostato dal contesto del belligerante patriottismo fascista, egli venne introdotto, a volte in modo ironico, nello spazio quotidiano della vita di famiglia» (p. 62). L’analisi di Favero si sofferma su tre film che hanno promosso un’immagine iconica del soldato capace, visto anche il successo di pubblico, di lasciare tracce importanti nella cultura popolare nazionale: Tutti a casa (1960) di Luigi Comencini, La Grande Guerra (1959) di Mario Monicelli e Mediterraneo (1991) di Gabriele Salvatores. «Nei tre film, il soldato è sempre un uomo semplice e un po’ ingenuo, nonché un amante del divertimento. I soldati protagonisti di questi tre film sembrano tutti piuttosto inconsapevoli di quel che succede intorno a loro e di conseguenza, sono staccati e deresponsabilizzati dalla storia. Hanno in comune la vicinanza e l’affetto delle popolazioni locali che incontrano durante le loro missioni e dimostrano anche una particolare devozione nei confronti delle donne e delle madri. Anche se in alcune occasioni vengono presentati come ipocriti, opportunisti ed egoisti, in realtà sono “brave persone” il cui unico desiderio è quello di tornare a casa e vivere serenamente insieme ai loro cari. Incapaci di agire, questi soldati sono pertanto indubbiamente anche incapaci di fare del male» (p. 64).
Venendo ai recenti reportage relativi a quelli che vengono descritti come “buoni soldati italiani”, martiri contemporanei, lo studioso individua in tali rappresentazioni l’intero armamentario retorico volto a presentarli non tanto come soldati impegnati in azioni di guerra, ma come brave persone andate a portare aiuto, amate da donne bambini locali, in trepidante attesa di tornare a casa dalla propria famiglia, martiri vittime di atrocità sempre e solo straniere. Insomma il soldato italiano è un soldato diverso dagli altri, per certi versi non sembra nemmeno un soldato.
La seconda parte di Dentro e oltre l’immagine è dedicata, come detto, all’analisi della cultura popolare visiva nazionale a proposito dei rapporti tra la società italiana e le culture altre. Nel primo saggio di tale sezione, Perché Sanremo è Sanremo, lo studioso si occupa della questione di genere soffermandosi sulla rappresentazione dell’omosessualità nel contesto del Festival sanremese del 2012. L’edizione indagata era stata preceduta da alcuni interventi pubblici di Adriano Celentano volti a criticare duramente la stampa cattolica nazionale, in particolare «Avvenire» e «Famiglia Cristiana», accusata dal cantante di subordinare le tematiche religiose a quelle politiche. Con tali premesse prendeva il via un’edizione della manifestazione canora fortemente segnata dalla presenza di riferimenti a Dio e alla Fede. «È nel testo della canzone vincitrice del festival, cantata da Emma, che la “fede” si mette esplicitamente in dialogo con la “patria” proponendo una sorta di consolidamento “pop” del concordato tra Stato e Chiesa. Per raccontarci una storia di disoccupazione e precarietà, la cantante pugliese sceglie la figura di un soldato e un testo (peraltro criptico, scritto da Kekko dei Modà) che recita: “Ho dato la vita e il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese, in mano a Dio le sue preghiere” e poi “ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzia di ritornare, solo medaglie per l’onore”. Questa commistura di fede, patria e guerra ri-propone, oltre un possibile tentativo di provocazione dell’autore, la figura del “soldato buono” una delle rappresentazioni più forti e longeve (nonché politicamente ed eticamente dubbie) della cultura popolare italiana» (p. 81).
Se poi al testo della canzone si aggiungono le dichiarazioni della cantante alla stampa che parlano della sua volontà di diventare madre come di una “missione” a cui tutte le donne sono chiamate, allora il patriottismo dispensato dalla canzone può essere interpretato come il «segnale di un nuovo conservatorismo giovanile all’interno di un paese ormai culturalmente invecchiato in modo irreparabile» (pp. 81-82). Di certo, sostiene lo studioso, l’immagine «della donna procreatrice, cui fa riferimento Emma, funziona paradossalmente bene in un contesto quale quello del festival, in cui le donne (con piccole dovute eccezioni) appaiono come la somma di parti anatomiche messe a servizio degli uomini, di cui fungono da spalla silente» (p. 82).
L’arretratezza italiana nell’affrontare la diversità di genere (o d’identità sessuale) emerge in maniera eclatante quando viene affrontato il tema dell’omosessualità. In questo caso la kermesse sanremese non manca di mettere in scena tutti gli stereotipi più scontati. L’immagine dell’Italia offerta dal festival è quella di un paese «dominato da uomini (maschi) eterosessuali e vecchi, chiuso su se stesso e con poca voglia di cambiare. Questo è un paese autoreferenziale, trincerato dietro una fede cattolica, che appare sempre più oggetto di opportunismo e molto raffinato nella sua capacità di mettere all’angolo (tramite, paradossalmente, la sua spettacolarizzazione) ogni forma di diversità culturale» (p. 84).
Nel saggio Lo spettacolo del multiculturalismo viene offerta una lettura critica del documentario L’Orchestra di Piazza Vittorio (2006) di Agostino Ferrante mettendo in rapporto l’idea di multiculturalismo suggerita dall’opera con il dibattito politico che ha caratterizzato le lezioni comunali romane del 2008. Alla realizzazione di Ferrante dedicata all’orchestra multiculturale dell’Esquilino, viene rimproverato di non approfondire i temi lanciati dalle sue immagini e di non giungere mai a un confronto paritario con l’Altro” dandogli realmente voce. «Il film sembra risentire della mancanza di un dialogo critico con lo stesso “Altro” che intende rappresentare e viene penalizzato dalla scelta di evitare di approfondire il contesto che ha reso possibile la realizzazione dell’Orchestra. Il fatto, per esempio, che la band abbia, nel corso degli anni, rinunciato a fare dichiarazioni apertamente politiche, temendo comprensibilmente di non essere poi in grado di creare una struttura solida che potesse pagare regolari stipendi ai musicisti (come spiegatomi da Mario Tronco durante un’intervista), delinea una situazione di fondo piuttosto critica che testimonia anche i paradossi che segnano le ideologie multiculturali contemporanee. Il film avrebbe potuto trarre dei benefici dall’approfondire queste tematiche, piuttosto che dal smorzarle in nome della rappresentazione dei “musicisti immigrati” come persone simpatiche» (p. 92).
Dalla visione dell’opera, sostiene ancora Favero, si individua come unico vero protagonista l’organizzatore italiano Mario Tronco mentre le vite dei musicisti sono soltanto sfiorate in superficie: «ci vengono presentati come personaggi abbastanza gioiosi, distaccati, bizzarri e divertenti, ognuno di essi rappresentante di quella “pittoresca” parte di mondo da cui proviene […] i musicisti ci vengono subito presentati (nel film e durante il concerto) in associazione alla loro nazionalità (mentre gli italiani alle loro città di provenienza). Ciò li rende principalmente “rappresentanti di un’etnicità” piuttosto che “musicisti professionisti”» (pp. 92-93). Insomma, secondo lo studioso il film «manca, da un punto di vista politico, di un riflessivo esporsi e dialogare con l’“Altro” che intende rappresentare. Questo forse riflette anche il destino dell’orchestra che, malgrado il suo intento originario, con gli anni si è trovata intrappolata a rappresentare la diversità e l’alterità, di fronte a un pubblico prevalentemente “bianco” e di classe media (partecipando ai loro concerti ho potuto notare la netta minoranza di stranieri presenti tra il pubblico) invece che a creare un ponte a cavallo di categorie razziali ed etniche […] Qui i migranti diventano oggetto dell’intrattenimento altrui invece che produttori di musica e di un film-denuncia a difesa dei loro diritti. La sensazione è che non sia stata sfruttata a dovere la splendida opportunità di mettere in discussione le categorie ferree che dividono gli “italiani” dagli “stranieri”» (pp. 93-94).
Gli ultimi due saggi sono dedicati rispettivamente all’immaginario italiano sull’India – Bello e distante. La politica dell’esotismo e la rappresentazione visiva dell’India nella cultura popolare italiana – e al mito del Nord nella cultura popolare italiana – ’O Sole mio: turisti charter italiani in visita al Sole di Mezzanotte di Capo Nord (Norvegia). Lo studioso indaga qui le esperienze turistiche di italiani a Capo Nord, la costruzione del Sole di Mezzanotte come oggetto mitico.
Dentro e oltre l’immagine decostruisce criticamente alcuni dei miti e delle rappresentazioni che hanno contribuito a costruire l’identità nazionale italiana e lo fa con gli occhi di un antropologo, Paolo S. H. Favero, che si trova nella particolare, e per certi versi privilegiata, posizione di insider/outsider.
Serie completa: Il reale delle/nelle immagini



