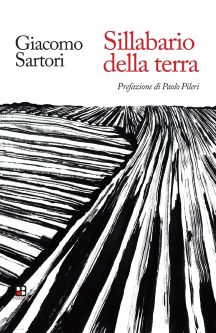 Piano B edizioni, Prato 2025 pagg 152 € 15,43
Piano B edizioni, Prato 2025 pagg 152 € 15,43
Dopo Coltivare la natura (Kellermann 2023) Giacomo Sartori, che scrive prevalentemente romanzi, porta avanti il suo percorso narrativo-scientifico sulla materia che conosce meglio: la terra, i suoli, quella sezione dell’ambiente che ci ospita e ci dà da vivere. E’ un agronomo e un geologo, studia i terreni, indaga sul loro uso e abuso – l’edilizia selvaggia, l’agricoltura intensiva – li ama, quasi in una simbiosi con gli odori, i colori, e ne denuncia il saccheggio e la violenza della società dei consumi. E’ un testo ibrido, in cui le osservazioni storico-scientifiche si uniscono in osmosi con le esperienze personali del narratore. Racconta il mondo sotterraneo affollatissimo di creature piccole o invisibili sempre in attività, i lombrichi, la infinità di batteri che la rendono un organismo vivente e addirittura senziente, come la Gaia di Asimov. Il testo è illustrato coi disegni a china di Elena Tognoli. Di seguito pubblichiamo la prefazione di Paolo Pileri, professore ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, e alcuni estratti del libro. (MB)
Dare voce alla terra
Innumerevoli volte ho scritto che una delle prime cose che possiamo fare tutti noi per tutelare il suolo è quella di parlarne, di raccontare cosa è il suolo, la sua bellezza, la sua potenza, le sue funzioni ma anche le sue fragilità. Insomma, noi tutti possiamo e dobbiamo, ognuno con le proprie forze e capacità, dare voce al suolo che voce non ha. Ogni speranza di cambiamento ha nell’uso libero della parola il suo primo atto rivoluzionario. Il sillabario di Giacomo Sartori è questo: una forma possibile, e creativa, per tenere viva quella possibilità di cambiamento aiutando il lettore ad acquisire e/o rafforzare le proprie conoscenze e consapevolezze sul suolo così da essere più efficace nel dare voce alla terra e nel far valere i diritti del suolo davanti a chi pretende di aggredirlo. Con un linguaggio accessibile e sempre chiaro, il sillabario riesce a raccontarci cosa è la terra, forse il più antico tra gli ecosistemi. Lo fa attraverso venti storie più un prologo e una conclusione.
Trovo efficace e pulita l’idea del sillabario perché è un modo sincero e originale di raccontare le cose come stanno e per tenerci svegli. Già perché il suolo può morire, come scrive nel prologo. Una tremenda verità contro la quale dobbiamo opporre tutte le nostre forze, inventandoci sempre nuove tattiche perché la terra non può, ma soprattutto non deve, morire. La sopravvivenza del suolo dipende da noi. O spariamo dal pianeta Terra o dovremo imparare a fare un passo indietro che possiamo fare con convinzione se ci sforziamo di conoscere la terra in quanto corpo ecologico allontanandoci dal pensiero unico che la vede solo come risorsa da sfruttare. Ecco allora dispiegarsi nelle pagine, con meritorio tono divulgativo, quelle argomentazioni scientifiche utili a spiegarci i segreti della terra, le sue proprietà, le sue capacità generative. Una spiegazione mai didascalica e neutra, sempre acutamente disincantata perché capace di guardare negli occhi noi uomini predoni e le nostre invenzioni tecnologiche fintamente conservative per il suolo, ma in verità sempre troppo obbedienti agli interessi di giganti globali ovvero quelle grandi multinazionali e imprese, da sempre posizionate laddove si formano e si prendono le decisioni in tema di politiche agricole e quindi di uso del suolo. Giganti globali che hanno spavaldamente dettato l’agenda colturale e culturale tutta la filiera agricola e agroalimentare incuranti del suolo e condizionando le nostre scelte alimentari. Ma il sillabario di Giacomo Sartori è un testo dalla parte del suolo e quindi il suo modo di porsi non poteva che essere di aiuto a vedere con chiarezza i ‘nonsense’ di alcune agricolture o di alcune produzioni alimentari; le esiguità degli studi scientifici sul suolo a causa della carenza di investimenti pubblici in ricerca indipendente; la inazione della politica che continua a non avere il suolo in cima alla propria agenda.
Nel sillabario impariamo che il suolo non si ammala da solo, non viene eroso dalla natura per un vezzo della natura stessa, non perde sostanza organica da solo, né decide di avvelenarsi in una sorta di spirale suicida. Quando qualcosa di ciò accade è perché in qualche punto del sistema siamo intervenuti noi umani rapinando terra, inquinandola, deportandola, sfruttandola e così via. E il sillabario lo racconta aiutandoci a prendere posizione in una società sempre più innaturale che decide con disarmante leggerezza di consegnare a una intelligenza artificiale le redini delle decisioni. Decisioni che così saranno sempre più povere di senso etico. Occorre allora cambiare, e in fretta. Ma per cambiare servono le persone che costruiscono le basi di ogni cambiamento e ci aiutano a vedere come scegliere di evitare lo sfruttamento del suolo nascosto in tante nostre scelte quotidiane che possiamo evitare o migliorare.
L’autore chiude il sillabario svelandoci la doppia sensazione che lo ha spinto a scriverlo. Da un lato il fatto che gli pareva che la terra avesse bisogno di aiuto e questo ci riporta al concetto iniziale di dare voce alla terra così da ingigantire le fila degli alfieri per la sua tutela. Dall’altro c’è il riconoscere che siamo noi ad aver bisogno dell’aiuto della terra. Siamo noi che dobbiamo imparare ad ascoltarla facendoci umili (parola che deriva da humus, peraltro) per poi, come dicevo, ripensare completamente i diversi modi con i quali interagiamo e impattiamo, ovvero abitiamo la terra e la Terra. Se al nostro pianeta i nostri antenati meno incoscienti di noi hanno dato il nome Terra è perché sapevano bene e meglio di noi quale fosse la parte più importante del globo su cui abitiamo e la prima di cui prenderci cura: la terra con la t minuscola. Eppure noi abbiamo scordato tutto ciò e ci muoviamo con spavalderia e la disgrazia di elefanti in una cristalleria.
Termino ricordando che, sebbene il libro guardi in prevalenza al suolo nel mondo agricolo – l’autore, lo ricordo di nuovo, è un agronomo –, i suoli sono fortemente minacciati dall’aggressione spietata operata dalle trasformazioni urbanistiche volute dall’uomo in nome di quel che lui chiama ‘sviluppo’, una parola che dobbiamo far uscire di scena.
Questo libro è quindi da consigliare a tutti perché tutti abbiamo bisogno di tenere gli occhi ben aperti e arricchire le nostre parole in difesa del suolo.
Estratti
Vocazione p. 10
Adesso però ero a mio agio, ero in sintonia con la terra. Ora la sentivo respirare, percepivo che stava solo attendendo, sotto la sua apparenza tramortita. Sapeva che alla lunga l’avrebbe vinta lei, la tracotanza degli uomini li avrebbe portati alla sconfitta. Non lo intuivo, ma ormai la terra mi aveva preso, non mi avrebbe più
lasciato.
Pedologi p. 28-29
Anch’io sono un pedologo, quando sono in una buca perdo la cognizione del tempo e di me stesso, e mi lascio cullare dagli odori di umido e di funghi. Mi sforzo di cogliere quanti più dettagli possibile della sezione terrosa che ho davanti, e questa tensione mi assorbe completamente. Forse proprio perché so bene che molti aspetti mi sfuggono, e che non posso capire tutto. Ma certo non si tratta di una pura concentrazione cerebrale con qualche spruzzatina filosofica, le sensazioni fisiche restano sempre presenti. Spesso chi mi sorprende così dedito mi domanda qual è il mio vero impiego, non possono pensare che quello sia un lavoro retribuito.
I colori della terra p.39
I colori della terra hanno pochi ingredienti, che sono facili da reperire. Il pigmento fondamentale è costituito dagli ossidi di ferro, i quali hanno un legame molto stretto con il clima. Nelle regioni calde o comunque con una stagione calda e secca, come quelle mediterranee, hanno gradazioni rossastre o decisamente rosse, e insomma rugginose. Sono le Terre rosse che tutti conosciamo. E anche quando il clima si avvicina a quello mediterraneo, senza esserlo davvero, come in molte zone del nord Italia, i toni tendono al rosellino o al bruno arrossato. Le varie sfumature terra di Siena, per intenderci.



