di Gioacchino Toni
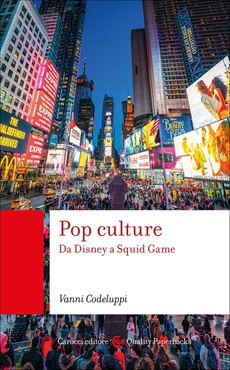 Vanni Codeluppi, Pop culture. Da Disney a Squid Game, Carocci, Roma 2025, pp. 100, € 13,00
Vanni Codeluppi, Pop culture. Da Disney a Squid Game, Carocci, Roma 2025, pp. 100, € 13,00
A conferma dell’importanza che è andata ad assumere la cultura di massa nella costruzione dell’immaginario contemporaneo, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, pur all’interno di una varietà di atteggiamenti che spaziano dall’allarmismo al compiacimento, passando dalla semplice presa d’atto, si è diffusa la convinzione che la realtà artificiale creata dalla cultura di massa attraverso i media si stia sempre più sostituendo alla realtà. In Pop culture il sociologo Vanni Codeluppi indaga la creazione di immaginario da parte della cultura di massa passando in rassegna alcuni suoi personaggi e fenomeni esemplari, oltre che emblematici delle trasformazioni sociali.
Tra i meriti dell’agile volume vi è quello di mostrare come anche gli esempi più apparentemente innocenti della cultura di massa concorrano alla costruzione di un immaginario votato soprattutto alla mercificazione, al consumo e al controllo sociale, ma anche quello di ricordare come il successo dei personaggi e dei fenomeni che si sono imposti nella cultura di massa derivi innanzitutto dalla loro capacità di dare risposta ad alcune esigenze fondamentali degli esseri umani.
Tenendo presente quanto l’immaginario veicolato dalla cultura di massa statunitense si sia imposto a livello globale, il viaggio di Codeluppi prende il via da alcuni celebri esempi di pop culture made in USA: l’universo Disney, Marilyn Monroe e Barbie. Lo studioso sottolinea come il successo del mondo Disney derivi soprattutto dalla sua capacità di rivolgersi anche agli adulti consentendo loro di sentirsi nuovamente bambini. Al contempo Disney guarda ai bambini come a dei piccoli adulti-consumatori, contribuendo così a privarli dell’infanzia.
Tra le caratteristiche del mondo Disney, lo studioso mette in luce la tendenza a evitare il confronto diretto con l’attualità a cui vengono preferite ambientazioni proiettate in un immaginifico futuro o, più spesso, in un passato di fantasia che, come nel caso del medioevo fantastico, si propone come riflesso deformato dell’attualità consentendo al fruitore di guardare a quest’ultima con un rassicurante distacco. Particolarmente presente nel panorama disneyano, sottolinea Codeluppi, è anche l’esaltazione delle cultura meccanico-industriale cara al fondatore, così come al sistema produttivo statunitense. In generale l’immaginario disneyano è permeato dalla cultura consumista, tanto che, nei suoi parchi di divertimento, il tema pedagogico dichiarato si rivela un mero presto «per mascherare il principale modello ideologico presente nei parchi della Disney: quello delle merci che devono essere acquistate» (p. 22). Presentato come componente del divertimento e della fantasia, il consumo viene proposto come parte integrante dell’esperienza a cui è tenuto a sottoporsi il visitatore. Circa poi gli sviluppi più recenti delle proposte Disney, l’autore si sofferma sul ricorso al “cinema dinamico”, un’esperienza immersiva che si inserisce all’interno del processo di progressivo annullamento della distinzione tra realtà e artificiale.
Andy Warhol è sicuramente tra gli artisti che meglio hanno intercettano l’immaginario statunitense degli anni Sessanta, come testimonia la scelta di misurarsi artisticamente non con il regno degli “elementi primari” (natura) ma con quello degli “elementi secondari” (artefatti) guardando all’essere umano come a un consumatore di prodotti seriali. In tale ottica l’artista ricorre ai personaggi dei fumetti, alle confezioni delle merci industriali e alle star dello spettacolo come Marilyn Monroe come ad altrettante icone che solleticano l’immaginario popolare. Codeluppi si sofferma su come l’attrice statunitense sia stata trasformata in quel particolare tipo di merci immateriali «che invitano alla sperimentazione, che non spingono a esclusioni e giudizi, ma si offrono costantemente al mondo» (p. 27). L’icona a cui è stata ridotta Marilyn l’ha elevata a immagine complessa, a «forma espressiva collettiva e condivisa che non presenta narrazioni, né particolari punti di vista e, proprio per questo, può agire efficacemente all’interno della cultura di massa coinvolgendo in profondità le persone» (p. 33).
Tra i fenomeni più longevi della cultura di massa vi è senza dubbio la bambola Barbie messa sul mercato sul finire degli anni Cinquanta e recentemente celebrata dal film Barbie (2023) di Greta Gerwig. Se da un lato tale bambola sembra proporsi come un modello di emancipazione femminile, dall’altro non sfugge come il corpo e la cura riservata all’aspetto tradiscano un assoggettamento all’immaginario maschile. Criticata per il suo proporre alle bambine un modello femminile inarrivabile, la casa produttrice ha modificato in senso leggermente più realistico le forme fisiche della bambola, proponendola, inoltre, in diversi colori di pelle, capelli e occhi, in versioni dai tratti Down e in sedia a rotelle. Nonostante ciò, il modello culturale incarnato dalla bambola in tutte le sue versioni resta quello di «un tipo di donna che considera la bellezza una virtù imprescindibile e che si presenta in pubblico sempre perfettamente curata, secondo un modello femminile tradizionale» (p. 41). Inoltre, ricorda Codeluppi, mentre da un lato la casa produttrice, in ossequio al cosiddetto “capitalismo woke”, ha inteso fornire ai consumatori un’immagine del marchio eticamente corretta, dall’altro dimostra ben poco interesse per le condizioni a cui sono costrette le lavoratrici cinesi che producono le bambole per conto della ditta californiana.
Codeluppi si sofferma anche su come il film Balde Runner (1982) di Ridley Scott abbia saputo incarnare e al tempo stesso trasmettere, in apertura degli anni Ottanta, il senso della “fine dell’utopia”, la condanna a sopravvivere in una realtà priva di vie d’uscita, in uno stato di crisi permanente, mancante di connessioni con il passato e il futuro, in una condizione identitaria sempre più precaria e in una crescente difficoltà nel relazionarsi con l’Altro. Sia i replicanti di Blade Runner che gli esseri antropomimetici della serie Westworld (dal 2016) creata da Jonathan Nolan e Linda Joy presentano qualche traccia di coscienza, tanto da ribellarsi al sistema che li ha prodotti. Soprattutto nella serie televisiva la condizione di questi esseri antropomimetici in balia del controllo aziendale rimanda palesemente a quella degli esseri umani contemporanei che, invece, sembrano meno propensi alla ribellione.
Un ruolo importante nella cultura di massa spetta a star della musica pop come Madonna, Lady Gaga e Taylor Swift, che Codeluppi, riprendendo le interpretazioni proposte da Brendan Canavan e Claire McCamley (The Passing of the Postmodern in Pop?, 2020), indica come tre esempi di altrettante fasi evolutive dell’epoca postmoderna. Madonna incarna il classico american dream realizzato: una ragazza proveniente da una famiglia working class di immigrati del Michigan che, trasferitasi a New York con pochi dollari in tasca, riesce a divenire una celebrità. Il successo di Madonna deriva da un’indubbia abilità nel trasformarsi interpretando di volta in volta diverse figure femminili stereotipate. In linea con quanto sostenuto da Jean Budrillard (Miti fatali, 2014), Codeluppi ritiene che Madonna abbia saputo fare della mancanza di un’identità forte un’occasione per assumerne tante e diverse.
Come Madonna, anche Lady Gaga ha costruito la sua popolarità sull’abilità di trasformare costantemente la sua immagine. Pur evitando di proporre un’immagine fortemente trasgressiva di sé, Lady Gaga ha saputo suscitare identificazione tra gli adolescenti che, per i più diversi motivi, non si sentono pienamente accettati dalla società e ciò ha fatto di lei una sorta di regina delle identità diverse. In linea con l’ultima fase evolutiva del postmoderno, il personaggio di Taylor Swift, nel suo aspetto da brava ragazza di provincia, semplice, diretta e facilmente imitabile dalle adolescenti, sembra incarnare invece una sorta di riappacificazione dell’individuo con una società in cui i continui cambiamenti non sono più dettati dal soggetto che non si adegua alla realtà, ma sono ad esso imposti dalla flessibilità richiesta dal mercato. Secondo Codeluppi il principale motivo del successo ottenuto da Taylor Swift deriva dalla capacità identificativa che permette alle adolescenti di riconoscersi nella lotta a cui è costretta la loro star semplice e genuina nel farsi strada in un mondo controllato dagli uomini. Altra indubbia abilità della cantante è quella di ricorrere nelle sue canzoni a testi in equilibrio tra autoreferenzialità e apertura alle problematiche altrui, consentendo così a tante adolescenti di identificarsi in quei testi in quanto percepiti come sinceri. Se Lady Gaga si propone come una sorta di madre protettrice delle identità diverse, Taylor Swift si presenta non come star, ma come “la migliore delle amiche” a cui guardare.
Nella cultura di massa un ruolo importante spetta sicuramente agli eroi del mondo Marvel di cui Codeluppi si è recentemente occupato all’interno del volume La morte della cultura di massa (2024) tratteggiandone l’evoluzione a partire dallo loro comparsa negli anni Trenta del secolo scorso, passando per il processo di umanizzazione a cui sono stati sottoposti negli anni Sessanta, sino alla recente creazione di un grande e unico Marvel Cinematic Universe i cui film, sfruttando l’abitudine del pubblico più giovane alla serialità delle piattaforme, non mancano di rinviarsi l’un l’altro. Il successo del sistema Marvel avrebbe, secondo il sociologo, contribuito ad accelerare la crisi dei film di fascia media. Codeluppi si sofferma in particolare sul personaggio Joker che nei due film di Todd Phillips – Joker (2019) e Joker: Folie à Deux (2024) – è giunto a emanciparsi completamente dall’universo Batman manifestandosi come un irrecuperabile soggetto privo di scrupoli a cui una parte della popolazione guarda come a una vittima del sistema e come simbolo a cui rifarsi per scatenare una rivolta a prescindere dalle sue intenzioni di prendervi parte.
Nella formazione della cultura di massa ha indubbiamente un ruolo di primo piano la televisione sin dalla sua nascita quando, almeno nel panorama italiano, proponendosi una funzione pedagogica, mantiene gli spettatori rigorosamente all’esterno dello schermo, dando luogo a una comunicazione frontale priva di interattività. Tale modello televisivo (Paleotelvisione) viene soppianto, a partire dagli anni Ottanta, da quella che Umberto Eco ha definito Neotelevisione, caratterizzata, oltre che da un’inedita spettacolarità, dalla ricerca del coinvolgimento degli spettatori all’interno dei programmi. Una nuova evoluzione del medium televisivo ha dunque condotto alla cosiddetta Transtelevisione che ha adottato il modello comunicativo dei reality show a cui si rifanno gli stessi talent. Tale modello comunicativo si basa sullo spettacolo offerto da persone comuni che, dal momento che hanno oltrepassato lo schermo, si limitano a mettere in scena, per quanto in maniera esasperata, ciò che li accomuna agli spettatori. Il successo di molti di questi sconosciuti personaggi televisivi, più che da una qualche abilità extra-ordinaria (indispensabile nella Paleotelevisione), sembra derivare dalla capacità che manifestano nella gestione della loro immagine in pubblico, che, del resto, è ciò che chiede il modello di società attuale, di cui Codeluppi si è occupato, ad esempio, nel libro Mi metto in vetrina (2015).
In conclusione di Pop culture Codeluppi si sofferma su alcune serie televisive che hanno portato all’interno della cultura di massa riflessioni critiche sulla società contemporanea e sul ruolo negativo esercitato su di essa dai media e, più in generale, dalle tecnologie. La serie televisiva coreana Squid Game (dal 2021) scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk, estremizzandoli, mostra egregiamente gli esiti nefasti a cui possono condurre i processi di gamificazione a cui sono sempre più frequentemente tenuti a sottostare gli esseri umani contemporanei in ambito lavorativo e, più in generale, nella loro quotidianità. Così come in Squid Game a trarre godimento non sono i vincitori delle sfide mortali, ma i facoltosi spettatori privilegiati che scommettono sui contendenti osservandoli dagli schermi, nella società contemporanea a trarre profitto dai processi di gamificazione a cui sono sottoposti gli individui sono esclusivamente le corporation che prosperano sulla competizione degli esseri umani ridotti a gamer.
Codeluppi si sofferma anche sulla serie britannica Black Mirror (dal 2011) ideata e prodotta da Charlie Brooker per le riflessioni critiche che propone a proposito del rapporto tra gli esseri umani contemporanei e le nuove tecnologie, soprattutto mediatiche. Certo, se da un lato serie come Squid Game e Black Mirror hanno indiscutibilmente il merito di invitare gli spettatori a riflettere sulle nuove forme di sfruttamento a cui sono sottoposti quotidianamente, dall’altro lo fanno all’interno di piattaforme che prosperano ricorrendo ai meccanismi del capitalismo digitale contemporaneo. Insomma, mentre la piattaforma, attraverso sue opere, ci mette in guardia circa la deriva a cui conducono gli attuali processi di gamificazione e di sorveglianza digitale, questa non manca di profilarci, mercificarci e renderci produttivi.



