di Fabio Ciabatti
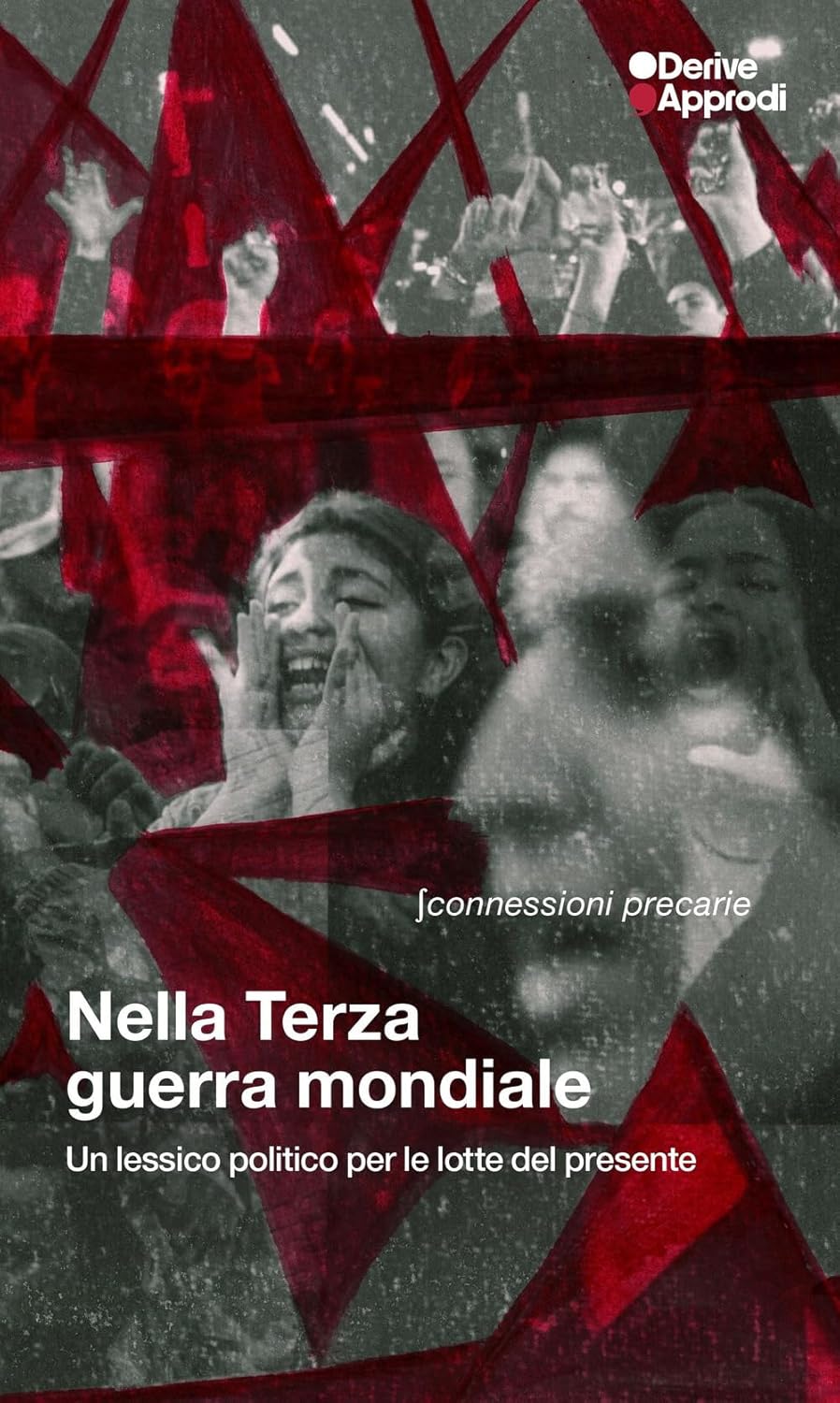 ∫connessioni precarie, Nella Terza guerra mondiale. Un lessico politico per le lotte del presente, DeriveApprodi, Bologna 2025, pp. 116, € 15,00
∫connessioni precarie, Nella Terza guerra mondiale. Un lessico politico per le lotte del presente, DeriveApprodi, Bologna 2025, pp. 116, € 15,00
Di fronte “a ogni guerra la prima richiesta è sempre e comunque che le armi tacciano”. Ciò nonostante, “il nostro problema non è solo condannare la guerra ma anche opporre alla sua dura realtà parole e pratiche che essa non sia in grado di governare”. Se questo non avviene possiamo ottenere al massimo una tregua che non consente di cancellare le cause dei conflitti bellici. Queste considerazioni, che troviamo nel libro “Nella Terza guerra mondiale. Un lessico politico per le lotte del presente”, assumono particolare rilievo in considerazione della tragica scelta che deve affrontare Hamas, insieme alle altre formazioni armate palestinesi, di fronte al cosiddetto piano di pace di Trump: continuare la lotta armata facendo proseguire l’immane carneficina o arrendersi per interrompere il supplizio che comunque proseguirà, anche se, presumibilmente, con tempi più lunghi e modalità meno feroci. La resistenza palestinese sembra davvero trovarsi di fronte a una drammatica impasse. E allora, per non lasciarsi bloccare in questo vicolo cieco può essere utile adottare uno sguardo diverso nei confronti della coraggiosa lotta della popolazione di Gaza (e della Cisgiordania) con l’obiettivo di prefigurare possibili via di fuga dal tragico stallo a cui sembra destinata. Anche perché bisognerà in qualche modo approfittare delle condizioni tutt’altro che ideali in cui si trova oggi lo stato sionista, lacerato da profonde contraddizioni interne e investito da una diffusa condanna internazionale.
Certo, di fronte a un genocidio, ci si può legittimamente chiedere se sia possibile mantenere uno sguardo lucido sugli aspetti critici della resistenza palestinese senza divenire complici dei carnefici israeliani. O senza scadere in un eurocentrismo che solidarizza con i popoli oppressi solo finché non si ribellano perché, con i mezzi a loro disposizione, raramente lo possono fare rispettando il preteso bon ton occidentale. Sicuramente, non teme di andare controcorrente rispetto all’opinione diffusa nella sinistra, compresa quella radicale, l’autore collettivo che ha dato alle stampe il testo qui recensito. Si tratta di ∫connessioni precarie, un’area politica che assume come obiettivo centrale della sua analisi e della sua attività pratica la condizione globale e differenziata del lavoro contemporaneo che è sottoposto all’intreccio tra patriarcato, sfruttamento e razzismo. Benché Nella Terza guerra mondiale non sia un testo dedicato alla questione palestinese, come si può facilmente capire dal titolo, crediamo valga la pena partire da ciò che sta accadendo in Medio Oriente perché, dato il suo carattere estremo, può rappresentare un’utile cartina di tornasole per valutare le tesi di questo agile ma densa pubblicazione. Ebbene, la risposta dell’autore collettivo è che si possono criticare i movimenti di resistenza, compreso quello palestinese, anche se questo non significa minimamente praticare una facile equidistanza tra oppresso e oppressore. Significa, invece, non farsi risucchiare nella logica che costruisce nemici esistenziali al di fuori di ogni considerazione dei rapporti sociali, sessuali e storici all’interno dei quali maturano i conflitti.
Spesso si sente dire che gli occidentali, in qualità di alleati della lotta palestinese, possono solo ascoltare e sostenere “l’unica parola autentica, e quindi giusta e incontrovertibile”:1 la parola pronunciata dai palestinesi. Ovviamente per l’autore non si tratta di mettere in dubbio il dato di fatto che ciascun popolo oppresso sceglie autonomamente le sue forme di lotta e le sue opzioni politiche. In fin dei conti la resistenza e la necessità di stringere i ranghi per combattere l’oppressore sono prima di tutto determinate dalle condizioni materiali. Ma c’è un altro dato di fatto di cui bisogna tener conto: ogni movimento di liberazione è sempre attraversato da differenti opzioni ideologiche perché qualsiasi popolo oppresso, compresi i palestinesi, non costituisce un corpo omogeneo che vive al di fuori della storia e dei rapporti sociali.
Questa complessità, secondo l’autore, è sostanzialmente ignorata dal pensiero decoloniale che, per certi versi, rappresenta l’opposto speculare rispetto alla pretesa del capitale e degli Stati di stabilire fronti interni omogenei e compatti neutralizzando i rapporti sociali a sostegno del loro posizionamento nell’ambito della Terza guerra mondiale in corso (sulla natura di questa guerra, ovviamente, ci torneremo). Ma è proprio il lessico della decolonialità che ha finito per saturare l’intero discorso sull’attuale conflitto bellico globale per ridurlo a un episodio della secolare guerra dell’Occidente coloniale contro l’Altro resistente e rivoluzionario. Questo approccio si concretizza in una “re-esistenza” finalizzata alla ricostituzione di forme di esistenza precoloniali presuntamente sopravvissute al dominio coloniale. In questo modo la miseria del presente viene rifiutata in nome di un passato mitico, depotenziando la capacità delle lotte nel sud globale di rappresentare un evento sovversivo e imprevisto della storia, potenzialmente foriero di un’alterità che può essere coniugata solo al futuro.
Il discorso decoloniale, in altri termini, mette capo a conflitti articolati soprattutto sul livello della resistenza che, avendo un carattere sostanzialmente reattivo, si concretizzano in un’azione di contrasto in un campo di forze stabilito dalla controparte, incarnata di volta in volta da un governo, uno Stato, un regime, una piattaforma capitalistica. Di conseguenza la resistenza non è di per sé garanzia di una politica partigiana volta all’emancipazione dallo sfruttamento e dall’oppressione. La flessibilità del discorso decoloniale, infatti, gli consente di prestarsi perfino a curvature etno-nazionaliste che, ancor più della resistenza genericamente intesa, si rafforzano nella logica della guerra, a sua volta rafforzata dalla riproposizione di un intrascendibile dualismo.
Se l’appello alla resistenza ha contribuito alla riproduzione di una logica di guerra, questo non significa, secondo l’autore, che bisogna abbandonare del tutto il suo linguaggio, a patto di riuscire a riattivare la connessione tra resistenza e trasformazione sociale. Allo stesso modo non bisogna fare a meno delle rotture e delle crepe aperte dalla decolonialità che, come sottolinea il testo, figurano al principio dell’attuale movimento transnazionale del lavoro vivo grazie alla insubordinazioni dei popoli indigeni ecuadoregni, boliviani e chiapanechi, vere e proprie irruzioni del margine nel centro dove regnavano solo libero commercio, proprietà privata, diritti umani e Fukuyama. Ciò significa che, come accaduto più volte in passato, la resistenza può innestarsi dentro momenti organizzativi e progettuali contro lo sfruttamento e l’oppressione riuscendo a trasformare lo stesso campo di lotta e a politicizzare soggetti che non sono già determinati a priori.
Ora, tutto il discorso che abbiamo sommariamente sintetizzato sarebbe difficilmente comprensibile se staccato dalle considerazioni sulla terza guerra mondiale. Essa coincide con la manifestazione più violenta di quello che l’autore definisce il transnazionale, cioè l’attuale configurazione del sistema mondiale caratterizzato dall’impossibilità di imporre un ordine globale stabile e continuativo. In altri termini, siamo di fronte a un disordine non ricomponibile perché la valorizzazione del capitale oggi può avvenire solo a livello globale che, però, allo stato attuale, non è governabile secondo logiche politico-statuali. E ciò vale tanto per la retorica dei dazi trumpiana, indebolita dall’impossibilità del totale disaccoppiamento tra Cina e USA, quanto per l’idea di una moneta comune dei Brics che è impedita dal fatto che l’80% delle transazioni mondiali avviene attraverso il dollaro, sottolinea il testo. Questa tensione si scarica sui singoli stati che sono al tempo stesso necessari e non sufficienti a garantire la disponibilità di risorse umane e materiali per la valorizzazione dei capitali di riferimento. In questo contesto, la guerra rappresenta un salto di qualità decisivo nel disallineamento tra dimensione politica, istituzionale e territoriale dello Stato e dimensione spazio-temporale della valorizzazione nonostante ogni tentativo di rinazionalizzazione o regionalizzazione della produzione.
Assistiamo quindi all’ultimo capitolo in ordine di tempo della crisi della sovranità che però, per quanto monca, rimane lo strumento migliore per affermare regole decise da una governance allargata e mobile costituita da governi, frazioni di capitale, società di investimento multinazionali, thanks thank, centri di ricerca e produzione della conoscenza.
Allo stesso tempo, crisi della sovranità significa incapacità dello Stato di produrre unità nella società attraverso la creazione e la trasmissione di valori comuni. Viene meno la capacità di integrazione sociale e politica sperimentata attraverso i processi di mediazione democratica e, in particolare, per mezzo della mediazione politica e istituzionale tra capitale e lavoro sedimentata nel Novecento. Anche nei paesi capitalisticamente sviluppati elementi autoritari si innestano all’interno di un framework istituzionale che rimane formalmente democratico.
Il tutto si concretizza in un militarismo che si impone anche al di fuori dei teatri propriamente bellici. Un militarismo che bisogna distinguere dalla militarizzazione in senso stretto, cioè dalla mobilitazione totale propria di un’economia di guerra. Si tratta, di fatto, della riproposizione in armi del mantra neoliberale “non c’è alternativa” con un’intensificazione dei suoi contenuti autoritari, patriarcali e razzisti, funzionali alla ridefinizione complessiva delle condizioni dell’accumulazione e dello sfruttamento. Il militarismo, dunque, rilegittima lo Stato non in quanto garante della riproduzione sociale dei suoi cittadini, ma nella sua qualità di attore in grado di esercitare il disciplinamento sociale e la sottomissione della forza lavoro.
Con la cittadinanza svuotata di ogni contenuto sociale e di ogni valenza universalistica, però, resta ben poco dell’imperativo patriottico novecentesco. La logica militarista, in sostanza, è in grado di ricompattare solo retoricamente la nazione attraverso la guerra contro un nemico esterno e interno che può essere di volta in volta diverso. Ciò che rimane è essenzialmente la normalizzazione della violenza come risposta a ogni forma di insubordinazione. Una violenza preparata da decenni di militarizzazione dei confini contro la presunta invasione dei migranti. Non a caso la mobilità di questi ultimi (insieme a quella del capitale) continua a sfidare gli Stati impegnati a impedire che la scelta di migrare si trasformi nella permanenza nelle società di arrivo dove gli stessi cittadini devono fare i conti con il venir meno di garanzie, diritti sociali e tutele.
In ogni caso, il potere sempre più arbitrario nei confronti dei migranti non mira a sigillare le frontiere e fare a meno di loro, ma a regolare e irreggimentare la mobilità della manodopera che deve essere valorizzata come strumento di precarizzazione, frammentazione e coazione, con un effetto disciplinante va ben oltre il lavoro degli stranieri. Insomma gli Stati devono governare una dinamica contraddittoria di attrazione e repulsione che può essere precariamente gestita attraverso il razzismo soltanto fino a quando non emerge una soggettività dei migranti. La violenza degli Stati opera, infatti, per limitare la visibilità delle loro lotte per depotenziare quelle pratiche organizzative e di conflitto, in primo luogo lo sciopero, con le quali negli anni il lavoro migrante è riuscito a rappresentarsi come forza collettiva.
L’incapacità degli Stati di affrontare i problemi più urgenti del nostro tempo si manifesta anche di fronte alla crisi climatica che, pure, in un primo momento era stata utilizzata come occasione per rilanciare l’accumulazione. La cancellazione dell’ecologia come problema indifferibile in nome dell’emergenza bellica mostra l’impossibilità di Stati e capitale di affrontare questa crisi tramite un’accumulazione capitalistica pianificata. Sta di fatto che il mancato riconoscimento della crisi climatica come questione di classe, a cominciare dal fatto che i suoi effetti colpiscono principalmente i lavoratori e le lavoratrici povere, e la conseguente incapacità di connettere in modo strutturale le lotte ecologiche con quello del mondo del lavoro ha facilitato l’ascesa al potere della destra scettica o negazionista in grado di fare leva sul fondato timore di proletari e proletarie di dover pagare i costi della transizione green.
Dovrebbe essere oramai chiaro che non è più possibile pensare i conflitti climatici al di fuori di un orizzonte di opposizione di classe alla guerra. Questo tipo di opposizione, in realtà, emerge in tutto il libro come l’unica possibile risposta alla crisi del nostro mondo che si concretizza nella terza guerra mondiale. La domanda che ci si pone è dunque la seguente: come è possibile porre fine a questa guerra sottraendola al monopolio geopolitico che fa degli Stati e dei regimi parastatali gli unici attori rilevanti?
Questa domanda sembrerebbe aprire a scenari irrealisticamente ambiziosi se non si tenesse conto del fatto che è “oltremodo improbabile, e in fondo nemmeno auspicabile, che questa guerra finisca con uno stato vincitore in grado di assurgere a guardiano di un nuovo equilibrio mondiale”2. Il suo esito è ancora aperto.
La guerra mondiale può essere letta tanto come una risposta all’esigenza di un comando sul lavoro vivo a livello mondiale, quanto come evento all’interno del quale si creano inaspettate condizioni affinché si affermi una potenza collettiva del lavoro vivo che è l’unica concreta forza di pace che possiamo aspirare a sostenere.3
Questa seconda lettura è possibile solo tenendo in considerazione il fatto che nel transnazionale il lavoro vivo è ancora in cerca di organizzazione perché ha una conformazione diversa dal passato:
la classe non è più un’identità operaia data dalla produzione, né può essere superata dalle molteplici identità di razza, sesso e cultura nella riproduzione, ma indica la possibilità della costituzione di un soggetto in azione tra produzione e riproduzione che metta in movimento differenze e contraddizioni caratterizzanti il lavoro vivo di operai, precari, donne e migranti nel mercato mondiale.4
Si possono superare gli attuali rapporti di forza favorevoli al capitale a patto di non immaginare la lotta di classe come scontro tra fronti compatti, come se il paradigma delle nostre lotte dovesse essere ricalcato sulla logica bellica. Oggi, infatti, bisogna fare i conti
con soggetti frammentati, con movimenti transnazionali diversi e molteplici che hanno fatto letteralmente esplodere i presupposti organizzativi e la concezione omogenea della classe dell’internazionalismo storico. Il problema è come approntare processi organizzativi che riescano a dare spazio, voce e continuità al movimento del lavoro vivo attraversando le differenze che lo compongono.5
Un problema che è possibile affrontare solo se siamo in grado di combattere il capitale sul terreno su cui si costituisce il suo dominio.
La dimensione transnazionale è l’unica in cui fare delle differenze che ci dividono, contro lo scacco del campismo, il punto di forza di un lavoro organizzativo che si pone come esplicito obiettivo quello di costruire la nostra parte dentro e contro la guerra: fare, in altre parole, della nostra politica di pace la guida pratica per preparare le condizioni di uno sciopero sociale transnazionale contro la guerra e il suo mondo.6
In sede di commento, possiamo sottolineare che il testo si può sottrarre alle tentazioni del campismo, cioè all’attitudine di schiacciare le lotte sociali sul sostegno a uno specifico campo geopolitico, mettendo in evidenza il concetto di transnazionale, vale a dire l’idea di un ordine mondiale oramai compromesso e non ricomponibile in forza delle attuali logiche della valorizzazione capitalistica. Un’idea tutto sommato condivisibile anche se forse portata all’estremo. In particolare, non è da escludere del tutto la possibilità di una ricostruzione, sulle macerie fumanti una parte cospicua del globo, di nuove gerarchie globali, ben più oppressive di quelle precedenti, qualora nella terza guerra mondiale prevalesse il polo statunitense. In questo senso potrebbe non essere indifferente rispetto allo scontro di classe quale sia l’esito del conflitto geopolitico. Questo non perché si debba ricercare qualche nuovo stato guida, ma solo e soltanto perché la mancata sconfitta del polo cinese e di quello dei Brics lascerebbe lo scenario maggiormente aperto, impedendo il consolidarsi di una nuova gerarchia a livello globale, anche in considerazione dell’estrema improbabilità che si affermi un nuovo e stabile ordine multipolare, dati gli attuali rapporti di forza nell’ambito della presente conformazione del capitalismo transnazionale.
Ma l’aspetto su cui vorrei maggiormente soffermarmi è quello della costruzione di una soggettività antagonista transnazionale, alla luce di quello che sta accadendo in Palestina. A tal proposito vale la pena citare quanto sosteneva Mahmoud Darwish dopo il massacro di Sabra e Shatila del 1982. A seguito di quelle tragiche vicende, il poeta palestinese affermava che ogni suo compatriota
è ingombrato dall’incedere incessante della morte e impegnato nella difesa di ciò che rimane della sua carne e del suo sogno… le sue spalle sono contro il muro, ma i suoi occhi rimangono fissi sul suo paese. Non riesce più a urlare, non riesce più a comprendere la ragione del silenzio arabo e dell’apatia occidentale. Può solo fare una cosa, diventare ancora più palestinese… perché non ha altra scelta.7
Questa scelta sembrerebbe ancora più obbligata oggi, di fronte all’attuale violenza genocida che rappresenta un salto qualitativo anche rispetto alle già efferate vicende del 1982. D’altra parte, questo salto non è il frutto di un singolo stato criminale perché vede l’attiva complicità dei governi e dei capitali nord occidentali (e la sostanziale passività di quelli arabi) a testimonianza di un disordine internazionale di fronte al quale soggetti fino a poco tempo fa capaci di esprimere egemonia provano a rimettere insieme i pezzi a forza, attraverso una violenza fuori scala rispetto ad ogni recente parametro. La perdita di qualsivoglia limite alla ferocia bellica, come indica l’estrema crudeltà ostentata via social, sembra condannare la resistenza palestinese, sostanzialmente osteggiata dagli attori geopolitici che più contano in Medio Oriente. Rimane da chiedersi se, nelle tragiche condizioni attuali, sia possibile un salto di scala, nel senso auspicato dal testo, che vada al di là della pur legittima rivendicazione di una patria, facendo leva sull’ampia solidarietà ricevuta dai movimenti sociali a livello globale e sulle contraddizioni interne della società israeliana. Queste ultime si sono certamente manifestate con forza, cosa certamente positiva per la sorte dei palestinesi, ma fino ad oggi la solidarietà o la semplice empatia nei confronti della popolazione di Gaza è stata decisamente estranea alla grande maggioranza degli israeliani che si sono mobilitati.
Tutto ciò per dire che l’opzione per un’opposizione transnazionale appare comprensibile anche se non proprio all’ordine del giorno. Il che non significa che non si darà qualcosa di simile. Ma in questo processo di organizzazione di un soggetto strutturalmente molteplice e frammentato potrebbe esserci anche lo spazio per un’identità palestinese (o ecuadoregna, boliviana, chiapaneca, per riprendere gli esempi del libro), intesa non come rivendicazione etno-nazionalista, ma come riappropriazione di una specifica tradizione di lotta contro l’oppressione e lo sfruttamento da mettere in connessione con altre tradizioni con obiettivi convergenti. Perché, riprendendo ancora Darwish, per rispondere alla domanda cosa significa patria non è sufficiente mostrare una cartina geografica o rievocare la tomba del proprio nonno. “La lotta è la risposta. Se combatti appartieni a qualcosa. La patria è lotta”.8
In ogni caso, quello che sembra difficilmente contestabile è il ragionamento di fondo che si trova nel testo di ∫connessioni precarie: “Rifiutare il militarismo e la logica del nemico significa che la nostra parte non è già data, ma che può costruirsi proprio attraverso l’opposizione alla guerra”.9
∫connessioni precarie, Nella Terza guerra mondiale. Un lessico politico per le lotte del presente, DeriveApprodi, Bologna 2025, p. 82. ↩
Ivi p. 20. ↩
Ivi, p. 101. ↩
Ivi, p. 25. ↩
Ivi, p. 102. ↩
Ivi, p. 103. ↩
cit. in Ruba Salih, Gaza e Israele. Ripensare l’umano tra guerra, violenza e trauma coloniale, https://www.globalproject.info/it/mondi/gaza-e-israele-ripensare-lumano-tra-guerra-violenza-e-trauma-coloniale/24664. ↩
Mahmoud Darwish, Diario di ordinaria tristezza, in Id, Una trilogia palestinese, Feltrinelli, Milano 2017, p. 48, edizione Kindle. ↩
∫connessioni precarie, Nella Terza guerra mondiale, cit., p. 54. ↩



