di Franco Pezzini
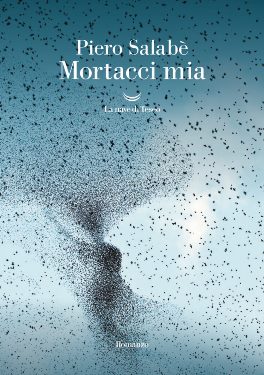 Piero Salabè, Mortacci mia, pp. 384, € 20, La nave di Teseo, Milano 2025
Piero Salabè, Mortacci mia, pp. 384, € 20, La nave di Teseo, Milano 2025
– Come è possibile!
– Cosa, Aič?
– Che il nostro mondo sia già finito se la nostra vita non è neppure iniziata?
La ricerca di un padre perduto, morto o comunque scomparso, da parte di un figlio maschio più o meno fratto dentro, è un topos fertile di declinazioni – idealmente, potremmo dire, dall’Eneide a Dancing Paradise di Pupi Avati, fino a questo bel romanzo. Perché cercare il padre? Per i motivi, come intuibile, più vari: per recuperare la propria adultità o per sanare nodi mai sciolti d’un rapporto, per riprendere il filo del proprio passato, per cercare un amore la cui manifestazione nel tempo sia stata difettosa per mancanze del genitore o del figlio, per loro latenze, distanze o incomunicabilità. Tutto ciò, in qualche modo, è presente anche qui.
Come tutti i figli maschi, ho anch’io dovuto “ritrovare” mio padre, e i dettagli non interessano i lettori: ma è per dire che del vorticoso, appassionato, malinconico, ironico romanzo di Piero Salabè, Mortacci mia – titolo da intendere più come gioco affettuoso sui nostri morti che come sorpresa esclamazione d’uso locale – ha poco senso domandarsi quanto vi sia d’autobiografico, al di là della dedica “Alla memoria di mio padre”. Uno scrittore – e Salabè lo è indubbiamente, con una solida consapevolezza letteraria – non affida alla forma romanzo una mera memoria fattuale: a prescindere dai materiali con cui è costruito, un romanzo è sempre fictio, tanto più come in questo caso dove gioca vorticosamente con registri surreali o persino fantastici. Ma in questa fictio – che, potere della letteratura, è deputata a dire cose veridiche – si respira una verità dolente e spudorata, onesta e beffarda, ossessiva e conflittuale che restituisce vita davvero vissuta. Il pigro, in apparenza disincantato Fabio, voce narrante che vive all’estero da tanto tempo, letterato tra le incomprensioni degli altri familiari, di tanto in tanto torna a Roma: e delle città trasfigurata fantasiosamente (fino a trovate come l’Università degli Studi “La Brillanza”), tra figure caratteristiche e luoghi dei tempi andati coglie aspetti lirici e sordidi meditando sul proprio passato. Che ci stiano frammenti di un’autobiografia reale è abbastanza inevitabile ma non è così importante discettarne.
Il romanzo si struttura idealmente in tre parti (attenzione, seguono spoiler). Anzitutto la presa d’atto da parte di Fabio della scomparsa dalla casa di riposo, dov’era ricoverato per sopraggiunta demenza, del padre Luigi Pintor: già luminare della ricerca medica e insieme brav’uomo frustrato dagli scarsi riconoscimenti e dai sogni abortiti, in un impasto strano e malinconico, buffo e tenero di idealismo e fragilità, dedizione alla scienza e coscienza di limiti anche nei rapporti coi figli, conflitto eroico contro poteri forti (lottizzazioni partitiche, abusi di baroni) e sostanziale lucidità su un finale ritrarsi dal mondo. Messo a riposo per età dopo una vita al Policlinico – ufficialmente Policlinico Felisberto II, istituzione labirintica e colossale nel cuore dell’Urbe dove paiono essersi consumate tutte le ruberie, corruzioni e malversazioni dell’orbe –, Luigi potrebbe essersi suicidato tuffandosi in uno degli insondabili pozzi artesiani sparsi nei campi: “Ma perché allora mancava la borsa da medico che si era fatto portare nella casa di riposo?”. Così, mentre una parte della famiglia si rassegna, anche per chiudere la pratica che lascia comunque presumere un decesso, il figlio Fabio da cui l’ha sempre marcato una certa distanza (“Forse noi non ci siamo mai detti niente. Tutto ciò che c’è stato e che ci è mancato, non erano parole”) inizia a cercarlo trascinato dall’attivissima sorella Lara detta Aič. Ricordando l’uomo che aveva elaborato con esemplare discrezione strategie di pace interiore e coi familiari. Del resto,
A Roma era scomparsa tutta una serie di professori estromessi dall’università per raggiunti limiti di età. Era davvero assurdo pensare che si fossero rifugiati nel Policlinico chiuso, in una terra di nessuno, per portare a compimento le loro ricerche in santa pace, senza essere perseguitati dai detrattori di un tempo? Aič ha ragione, e anch’io sono sempre più convinto che papà stia lì, e che non fidandosi ormai di nessuno, avesse messo in scena la demenza per preparare meglio la fuga.
La seconda parte del romanzo narra la febbricitante, sfinente e visionaria catabasi nel grembo ctonio del Policlinico, una Wonderland nera ufficialmente chiusa per far sorgere al suo posto il complesso termale di San (sic) Samael: ma, con le conoscenze giuste, c’è sempre modo di entrarvi di straforo. Come il regno dei morti per Enea alla ricerca di Anchise, insomma, perché il Policlinico così descritto ha molto di infero: luogo di misteriose frequenze sonore, di mutazioni dei corpi, di empatie e abbrutimenti paradigmatici. I due vi inseguono dunque le tracce del padre che potrebbe esservisi nascosto, probabilmente coinvolto nella faida lì celebrata tra due progetti filosofico-sanitari di scuole opposte: quella del collega Castellari, detto il “medico della morte”, contro l’accanimento terapeutico e “la fede irrazionale nella scienza”, e la Nuova Scuola di Fulcani e Semprebene con le tecnologie del Progetto Eternità – “Lo scopo è stabilire una relazione fra l’orgasmo, la cosiddetta ‘piccola morte’, e l’ultimo spasmo, il trapasso. Se le mie tesi dovessero essere corroborate, ci avvicineremmo alla chiave della vita umana” – scuole che si smaltiscono per esperimenti partite di anziani dal Belgio… La provocazione permette di sollevare riflessioni profonde sul rapporto con la sofferenza e con la morte in un mondo dallo scientismo aggressivo. Peccato che, a differenza che nel caso di Enea, la discesa si risolva in un fallimento, perché a dispetto delle piste e di testimonianze (quanto affidabili?) Luigi non si trova. La ricerca del padre negli inferi diventa ricerca di senso e di identità alla propria vita, per Aič in chiave di affetti e forse di sicurezza, per il protagonista a un livello di razionalità e dialogo con le perplessità e provocazioni del reale, per entrambi qualcosa che svela radici. Se infatti infero è il Policlinico, a un livello più ampio lo è l’intera Roma-Wonderland altrettanto ctonia e surreale, teatro d’un passato in cui si sono forgiate le categorie esistenziali, affettive e razionali, dei due esploratori.
Mentre la terza parte (almeno su questo evitiamo spoiler) vede una chiusura almeno temporanea della quest, un’ideale ricollocazione dei tasselli al loro posto: almeno quelli di una provocazione sulle domande fondamentali. La morte è stata ufficializzata, vi crediamo o no, la neghiamo o no – e questo metterla tra parentesi come un’ipotesi da considerare per rifiutarla, come una mera illusione che c’è qualche buon motivo per denunciare (buon motivo in noi e per noi, per quest’unica volta che siamo al mondo) è in fondo una chiave forte di tutto il romanzo.
– Cosa succede quando una persona muore?
– Non muore.
– Ma come è possibile morire e non morire?
– Non mi chiedere cose difficili, Aič.
Alla morte non riusciamo a rassegnarci, non importa quanto fantastiche, utopiche o francamente oniriche siano le soluzioni con cui intendiamo confutarla: perché in fondo – tale la provocazione – a essere impossibile è la comprensione della verità. Ed emblematica è la citazione d’incipit da Samuel Johnson , “…that immense fear that life could have a sense”, perché allora occorrerebbe comprenderlo.
“La radice della vita è il dubbio,” risuonano in me le parole di mio padre. Ma diffidare stanca, e spesso non si rivela che essere un gioco mentale.
Diffidare stanca, sembra dire malinconico l’autore, e dunque è nel clima di un’esausta sospensione di giudizio che ci lasciamo trascinare da altri alla ricerca. Che pure ci sperde, e sperde il lettore nel dedalo infero. Resta, su tutto, un senso di smarrimento in cui nessuna pista è affidabile e non è mai chiaro chi guidi chi (emblematici gli scambi con Aič all’inizio dei singoli capitoli).
Molto interessante il rapporto tra i due fratelli, liquidati come illusi e “cacciatori di fantasmi” dai due più vecchi (Alessandro e Maddalena), ma legatissimi e insieme in continuo, aspro conflitto. Molto interessante il rapporto dello scomparso con l’istituzione pubblica e le sue arroganze, le baronie, i progetti promossi per gli utili dei soliti: se Pintor ha scelto di nascondersi tra le mura che ben conosceva – seminando sassolini bianchi come in una fiaba in un contesto da incubo, popolato di folli presenze intente a sparlare l’una dell’altra, tra continui inabissamenti e impreviste risalite, caratteristi grotteschi e bizzarrie metapsichiche – non è solo per non farsi trovare. Quel regno dell’assurdo è un’immagine del mondo e di una geografia di potere dove Luigi ritiene forse di avere ancora qualcosa da dire e da dare, o forse l’immagine espiatoria degli incubi dei suoi figli, toccati in ultimo dalle amarezze di lui e per una volta pronti a condividerle. Come in un caleidoscopio, le tracce del vecchio medico si moltiplicano così tra orride putredini e procedure misteriose di iniziati all’abisso: e mentre i figli cercano di non perdere anche quel passato come già l’infanzia, la madre e la casa sgomberata di famiglia (Aič non si rassegna per affetto, il perplesso Fabio si lascia tirare) finiscono con l’imbattersi costantemente in teatrini grotteschi, da farsa. La malinconia non cede mai alla tristezza: la vita – e la morte, in fondo – sono troppo paradossali per evitare di riderne, almeno un po’.
– Hai mai sentito, Aič, di un cervo che bracca i cani?
– No, ma anche la nostra non è la legge del mondo.
– È qual è la nostra legge?
– Restare nel labirinto.



