di Luca Baiada
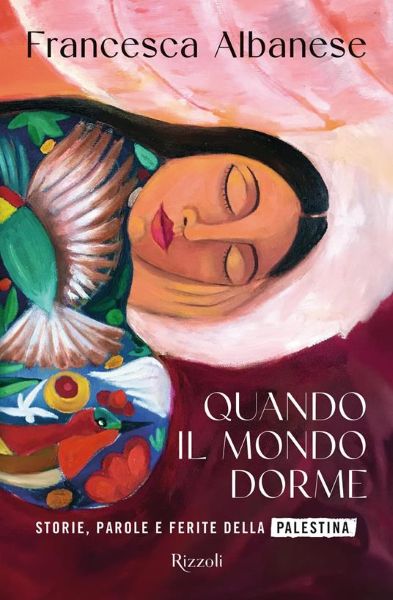 Francesca Albanese, Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina, Rizzoli, Milano 2025, pp. 288, euro 18.
Francesca Albanese, Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina, Rizzoli, Milano 2025, pp. 288, euro 18.
Relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, Francesca Albanese condivide le sue esperienze. Ne esce un libro palpitante, che freme di sostanza.
Se ne valesse la pena, si potrebbe dar conto delle offese, delle insinuazioni sulla professionalità, dei sabotaggi che hanno colpito l’autrice anche in privato. Ma chi legge è consapevole che l’impegno si paga, e sa già che ci sono conseguenze prevedibili per chi, specialmente in posti di rilievo, si schiera secondo giustizia. La protesta sterile è appena tollerata; quella costruttiva se la vede brutta; per il posizionamento giusto di chi ha responsabilità ufficiali, poi, non ci sono riguardi.
Questa giurista tenace è innamorata della vita, anche quella degli altri; si aggrappa al lavoro, compresi i problemi che comporta, e va per la sua strada. Quel lavoro, grazie a un’energia vulcanica, riesce a proseguirlo «e, in modo controintuitivo, a continuare ad amarlo». Solo se si tiene presente questo, si apprezza sino in fondo un libro che segue le persone e che alle persone si rivolge.
Persone, tante persone. Alcune non sono più, tutte hanno qualcosa da dirci, in un volume che persino nella divisione in capitoli segue il filo delle loro storie. Chi conosce il peso soporifero dei soliti scritti biografici dei giuristi e del notabilato, qui riceve una sorpresa a colori. Una giurista che non annoia? una relatrice dell’Onu che fa capire a caldo problemi complessi? Deve aver pagato un prezzo, per conquistare questa chiarezza, ma non lo fa pesare, perché ha dalla sua una scelta di campo. Una scelta convinta, sempre argomentata. La scelta dei fatti.
Il quadro generale è esplicito; il sistema che schiaccia i palestinesi ci riguarda tutti:
È il sistema che decide al posto nostro su questioni determinanti della vita di tutti noi, senza necessariamente ascoltarci e rappresentarci; quello che trasforma il lavoro in precariato e i diritti in privilegi, che fa in modo di alienarci gli uni dagli altri, rendendoci tutti più fragili e insicuri; che considera la solidarietà un atto sovversivo e l’empatia una forma di disfunzione mentale e sociale[1].
Se l’oppressione non ha confini, anche la liberazione o è di tutti o non funziona: «Nella liberazione del popolo palestinese dall’oppressione dell’apartheid c’è la chiave per la liberazione degli stessi israeliani»[2].
Nessuno può chiamarsi fuori, perché una linea del colore, diseguale ed esclusivista, colonizza l’umanità su scala mondiale. Anche l’operazione securitaria in atto in Italia, con la stretta sulle libertà e i lacci alle mobilitazioni sociali, realizza una discriminazione che controlla i rapporti di lavoro, lo spazio, la cultura. Nei metodi militari e polizieschi, poi, la sperimentazione sui palestinesi collauda tecniche applicabili dappertutto.
Albanese spiega: «La sicurezza in quella terra – e non solo, purtroppo – è a senso unico; se sei palestinese, viene invocata solo per reprimere la tua libertà. Per punirti». Evidentemente esiste una sicurezza unilaterale: può presentarsi in grado estremizzato ed eliminazionista, oppure può essere quella che si vuole imporre in Europa da molti anni. Ma lei ha visto la violenza in una forma radicale, fatta di negazione e squalifica profonda:
Israele i palestinesi non li vede, non li ascolta e, cosa ancor più grave, non li «sente». Per la maggior parte degli israeliani che intervengono pubblicamente, ma anche per molti esponenti della diaspora ebraica, esiste una sola prospettiva: quella di Israele[3].
Chi è cosciente di questa situazione parla una lingua dal suono inconfondibile: «Nessuno è libero finché non sono liberi tutti»[4]. Non si arriva a queste consapevolezze senza una buona dose di autocritica. Per forza: i giuristi migliori sono quelli che decostruiscono il diritto, che ne mettono a nudo i pregiudizi, le stratificazioni prevaricanti. Non è un caso se quest’anno, nelle irruzioni dell’esercito all’Educational Bookshop, a Gerusalemme, fra i testi sequestrati c’era un libro di diritto scritto anche da lei[5]. Ma bastano, cultura e introspezione?
Proprio no. Bisogna incontrare la realtà faccia a faccia, sbatterci contro il muso, magari in un caffè con gli odori pesanti e i camerieri che sono ragazzi usciti dalle mani dei carcerieri israeliani. L’autrice discute con un palestinese, sottolinea il suo ruolo nell’Onu, e quello la smonta senza complimenti: «Non si è scomposto più di tanto; guardandomi dritto negli occhi, si è limitato a chiedermi: “Ma tu, che vuoi fare?”. Una domanda alla quale, a distanza di tanti anni, forse sto ancora cercando di rispondere»[6]. Evviva! Una giurista che si mette in discussione, che non sbandiera successi immaginari, che non si pavoneggia citando commi e paragrafi.
Quando si fanno queste sane docce fredde, si capisce molto di sé e dei colleghi. Anche l’impegno dalla parte degli oppressi può contribuire all’oppressione: è il «paradosso umanitario». Credi di aiutare e, senza saperlo o senza poterlo evitare, ogni cosa che fai sta già in un modello che lascia le cose come stanno, che consolida lo stato di fatto. Allo stesso tempo ti senti un benefattore, un bianco buono, mentre sei parte del problema che vuoi risolvere. Anche su questo, il modello praticato sui palestinesi estremizza la violenza. Ma il contributo funzionariale alla linea del colore è simile ovunque, anche in Italia: il giurista, il benefattore, l’attivista, il militante possono diventare parti del circuito che credono di spezzare.
E allora arriva l’impegno di Albanese in ogni direzione, per sfuggire ai pregiudizi e ai condizionamenti, per dare il meglio. Frequenta il popolo e gli intellettuali, legge e si documenta, entra in contatto con studiosi di mezzo mondo, approfondisce teorie d’avanguardia: ci mette di fronte alla politica verticale, allo spaziocidio, alla trasmissione intergenerazionale dei traumi.
Ma non trascura i dettagli, le cose. In quel caffè palestinese con gli odori forti torna sempre, per attingere alla fonte che ogni essere umano – il giurista più degli altri, con la sua tendenza automatica alle categorie e alle astrazioni – non deve abbandonare: la realtà. Lei la riassume così:
Israele e Palestina, uno è l’occupante e l’altro l’occupato, uno è il colonizzatore e l’altro il colonizzato, posto in una situazione di strutturale subalternità e vittima di un sistema di controllo e segregazione. No, questo non è un conflitto: al massimo può essere visto come un conflitto con l’umanità[7].
È bene, oltre alle persone, frequentare i luoghi: ma se fai le escursioni organizzate, vedi cosa ti fanno vedere e devi sorbirti versioni addomesticate della storia e dell’archeologia del Medio Oriente; invece località e rovine, anche quelle che le guide turistiche definiscono senza un margine di dubbio, sono interpretabili in vari modi. Tutto va approfondito: il Muro del pianto, per esempio, potrebbe non essere un muro del Secondo tempio di Gerusalemme; per alcuni, anzi, il Secondo tempio non sarebbe stato lì o non sarebbe mai esistito[8]. Così, lei supera il suo anticlericalismo e si affida a un prete, oltre che a un palestinese, per sentire l’altra campana e non solo le narrazioni che piacciono a Tel Aviv.
Instancabile, affamata di esperienze e di vita, Albanese ha capito che se in Palestina si vede un «conflitto» si inizia a leggere un libro da metà delle pagine, ignorando cosa c’è prima. Ecco, Quando il mondo dorme ci aiuta a cercare lì, è un libro che si porta dietro i capitoli mancanti nelle letture degli altri. Perché stupirsi? Nasce da un’idea che le ronzava in testa da anni: scrivere Polaroid da Gerusalemme, presentando la Palestina come l’ha vissuta, con curiosità culturale e attenzione giuridica insieme.
Pensiamoci: un libro che porta con sé l’altra metà della storia, cioè i mezzi libri che il mondo non legge, perché non può contenere l’ombra di se stesso, il libro non scritto? Forse è questo, il segreto di un lavoro riuscito.
[1] Francesca Albanese, Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina, Rizzoli, Milano 2025, p. 16.
[2] Ivi, p. 19.
[3] Ivi, p. 207.
[4] Ivi, pp. 240-241.
[5] Ivi, pp. 104-105. Si tratta di Francesca Albanese, Lex Takkenberg, Palestinian Refugees in International Law, Oxford University Press, Oxford, New York 2020.
[6] Albanese, Quando il mondo dorme, cit., p. 63.
[7] Ivi, p. 76.
[8] Ivi, p. 87.



