di Luca Cangianti
 Andrea Bottalico, La logistica in Italia. Merci, lavoro e conflitti, Carocci, 2025, pp. 120, € 14,00.
Andrea Bottalico, La logistica in Italia. Merci, lavoro e conflitti, Carocci, 2025, pp. 120, € 14,00.
Un mondo liscio, lubrificato, incanalato, senza conflitti, attrito e soluzioni di continuità. È questo il paradiso sognato dall’inconscio logistico: il panta rei, il tutto scorre della merce.
La logistica è costituita da tutte le attività necessarie da far giungere un prodotto ai clienti. Solo allora sarà merce, perché, come giustamente ricorda Karl Marx, il trasporto è parte integrante della produzione. La logistica in Italia, il nuovo saggio di Andrea Bottalico, illustra attraverso documenti d’archivio, interviste e osservazione partecipante, come questo settore industriale, che costituisce oltre l’8% del pil italiano, rappresenti la nuova frontiera avanzata del capitalismo contemporaneo. Le navi, i camion, le gru, i treni, gli aerei, i nastri trasportatori, i software e i robot utilizzati da multinazionali quali Amazon, Walmart, Ups, FedEx, Dhl, Tnt, Gls, Msc, non spostano meramente prodotti, ma scompongono e riassemblano continuamente processi produttivi agendo sul valore complessivo, sui tassi di profitto e sulla composizione della forza lavoro.
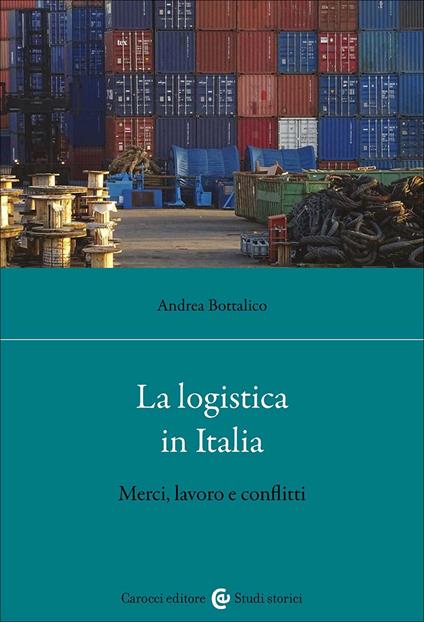 Nata con la scienza bellica, lo sviluppo delle infrastrutture e il mercato degli schiavi, la logistica, secondo l’autore, attraversa tre fasi principali. Nella prima, dagli anni cinquanta ai settanta del secolo scorso, siamo ancora a un livello da sussunzione meramente formale, con il trasporto ferroviario che cede progressivamente il passo a quello su gomma. La seconda fase, negli anni ottanta e novanta, è connotata dalla rivoluzione del container1: la centralità fordista della produzione viene scomposta e il trasporto diventa uno degli aspetti cruciali del processo di accumulazione. In questo modo si pone in essere il bisogno di nuovi porti, interporti, ferrovie, strade, ma anche di infrastrutture immateriali e sociali: «Se in passato il trasporto delle merci era costituito da un seguito di segmenti operati da vettori diversi», afferma Bottalico, «ora il container elimina la cosiddetta “rottura del carico”, trasformando il trasporto in un unico flusso ininterrotto e riducendo sia i tempi che i costi». Infine, nella terza fase in corso, l’autore individua i seguenti fattori principali: utilizzo dell’informatica e delle pratiche just in time, sviluppo dell’intermodalità, consolidamento della figura dello spedizioniere come organizzatore del trasporto integrato, frammentazione, esternalizzazione dei servizi logistici e di trasporto, subappalto e precarizzazione dei rapporti di lavoro.
Nata con la scienza bellica, lo sviluppo delle infrastrutture e il mercato degli schiavi, la logistica, secondo l’autore, attraversa tre fasi principali. Nella prima, dagli anni cinquanta ai settanta del secolo scorso, siamo ancora a un livello da sussunzione meramente formale, con il trasporto ferroviario che cede progressivamente il passo a quello su gomma. La seconda fase, negli anni ottanta e novanta, è connotata dalla rivoluzione del container1: la centralità fordista della produzione viene scomposta e il trasporto diventa uno degli aspetti cruciali del processo di accumulazione. In questo modo si pone in essere il bisogno di nuovi porti, interporti, ferrovie, strade, ma anche di infrastrutture immateriali e sociali: «Se in passato il trasporto delle merci era costituito da un seguito di segmenti operati da vettori diversi», afferma Bottalico, «ora il container elimina la cosiddetta “rottura del carico”, trasformando il trasporto in un unico flusso ininterrotto e riducendo sia i tempi che i costi». Infine, nella terza fase in corso, l’autore individua i seguenti fattori principali: utilizzo dell’informatica e delle pratiche just in time, sviluppo dell’intermodalità, consolidamento della figura dello spedizioniere come organizzatore del trasporto integrato, frammentazione, esternalizzazione dei servizi logistici e di trasporto, subappalto e precarizzazione dei rapporti di lavoro.
Stando a quanto emerge perfino da alcune ordinanze di tribunali, queste ultime due componenti nel modello logistico italiano raggiungono livelli parossistici mediante l’utilizzo spesso fraudolento di cooperative, lavoro nero, evasione fiscale e contributiva. Si inserirebbero in questo contesto le morti per investimento del lavoratore egiziano Abd Elsalam Ahmed Eldanf nel 2016 e del lavoratore marocchino Adil Belakhdim nel 2021, nonché vari raid punitivi ai danni di altri lavoratori. D’altro canto, mentre il sindacato confederale legato al mondo delle cooperative non ha saputo guadagnarsi la rappresentanza della forza lavoro migrante del comparto, emergono nuove forme di lotta radicale che hanno conseguito vittorie contrattuali e miglioramenti delle condizioni lavorative.
Il sogno capitalista dell’inarrestabile fluire non riesce a prescindere dalla rugosità operaia – una contraddizione che il saggio di Bottalico mette bene in luce, con equilibrio sociologico, ma senza ossificare un presente privo di dinamica e di speranze.



