di Fabio Ciabatti
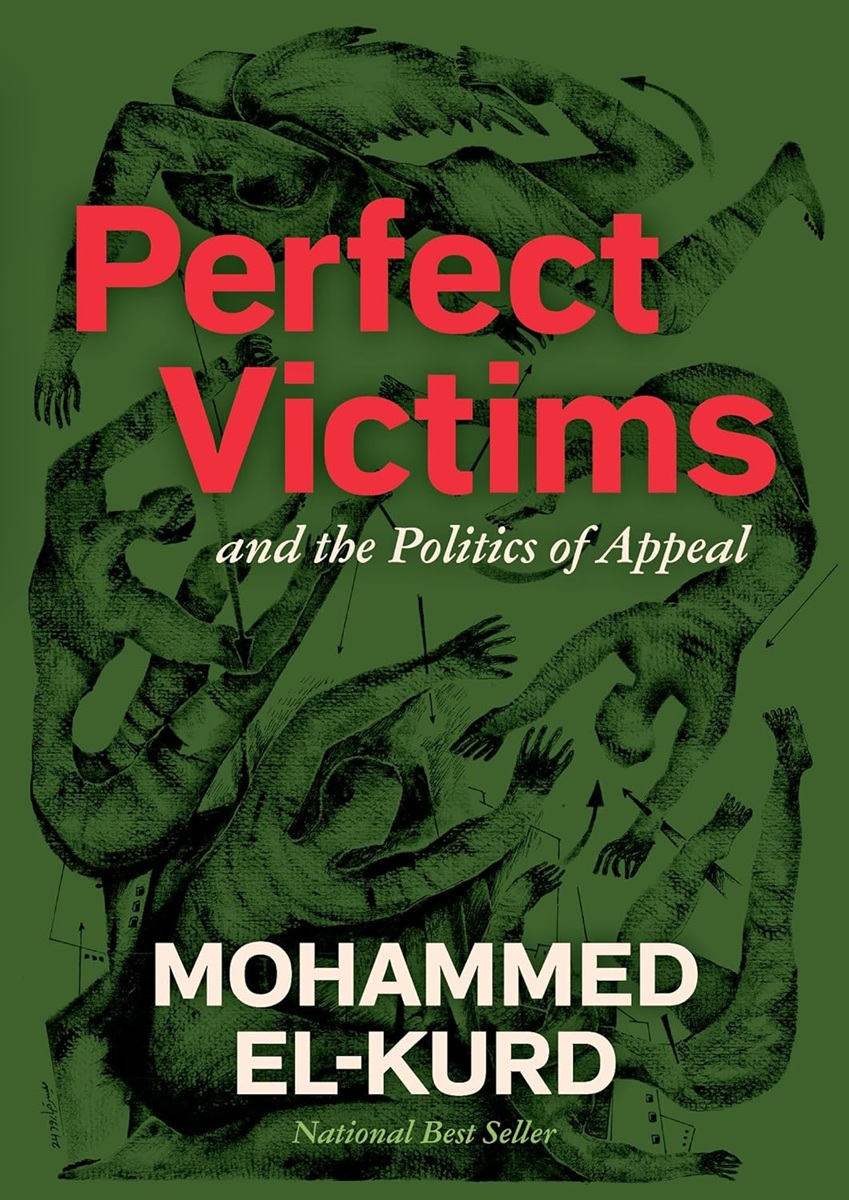 Mohammed El-Kurd, Perfect Victims And The Policy of Appeal, Haymarket Books, Chicago 2025, pp. 256, € 15,43 (traduzione italiana in corso di pubblicazione, Vittime perfette e la politica del gradimento, Fandango Libri, Roma 2025, pp. 288, € 19,00).
Mohammed El-Kurd, Perfect Victims And The Policy of Appeal, Haymarket Books, Chicago 2025, pp. 256, € 15,43 (traduzione italiana in corso di pubblicazione, Vittime perfette e la politica del gradimento, Fandango Libri, Roma 2025, pp. 288, € 19,00).
Secondo la narrazione mainstream occidentale, compresa quella progressista, i palestinesi sono intrappolati in una falsa e rigida dicotomia: o sono terroristi o sono vittime. Mai e poi mai possono essere i protagonisti, gli eroi della loro storia. O sono i villains, i nemici cattivi del racconto, o sono coloro che, inermi, vengono colpiti da un nemico innominabile e invisibile. Invisibile, si potrebbe anche aggiungere, perché celato nelle pieghe della loro stessa interiorità dal momento che, in fin dei conti, i palestinesi, per loro natura irragionevoli e bellicosi, sono i veri nemici di se stessi, la causa ultima del male che li affligge e perciò, come recita il vecchio adagio, destinati a piangere se stessi.
Questa costruzione narrativa viene denunciata come palesemente assurda da Mohammed El-Kurd, poeta1 e corrispondente per la rivista statunitense The Nation. Lo scrittore, nato a Gerusalemme, ha dato alle stampe Perfect Victims And The Policy of Appeal,2 un pamphlet corrosivo e irriverente non certo per amore dello scalpore in sé, ma per la dichiarata volontà di rompere la gabbia ideologica in cui è condannata a girare a vuoto, come un criceto nella ruota, chiunque voglia supportare la causa palestinese senza liberarsi dalla narrazione dominante sul “conflitto” originato dalla colonizzazione sionista. Una gabbia confermata ulteriormente dalla perentoria ingiunzione a condannare l’attacco di Hamas del 7 ottobre ignorando bellamente tutta la sequela di orrori e ingiustizie cui sono stati sottoposti i palestinesi prima di quella data. Denigrare la violenza degli oppressi mentre si chiudono gli occhi di fronte alla violenza dell’oppressore, sostiene l’autore, non significa altro che sottomettersi alla logica coloniale e sostenere lo status quo.
Tornando alla dicotomia con cui abbiamo cominciato, i palestinesi che sono etichettati come terroristi non hanno mai l’opportunità di parlare per sé stessi e raramente sono oggetto di una qualche attenta considerazione. Sono creature quasi mitiche, puro e semplice materiale per storie spaventose, che non meritano neanche il dolore dei loro cari quando muoiono. Istinti fondamentali, come quello di sopravvivenza o di autodifesa, diventano un lusso per i palestinesi. Ciò che viene considerata una reazione naturale per una qualsiasi persona di fronte all’oppressione diventa un comportamento primordiale e incomprensibile nel loro caso. Ciò che rende alcune persone degli eroi fa dei palestinesi dei criminali: mentre la resistenza ucraina è glorificata per le sue tattiche di guerriglia, quella palestinese è considerata sconcertante, perversa e patologica. Poco importa se il presunto terrorista debba affrontare la sua personale Nakba ogni volta che viene perquisito per strada o picchiato con il calcio del fucile in un checkpoint. È irrilevante se ogni sfollamento, ogni demolizione e ogni funerale prematuro getti altra benzina sul fuoco della sua rabbia.
Tutto questo è trascurabile, denuncia El-Kurd. I palestinesi che resistono all’occupazione sionista sono dei terroristi e, in quanto tali, sono espulsi dalla condizione umana. Per guadagnarsi il diritto ad essere accolti nel consesso umano devono essere resi innocui. Devono dimostrare la loro innocenza. In breve, devono comprovare il loro status di vittime adeguandosi ad alcuni stringenti parametri. Per esempio, devono essere feriti e deboli: troppo feriti per combattere e troppo deboli anche per avere un’espressione corrucciata. Nella categoria di vittime rientrano le vedove il cui dolore è così inspiegabile da non poter essere contestualizzato o gli orfani i cui genitori assassinati non meritano neanche la menzione della “causa della morte” nei loro necrologi. E, più in generale, ci rientrano tutti coloro le cui grida angosciate esistono al di fuori della storia e della politica, le cui ferite possono essere descritte senza riportare alcun colpevole.
Le vittime alle volte sono invitate a parlare, ma devono narrare solo le loro tragedie personali. La loro protesta deve rimanere strettamente individuale. Non può essere mai collegata a una causa comune o portata avanti attraverso un collettivo organizzato. Le vittime non possono avere un’agency politica, per non parlare di una capacità militare. Si dà voce alla loro flebile protesta soltanto per cercare di porre rimedio a una crisi umanitaria, trattata alla stregua di un evento naturale come un terremoto.
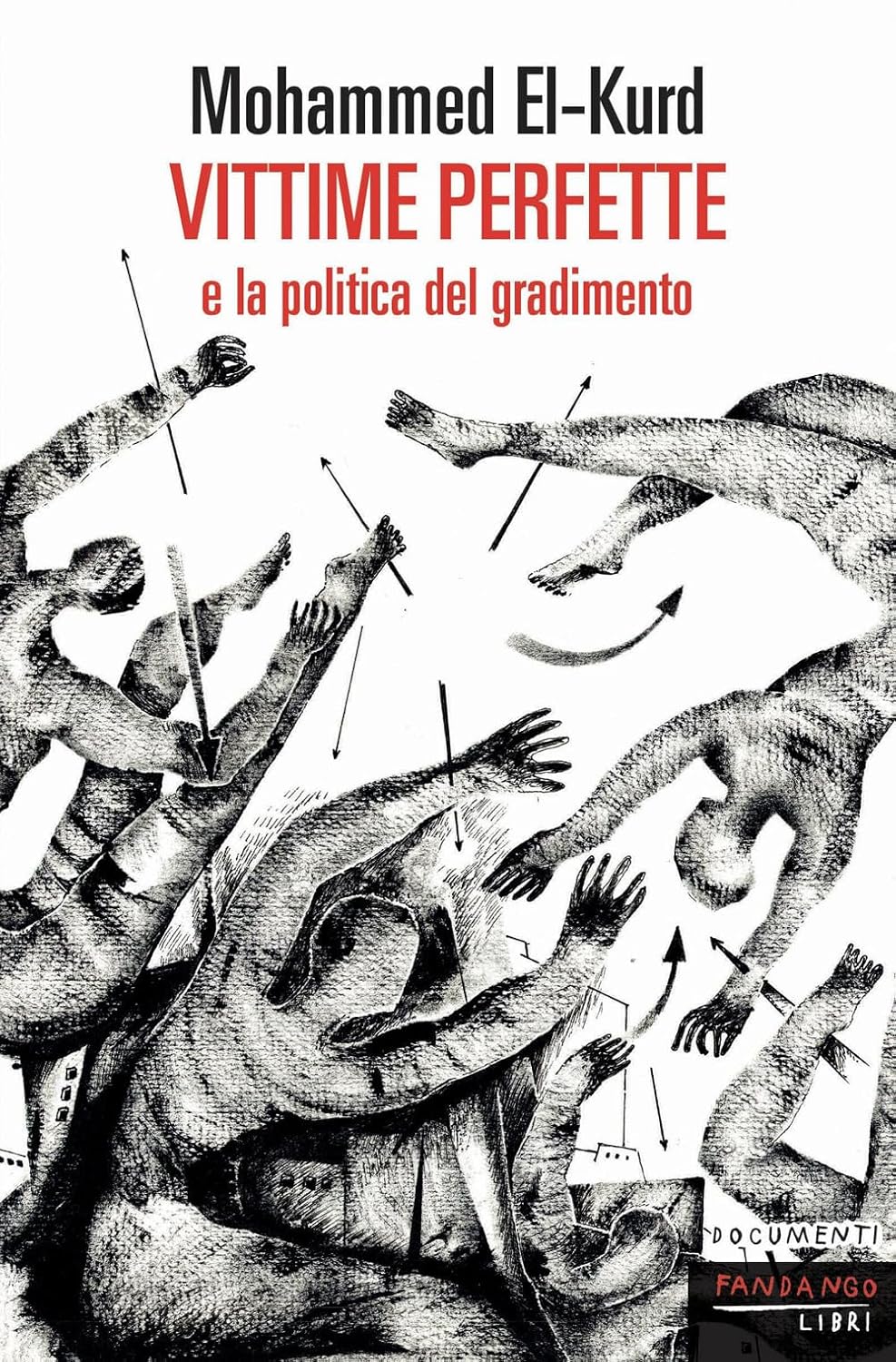 La risposta all’accusa di terrorismo è stata quella che El-Kurd definisce la politica dell’appeal,3 una pratica che utilizza una serie di tattiche creative per promuovere la causa palestinese, cercando incessantemente di soddisfare i requisiti sopra menzionati. Nella migliore delle ipotesi si tratta di una serie di scaltri tentativi di superare in astuzia il sistema, di batterlo al suo stesso gioco. Nella peggiore di una strategia strettamente riformista per alterare lo status quo, mai per demolirlo del tutto. Perché, in questa ottica, il potere è una struttura indistruttibile, scolpita nella pietra.
La risposta all’accusa di terrorismo è stata quella che El-Kurd definisce la politica dell’appeal,3 una pratica che utilizza una serie di tattiche creative per promuovere la causa palestinese, cercando incessantemente di soddisfare i requisiti sopra menzionati. Nella migliore delle ipotesi si tratta di una serie di scaltri tentativi di superare in astuzia il sistema, di batterlo al suo stesso gioco. Nella peggiore di una strategia strettamente riformista per alterare lo status quo, mai per demolirlo del tutto. Perché, in questa ottica, il potere è una struttura indistruttibile, scolpita nella pietra.
La politica dell’appeal ha come obiettivo l’umanizzazione dei palestinesi. L’umanizzazione, però, sposta l’attenzione critica dal colonizzatore al colonizzato, oscurando l’ingiustizia intrinseca del colonialismo. Non è il colonizzatore che deve giustificarsi per le sue politiche oppressive, ma il colonizzato che deve dimostrare di essere degno della libertà che gli viene negata. E c’è di peggio. La politica dell’appeal porta una interiorizzazione da parte dei palestinesi del modo in cui vengono percepiti dagli altri. Essi si sentono costretti a giustificare la loro stessa esistenza. Sentono la necessità di rispondere in modo preventivo alle accuse che hanno introiettato prima di fare qualsiasi affermazione. Sempre sulla difensiva si autodefiniscono in primo luogo per negazione: non siamo terroristi, antisemiti, violenti ecc.
I palestinesi sanno che devono essere educati nella loro sofferenza perché ogni affermazione sgarbata danneggia le proprie rivendicazioni. Sanno che la violenza inflitta alle loro terre e ai loro corpi deve passare in secondo piano rispetto alle macchie che offuscano la loro immagine. Sin da bambini hanno interiorizzato la museruola. Essere palestinesi significa oggi essere intrappolati nelle allucinazioni di un altro. Significa essere interrogati sulle intenzioni genocide nascoste nei loro slogan (come nel caso del famigerato From the river to the see Palestine will be free), mentre i politici israeliani si vantano esplicitamente sui giornali della pulizia etnica.
Nel discorso dominante, le armi della retorica in mano dei palestinesi appaiono più letali delle armi vere e proprie che l’esercito israeliano ha a disposizione in gran quantità. Per questo il linguaggio diventa un campo minato. Una parola sbagliata, se pronunciata da un palestinese, ha il potere magico di far scomparire tutti gli oggetti reali: gli stivali che li calpestano, i proiettili che li trafiggono, i manganelli che li percuotono e i lividi che sono impressi sui loro corpi. La loro presunta violenza semantica è in grado di far svanire decadi di violenza sistematica e materiale praticata dall’autoproclamato stato ebraico. Rispettare le regole di un discorso politicamente corretto per i palestinesi diventa un esercizio funambolico. Un esercizio che sembra riguardarli tutti allo stesso modo, ma che nei fatti esclude chi non ha la formazione e le risorse necessarie per evadere dalla categoria dei disumanizzati. Esclude, cioè, i poveri e gli emarginati, i rifugiati e gli assediati, quelli che sono destinati a sopportare il peso maggiore del sionismo. L’umanizzazione, se non è direttamente al servizio di interessi di classe, è certamente complice di una visione del mondo classista, sostiene l’autore.
Bisogna invece essere fedeli alle strade palestinesi, afferma Mohammed El-Kurd, consapevole del rischio di scivolare con questa affermazione nel populismo o nelle politiche identitarie. Rischi che possono essere superati se questa fedeltà significa un impegno verso un analisi materiale della questione palestinese. Un impegno capace di fare tesoro dell’esperienza e della conoscenza delle persone in carne e ossa che sono messe ai margini dai mass media occidentali nonostante i loro corpi massacrati siano la materia prima per confezionare i loro notiziari e articoli. Fedeltà alle strade significa anche creare una pratica radicata nella dignità che non non cerchi di convincere il macellaio a mollare il suo coltello, ma provi a raccontare storie in cui i palestinesi sono i veri protagonisti e non mero oggetto della narrazione, qualsiasi cosa ne pensi l’audience straniera.
Alle orecchie del pubblico occidentale, infatti, i palestinesi che parlano degli orrori propri dell’ideologia sionista sono, nel migliore dei casi, dei passionari, nel peggiore, persone rabbiose e piene di odio. Ma in realtà sono soltanto dei narratori credibili. O, quantomeno, più credibili dei loro carnefici perché, come la storia ci insegna, coloro che hanno istituzionalizzato e monopolizzato la violenza non dicono mai la verità. Per aggirare questa presunta mancanza di credibilità, spesso si privilegiano quelle che l’autore definisce sarcasticamente le epifanie miracolose: le inaspettate rivelazioni sulle pratiche criminali dei sionisti provenienti da voci non palestinesi, siamo esse israeliane, ebraiche, americane o occidentali. Questa strategia, però, finisce per consolidare il pregiudizio che le voci palestinesi sono sempre sospette o scadenti. Per evadere dall’opprimente sguardo coloniale occorre invece che i palestinesi prendano la parola in prima persona, raccontandosi l’un l’altro la propria storia smettendo aprir bocca esclusivamente per rispondere al biasimo dei colonizzatori e dei loro alleati.
Questo biasimo può attingere a un vasto campionario. Per esempio ai palestinesi, compreso l’autore, viene spesso chiesto se, con le loro rivendicazioni nazionali, vogliono gettare in mare tutti gli israeliani. O meglio, gli chiedono perché lo vogliono fare, dando per scontata l’intenzione genocidaria. La parola “vogliono”, sottolinea El-Kurd, è quella che rivela in modo più chiaro la logica coloniale: il solo fatto di fantasticare una vendetta va a inficiare la rivendicazione di giustizia palestinese. Soltanto immaginare una terra senza coloni, un cielo senza droni, delle strade senza checkpoint e perquisizioni equivale a pensare un genocidio nell’immaginazione sionista. Eppure, sono solo i sionisti ad avere il potere di realizzare le loro fantasie, le loro favole e la loro teologia. E lo fanno ininterrottamente da molti decenni intrappolando i palestinesi in un eterno presente che rinnova ogni giorno la loro Nakba. Quelli che si preoccupano del destino dei coloni non hanno pensato neanche una volta al destino di sei milioni di rifugiati palestinesi che agonizzano in esilio. L’ipotetico futuro dei coloni viene prima del presente materiale che è già marchiato dallo sterminio.
E che dire dell’esplicita accusa di antisemitismo? L’autore affronta la questione senza assumere un atteggiamento difensivo. Al contrario, il suo ragionamento si fa apertamente provocatorio: se, dopo aver visto i suoi cari uccisi a sangue freddo dai soldati vestiti con la stella di Davide dell’autoproclamato stato ebraico, un palestinese cominciasse a odiare ossessivamente e irrazionalmente tutti gli ebrei, questo velenoso sentimento pregiudicherebbe forse il suo status di vittima? Giustificherebbe forse i crimini dei militari sionisti? Difendersi in continuazione dall’infondata accusa di antisemitismo finisce per elevare le vicende passate della sofferenza degli ebrei, una storia ininterrottamente studiata se non onorata, al di sopra della presente sofferenza dei palestinesi che è invece una storia negata e contestata nonostante sia continuamente trasmessa per televisione. Nel situare l’Olocausto al di fuori del tempo, il sionismo dà precedenza alla possibilità di un secondo Olocausto degli ebrei rispetto allo sterminio dei palestinesi che sta avvenendo proprio in questo momento. Perché, in questo momento, solo una delle parti in questo “conflitto” è attivamente impegnata nell’intenzionale e sistematico tentativo di estirpare un’intera popolazione dalla sua terra.
La propaganda filosionista è dunque palesemente illogica. Ma questo è proprio il suo punto di forza perché essa può così funzionare come una distrazione rispetto al problema reale: il colonialismo, l’assedio, l’occupazione militare. La sua assurdità fa pensare ai palestinesi che possa essere combattuta con argomentazioni logiche in grado di ripulire il loro nome da false accuse. Occorre invece accusare gli accusatori, smascherando la loro disonestà e la loro doppiezza. E un modo per farlo, sostiene El-Kurd, è quello di ridicolizzare il tribunale che li vuole mettere sul banco degli imputati per il solo fatto di esistere. L’irriverenza è un atto di dignitoso rifiuto che può contribuire a liberare la mente di coloro che sono assediati o incarcerati. Il sarcasmo costruisce un realtà alternativa in cui l’occupazione non è inscalfibile e gli occupanti non sono indistruttibili. La derisione è una forma di autopreservazione e di sfida, un ostinato rifiuto della soggezione psicologica. Mentre il riso rende le loro ferite un po’ meno dolorose, i palestinesi potrebbero scoprire che il sionismo, dietro la sua facciata di formidabile superpotenza, oggi è più vulnerabile di quanto voglia far apparire.
In conclusione, non sarà un appello alla morale dominante che potrà salvare i palestinesi perché essa si fonda su un universalismo dai connotati capitalistici e commerciali che può tranquillamente sorvolare sul potere, sulla storia e sul filo spinato. Per combattere i colonizzatori sionisti e i loro alleati occidentale, sostiene l’autore, è necessario fare appello a una differente forma di universalismo
che riconosca che la condizione palestinese è la condizione umana. La Palestina è un microcosmo del mondo: miserabile, furiosa, inquieta e frammentata. In fiamme. Testarda. Inammissibile. Dignitosa. La prospettiva che adottiamo nei confronti del palestinese rivela come ci guardiamo l’un l’altro, come vediamo tutto il resto.4
La sua prima raccolta di poesie, intitolata Rifqa è stata pubblicata anche in italiano da Fandango Libri nel 2022. ↩
Mentre chiudevo l’articolo ho appreso con piacere che a settembre verrà pubblicata in italiano per Fandango Libri la traduzione del libro qui recensito, con il titolo Vittime perfette e la politica del gradimento. ↩
Il testo italiano in corso di pubblicazione traduce “politics of appeal” con “politica del gradimento”. Preferisco confermare l’espressione “politica dell’appeal”, che avevo utilizzato prima di vedere il titolo italiano, perché mi pare mantenga il senso di “politica del gradimento”, alludendo al tempo stesso una seconda possibile sfumatura di significato, quella cioè di politica dell’appello, intesa come invocazione a un’autorità esterna. ↩
Mohammed El-Kurd, Perfect Victims And The Policy of Appeal, Haymarket Books, Chicago 2025, p 27, ed. Kindle, traduzione mia. ↩



