di Luca Cangianti
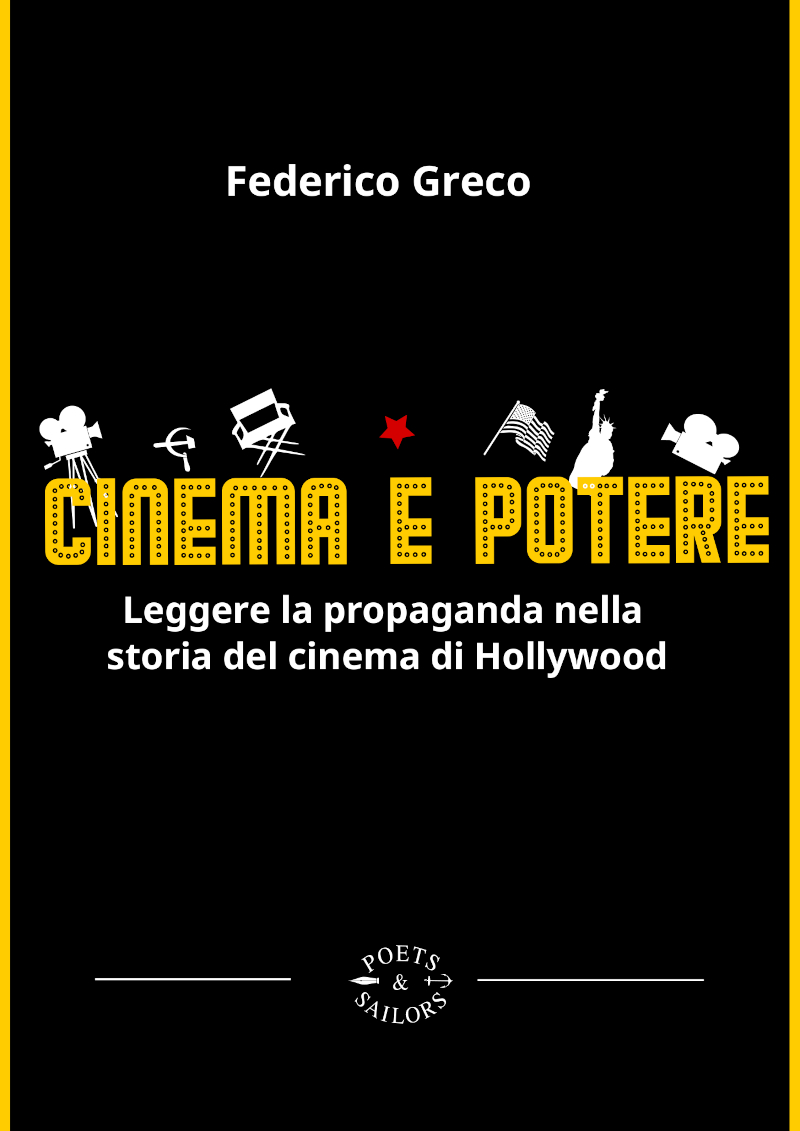 Federico Greco, Cinema e Potere. Leggere la propaganda nella storia del cinema di Hollywood, Poets & Sailors, 2025, pp. 276, € 16,00.
Federico Greco, Cinema e Potere. Leggere la propaganda nella storia del cinema di Hollywood, Poets & Sailors, 2025, pp. 276, € 16,00.
Valerio Evangelisti sosteneva che l’immaginario è un campo di battaglia: le forze dello status quo fanno di tutto per conquistarlo, mentre quelle della ribellione cercano di sabotarne la colonizzazione. L’immaginario affonda le proprie radici nell’inconscio collettivo, nel mito, e si manifesta nella musica, nella pittura, nella letteratura, nel cinema e nei videogiochi. Non è quindi un caso che il film-maker Federico Greco (Il mistero di Lovercraft, Piigs, C’era una volta in Italia, alcune delle sue opere) apra il saggio Cinema e potere con un’affermazione di Elmer Davis, direttore dell’Ufficio per l’informazione bellica degli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale: «Il modo più semplice per iniettare un’idea propagandistica nella mente della maggior parte delle persone è farla passare attraverso un film di intrattenimento, quando non si rendono conto di essere oggetto di propaganda».
Il libro è una trascrizione rivista e approfondita delle prime undici puntate della seguitissima rubrica Desaparecinema che Greco cura per OttolinaTV. Si tratta di un’operazione di controegemonia che analizza e decostruisce pellicole famosissime o mai arrivate in sala. Si va dalle distopie L’uomo che fuggì dal futuro (1971), Soylent Green (1973) e Zardoz (1974 – film adorato da Evangelisti, dicasi per inciso), che descrivono sotto metafora i meccanismi del capitalismo contemporaneo, a pellicole mai distribuite come Il giorno in cui il clown pianse di Jerry Lewis. Scorrendo le pagine veniamo a sapere molti retroscena politici dell’industria hollywoodiana e perfino che il padre di Paperino e Topolino è stato un informatore segreto dell’Fbi. Tuttavia Greco non compila una lista dei “buoni” e dei “cattivi”: «Il cinema dei grandi registi rimane grande cinema anche se quei registi lo hanno fatto per imporre ideologie e propaganda. Rimane cinema quello di John Ford, che era contiguo alla Cia; rimane cinema quello di Chaplin, comunista convinto; rimane cinema quello di Stanley Kubrick, cui di fascismo e antifascismo non importava nulla.» Ciò che è imprescindibile è decodificare cosa vediamo, altrimenti siamo destinati a rimanerne vittime inconsapevoli: «guardiamo i film che vogliamo, anche la Cortellesi (no, Veltroni no), ma almeno cerchiamo ogni volta di capire cosa e chi c’è dietro. Quale idea di mondo propongono. Il cinema è ancora un’arma potente e tocca difenderci, se non vogliamo diventare, o rimanere, zombie analfoliberali. Mettiamola in un altro modo: vedetevi pure i film di merda che vi pare ma poi non lamentatevi se in cabina elettorale la matita va da sola». E già, Greco ha le sue idiosincrasie e quando sente parlare di sinistra meanstream mette la mano sulla pistola. Ma chi siamo noi per giudicare?



