di Gioacchino Toni
 Vanni Codeluppi, a cura di, Forme estetiche e società ipermoderna, Meltemi, Milano 2024, pp. 184, € 18,00
Vanni Codeluppi, a cura di, Forme estetiche e società ipermoderna, Meltemi, Milano 2024, pp. 184, € 18,00
A mezzo secolo di distanza dall’uscita del volume di Alberto Abruzzese Arte e pubblico nell’età del capitalismo. Forme estetiche e società di massa (Marsilio 1973) – più noto con il titolo che ha assunto a partire dalla seconda edizione: Forme estetiche e società di massa –, un testo indubbiamente capace di suscitare interesse per le tematiche trattate e per l’approccio proposto, alcuni studiosi hanno voluto confrontarsi con esso alla luce dei cambiamenti intercorsi nella natura e nel funzionamento delle forme estetiche nel passaggio dalla società di massa indagata da Abruzzese nei primi anni Settanta del secolo scorso all’attuale società ipermoderna digitalizzata.
In apertura del volume curato da Vanni Codeluppi, Giovanni Ragone ricostruisce i passaggi fondamentali del libro di Abruzzese evidenziando i riferimenti teorici principali su cui lo studioso costruisce le sue riflessioni riprendendo, dialogando o distanziandosi da autori come Alberto Asor Rosa, all’epoca direttore di “Contropiano”, Benjamin di Angelus Novus e, più in generale, con Tronti di Operai e capitale, i francofortesi e Marx dei Grundrisse, contribuendo alla lenta assimilazione in Italia di Morin, McLuhan e dei cultural studies anglosassoni.
Ragone si sofferma anche sulla parte finale del libro di Abruzzese, ove quest’ultimo affronta il cinema analizzando film come King Kong (1933) di Ernest B. Schoedsack e Merian C. Cooper alla luce della capacità hollywoodiana di rimediazione dei linguaggi artistici. A partire da ciò, Ragone si proietta nell’era digitale evidenziando come se da un lato questa si caratterizza per «la rifunzionalizzazione dell’arte in design, la merce-opera come bene rifugio della ristretta élite globale dominante», dall’altro permette un inedito «ampliamento delle possibilità per il soggetto in rete, che può riaprire il confronto con forme estetiche non seriali, proprio in quanto iper-spettatore competente sullo spettacolo seriale».
Nello Barile confronta le innovazioni comunicative proprie dell’esordio della modernità industriale con quelle dell’epoca del metaverso e/o della cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale concentrandosi soprattutto sulle componenti esperienziali. Riprendendo le riflessioni di Abruzzese prodotte nei primi anni Settanta, lo studioso affronta i nuovi ambienti mediali a vocazione empatica.
Gli studi recenti sulla cosiddetta Intelligenza Artificiale Emozionale, ovvero sui media empatici, ripropongono tipi sociali che hanno contrassegnato gli albori dell’esperienza metropolitana, come il concetto benjaminiano di flâneur. Si tratta di un flâneur “aumentato”, che attraversa ed è in qualche modo attraversato non solo dallo spazio urbano e da quello digitale, ma dall’interazione tra i due che oggi assume la forma di quello spazio ontologico integrato che gli esperti di marketing chiamano “phygital”. Il paradosso della nostra epoca è dato dal fatto che l’incredibile sviluppo della tecnica non sacrifica la sfera emotiva, anzi, la sollecita, la amplifica, la rende onnipresente. Tutto oggi trasuda questa alta densità emotiva, dal design, agli spazi commerciali, alle campagne di comunicazione. […] Incarnando l’artificio, o l’illusione dell’empatia, [l’intelligenza artificiale] potrà sostituire non solo il lavoro pesante e ripetitivo della vecchia società industriale ma anche quello più teorico e creativo della fase postindustriale.
 Se nel passaggio tra Otto-Novecento si assiste a un contenimento della divaricazione socioeconomica tra le classi sociali, oggi, nell’ambito della Quarta Rivoluzione industriale, scrive Barile, la forbice sembra allargarsi nonostante le sue promesse mirabolanti. «[Mentre] la deglobalizzazione spacca l’economia globale erodendo ulteriormente la centralità dei ceti medi, dall’altro il metaverso si offre come nuova utopia globalista, direttamente derivata dall’ideologia californiana, in cui chiunque può essere qualsiasi cosa e ovunque senza enormi sforzi economici». Pertanto, le forme estetiche nella società demassificata risultano «ritagliate sulle caratteristiche idrografiche dei singoli utenti che mettono a deposizione enormi quantità di dati – generati nell’interazione quotidiana – per partecipare all’immane spettacolo (o postspettacolo) gestito da un numero limitato di piattaforme globali».
Se nel passaggio tra Otto-Novecento si assiste a un contenimento della divaricazione socioeconomica tra le classi sociali, oggi, nell’ambito della Quarta Rivoluzione industriale, scrive Barile, la forbice sembra allargarsi nonostante le sue promesse mirabolanti. «[Mentre] la deglobalizzazione spacca l’economia globale erodendo ulteriormente la centralità dei ceti medi, dall’altro il metaverso si offre come nuova utopia globalista, direttamente derivata dall’ideologia californiana, in cui chiunque può essere qualsiasi cosa e ovunque senza enormi sforzi economici». Pertanto, le forme estetiche nella società demassificata risultano «ritagliate sulle caratteristiche idrografiche dei singoli utenti che mettono a deposizione enormi quantità di dati – generati nell’interazione quotidiana – per partecipare all’immane spettacolo (o postspettacolo) gestito da un numero limitato di piattaforme globali».
Giovanni Boccia Artieri si concentra sulle caratteristiche, soprattutto esperienziali, proprie dell’informazione nell’era digitale, soffermandosi su come l’estetica del frammento rappresenti a suo avviso «sia un genere proprio, sia una forma comunicativa espressiva e identitaria, funzionale ad abitare gli spazi digitali e le relazioni, sia una subcultura, anche se non pare tanto costituire una via per la costruzione di identità collettive quanto una pratica di identificazione e di presentazione di sé e una sorta di spazio culturale socialmente condiviso capaci di fungere da orizzonte di senso per collocare la propria esperienza».
Sergio Brancato mette in evidenza come al centro Forme estetiche e società di massa vi siano «le tematiche del corpo nelle sue relazioni mutevoli con l’affermazione di una tecnologia, quella industriale, che rende leggibili nelle forme dell’immaginario collettivo le trasformazioni di sistema riguardanti la vita quotidiana nell’età delle masse», questioni che Abruzzese svilupperà poi nel volume La Grande Scimmia (1979) e, ulteriormente ne Il corpo elettronico (1988). A spiegare la fortuna longeva del libro del 1973, sostiene Brancato, è il fatto che tra le sue pagine vi si possa scorge, «per dirla à la Cronenberg, la “nuova carne” che rinegozia l’interazione della specie con la sfera della tecnica».
Fulvio Carmagnola invita a guardare all’immaginario contemporaneo «come uno specifico modo di uso e produzione dei simboli che ne cambia la funzione. Un uso prescrittivo o almeno seduttivo, una potenza sociale anonima che “ci dice come dobbiamo desiderare”», mentre il curatore del volume, Vanni Codeluppi, riprendendo le riflessioni di Abruzzese sui contesti metropolitani, si confronta con il ricorso sempre più massiccio alla sfera estetica da parte delle imprese in un universo occidentale ipermoderno sempre più caratterizzato da un moltiplicarsi di simulacri con il conseguente tramonto della realtà. Un universo in cui per timore di affrontare esperienze reali, o per non correre il rischio di restare da esse delusi, si finisce per accontentarsi dell’illusoria perfezione proposta sugli schermi. Della ricostruzione dell’immaginario che ha prodotto Forme estetiche e società di massa nei primi anni Settanta si interessa invece Stefano Cristante evidenziando come il suo autore si distanzi e venga distanziato dall’ortodossia dell’allora suo universo politico di riferimento.
«Dichiaratamente indisciplinato, coinvolto, militante. Autobiografico. Forme estetiche e società di massa, nell’analizzare l’interscambio circolare tra le diverse forme espressive che generano il pubblico apre le porte in Italia, agli inizi degli anni Settanta, all’inquietudine per la disciplina». Così Giovanni Fiorentino e Mario Pireddu tratteggiano efficacemente il testo di Abruzzese collegandolo a quanto stava portando avanti sul finire degli anni Sessanta il Centre for Contemporary Cultural Studies dell’Università di Birmingham, nel suo affrontare la cultura popolare, i media, le arti visive, le mode e le sottoculture giovanili in maniera inedita, facendo saltare le frontiere tra l’alto e il basso della cultura nelle sue più diverse declinazioni.
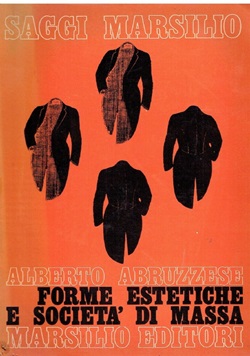 Dopo aver ricostruito l’humus culturale di cui si trova traccia nel lavoro di Abruzzese, i due studiosi ripensano alle tante questioni da lui sollevate alla luce di un’attualità in cui la rivoluzione digitale tecnomediale ha modificato il rapporto con le immagini, gli schermi e la realtà. Cambiamento del resto percepito nei primi anni Settanta dallo stesso autore di Forme estetiche e società di massa che, infatti, si chiude affermando: «è abbastanza significativo notare quanto le ricerche di informatica sui mezzi audiovisivi, pur riferendosi all’oggetto realizzato per interpretarlo [lo spettacolo], finiscano per fornire piuttosto prefigurazioni di oggetti futuri».
Dopo aver ricostruito l’humus culturale di cui si trova traccia nel lavoro di Abruzzese, i due studiosi ripensano alle tante questioni da lui sollevate alla luce di un’attualità in cui la rivoluzione digitale tecnomediale ha modificato il rapporto con le immagini, gli schermi e la realtà. Cambiamento del resto percepito nei primi anni Settanta dallo stesso autore di Forme estetiche e società di massa che, infatti, si chiude affermando: «è abbastanza significativo notare quanto le ricerche di informatica sui mezzi audiovisivi, pur riferendosi all’oggetto realizzato per interpretarlo [lo spettacolo], finiscano per fornire piuttosto prefigurazioni di oggetti futuri».
Gino Frezza evidenzia come il saggio di Abruzzese affronti il cinema all’interno di un ragionamento più ampio imperniato attorno alle relazioni fra processi della cultura e della politica, convinto che «gli assetti della cultura del secondo Novecento» siano radicati «in processi di lunga ondata, risalenti (almeno) a come, nella società moderna di metà Ottocento, si sono disposte le Esposizioni Universali, attorno al nodo fra arte e merce, consumi e forme di vita, identità e comunità, formazione delle città e comunicazione, ecc».
Nell’esaminare alcune pellicole hollywoodiane, «Abruzzese riconosce i percorsi fondativi che hanno costituito, nei decenni addietro, la società dello spettacolo cinematografico. Ne coglie gli intrecci decisivi fra produzione di immagini e forme rappresentative capaci di delineare le direzioni di marcia della società moderna». Nonostante la presenza di «qualche scatto d’intelligenza sul futuro», sottolinea Frezza, quel che manca in quel libro è una comprensione altrettanto profonda dell’universo televisivo, sul quale lo studioso non manca però di tornare in scritti successivi.
Dopo aver ricostruito il modo con cui Forme estetiche ha saputo cogliere la modernità a partire dall’analisi della metropoli e delle esposizioni universali, Antonio Rafele ragiona sull’attualità del libro «in riferimento al dominio quotidiano delle vetrine, delle immagini e dello choc». Metropoli, cinema e televisione rappresentano «il cuore della riflessione di Alberto Abruzzese sulla comunicazione moderna, a partire da Forme estetiche e società di massa (1973) fino a Lo splendore della TV (1995)»; ad interessare lo studioso, scrive Tito Vagni, è il «modo in cui si configura e riconfigura incessantemente la percezione e, quindi, all’instabilità dell’io».
La chiusura del volume curato da Codeluppi è lasciata a uno scritto dello stesso Alberto Abruzzese in cui ripensa, a distanza di tanto tempo, al libro ricordando come tra gli obiettivi che si proponeva in quei primi anni Settanta ci fosse anche
l’intento politico di scuotere la cultura progressista di marca “comunista” dal suo torpore e ostilità nei confronti della cultura di massa. Dunque di quanti in quelle forme di vita vissuta realmente nascevano e abitavano. Spettatori – quindi – e non classi o soggetti politici. Passioni e non ideologie. Miti e non razionalità strumentali. Schermi e non realtà. Persone. (Questa fu la via di una deviazione necessaria dalle teorie sociologiche di stretta osservanza verso una mediologia sperimentale).
Il ragionamento che mi animava – influenzato da letture e visioni, fonti, che potessero aiutarmi a dargli corpo ed efficacia – consisteva dunque in una teoria critica delle origini dei media contemporanei in grado di fornire strumenti innovativi alla politica. Al “che fare”. Ragione per cui buona parte di Forme estetiche e società di massa è stata da me pensata e scritta dentro una esperienza intellettuale (aliena a quella amatoriale) che in massima se non esclusiva parte aveva al suo cuore – anche se contraddittoriamente – la figura carismatica di Mario Tronti. E quindi la sua opera fondamentale: Operai e capitale.
A distanza di tempo, conclude Abruzzese, in quel Forme estetiche e società di massa – così come, del resto, nella ricerca e nei testi che sarebbero seguiti – si può dire che il “tema dominante” sia individuabile nella «persona costretta alla violenza del destino moderno». Se, dunque, il prezioso libro di Abruzzese muoveva dall’urgenza di contribuire al trovare risposte ad un “che fare” – dall’interno di un’esperienza politico-culturale segnata indelebilmente da testi come Operai e capitale di Tronti –, viene da domandarsi quanto di quello spirito possa essere applicato a una contemporaneità in cui davvero si fatica ad andare al di là di una, per quanto necessaria, analisi critica dell’esistente. Se porre al centro dell’analisi contemporanea la “persona costretta alla violenza del destino (iper)moderno digitalizzato” è di certo importante, non dovrebbe esserlo di meno interrogarsi circa il “che fare”.



