di Francesco Festa
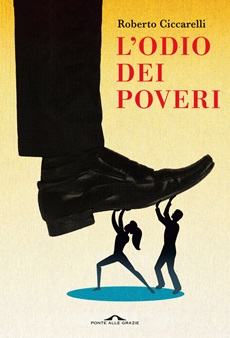 Roberto Ciccarelli, L’odio dei poveri, Ponte alle grazie, Milano, 2023, pp. 328, € 18,00
Roberto Ciccarelli, L’odio dei poveri, Ponte alle grazie, Milano, 2023, pp. 328, € 18,00
La povertà è un “significante vuoto”, un concetto discorsivo aduso per tutte le formazioni politiche, sia per quelle sfacciatamente populiste, sia per quelle che ci provano ma proprio non ce la fanno. D’altronde la povertà, quale concetto assai proficuo, si inserisce utilmente nella logica delle equivalenze di quel piano sintagmatico descritto da Ernesto Laclau, che di per sé enuclea un ossimoro: abbonda sulla bocca di molti, nonostante provochi passioni tristi, sofferenze, se non addirittura sentimenti di rabbia e violenza, a seconda di chi ne subisce gli effetti o ne evochi la realtà. Ad esempio, sia i partiti sia i movimenti politici inanellano le più variegate domande in una sorta di catena che viene transustanziata da un significante vuoto in grado di sussumerle e produrne un discorso con una presa sul “popolo”.
I postfascisti meloniani o i leghisti – ma anche i socialdemocratici o i centristi – raccolgono domande disparate che vertono sul disprezzo per i meridionali oppure il rigetto degli immigrati; le accuse di fannullonismo ai percettori di svariate forme di welfare et similia (reddito di cittadinanza, sussidi sociali e familiari ecc.); e ancora, la richiesta di centralizzazione dei poteri nell’“uomo nuovo” al comando e la protesta per le tasse troppo alte. Insomma, le più diversificate istanze che abbisognano di un collante, cioè, di un significante vuoto che li concateni e, così, attragga a sé i sentimenti più ambivalenti e, infine, si traduca in voti e consenso diffuso. La povertà funge da collante, par excellence.
Beninteso, spostando lo sguardo dal dito alla luna, dietro quel significante vuoto vi è una sostanza poco nota ai più che ne nominano l’esistenza per ragioni politiche. La diffusione della povertà, e in particolare della povertà misurata in termini assoluti ha assunto dimensioni crescenti. La quota di famiglie povere è salita ulteriormente nel 2020 a causa della pandemia, rimanendo sostanzialmente stabile l’anno seguente; e nel 2022, i dati dell’Istat e di Eurostat sono drammaticamente tristi: il 63% delle famiglie non riesce ad arrivare alla fine del mese, mentre la media europea è del 45,5%, cioè, le famiglie in condizione di povertà assoluta sono poco più di 2,18 milioni e oltre 5,6 milioni di individui. I dati registrano un aumento significativo a partire dalla due crisi globali del neoliberismo: la crisi dei mutui subprime del 2008-09 e, a seguire, la crisi dei debiti sovrani della seconda metà del 2011. Il debito sovrano esplode proprio nel periodo aureo del neoliberismo: quando la sua egemonia è dispiegata ai massimi livelli, dopodiché quel sistema di “accumulazione tramite spoliazione”, per dirla con David Harvey, si accanisce ancor più contro i poveri e ai beni pubblici.
La neoliberalizzazione della società ha comportato la distribuzione della ricchezza, piuttosto che la sua produzione, per cui i soldi pubblici servono a finanziare una distorta forma di welfare morale piuttosto che welfare economico che trova applicazione in forme diverse, fra cui anche il dismesso reddito di cittadinanza del governo gialloverde. O per meglio dire: un reddito di povertà volto alla gestione dell’ordine dinanzi all’aumentare del numero dei poveri che attentano al banchetto della proprietà privata, come una sorta di regolazione della produzione ma soprattutto della riproduzione sociale.
Poveri e povertà sono quel significante da riempire, dunque. “Il ‘povero’ diventa così il risultato di un lungo e complesso lavoro tecnico, giuridico e amministrativo che trasforma la sua ‘povertà’ in una costruzione sociale. Tale costruzione è ispirata da progetti diversi, ma convergenti, che provano a guidare i ‘poveri’, spingendoli a ‘cercare un lavoro’ e, se è possibile, a trovarne almeno uno. In fondo, non importa quale” (p. 12).
È uno dei passi assai suggestivi dell’ultimo libro di Roberto Ciccarelli. Un’inchiesta rigorosa sul welfare, sulle trasformazioni della “forza lavoro”, sulla fenomenologia del “capitale umano” e, fra l’altro, anche del “Quinto Stato”, ossia, della moltitudine di lavori e di vite precarie, di coloro che dal neoliberismo e dalle sue crisi hanno subito “il senso della perdita di una posizione sociale” e di una identità.
Una spietata e a tratti distopica radiografia delle società neoliberiste, dove l’individuo è prodotto dall’incontro tra le tecniche di governo politico, la disciplina morale e la razionalità economica, per cui come Christian Laval e Pierre Dardot hanno mostrato nella fabbrica del soggetto neoliberista, l’io è giocoforza spinto a “mutare per sopravvivere nella competizione”, dunque, deve divenire “esperto di se stesso, datore di lavoro di se stesso, inventore di se stesso, imprenditore di se stesso”; non vi è spazio per la povertà e per i poveri, né tantomeno per reddito di cittadinanza o altre forme di ammortizzatori sociali. Fuori dai denti: è la stessa povertà che deve essere messa a lavoro e a valore, a seconda di quelle domande generate dagli attori sociali e politici.
In questa ricerca cui va il merito di aver complicato l’analisi, altrimenti assai semplicistica se non leziosa che interpreta la povertà come fenomeno da fronteggiare con azioni filantropiche per ripulire le coscienze borghesi, Ciccarelli redige innanzitutto un glossario genealogico sui termini entrati nel senso comune (in appendice al volume si trova la voce “glossario”), e al contempo una guida degli affetti, in senso spinoziano, cioè, delle passioni che suscitano la povertà o l’essere povero, fino a provocare quei sillogismi, ormai assunti come naturali, per cui la condizione di povertà arrischia la proprietà privata, essendo assai incline a condotte illegali e incasellabile fra le “classi pericolose”.
Difatti, “la vita precaria, come quella povera, restano esperienze incomprimibili in un’astrazione statistica. Questa condizione è odiata sia da chi è povero, e viceversa. In una società costruita sulla competizione questa è la leva del livello più basso dell’odio che porta alla guerra tra chi vuole sentirsi meno precario o povero di un altro. Più che la persona in uno stato di bisogno è odiata la posizione sociale di chi è costretto a sopravvivere. Nessuno vuole assomigliare a chi prova vergogna, cioè la conseguenza della tristezza provocata dall’idea che gli altri possano biasimare l’azione di chi è povero. Ci si vergogna perché non si sopravvive con i miseri guadagni. È meglio mangiare o andare dal dentista? Pagare il mutuo o la bolletta del gas? Comprare le medicine o versare la rata dell’autonomobile? Fare benzina o acquistare un paio di scarpe?” (pp. 42-43).
Una volta smontati gli stigmi sulla pericolosità sociale della povertà – su cui hanno pontificato le scuole rancorose e pregiudizievoli della broken window theory – , Ciccarelli si concentra prima sul “governo dei poveri” e poi su quello formazione e dell’occupazione, prendendo di petto quella che è la nuova vulgata delle politiche sociali, vale a dire il workfare. La cittadinanza passa così a maggior ragione dalla cruna del lavoro. Viene definita “inclusione attiva”, ché il povero non esiste in quanto tale, piuttosto esiste un individuo non vocato alla propria esistenza che è quella del lavoro. Esso non sarà beneficiario di alcun sostegno pubblico se non si presta alle condizioni dell’occupabilità (employability). Anche se i beneficiari non fossero ritenuti occupabili – com’è stato, in realtà, per i due terzi della platea di percettori del reddito di cittadinanza – poco importa: poiché è il messaggio che conta; e anche l’attivazione del dispositivo di governo dei poveri. Insomma è un altro ordine del discorso: l’abolizione di quella che era una misura di contrasto alla povertà, quale il reddito di cittadinanza, ha dato la stura alle politiche attive del lavoro, nella formula del workfare (work-to-welfare), vale a dire, del rovesciamento dello schema del welfare.
Se in quest’ultimo la cittadinanza sociale – scrive Ciccarelli, in altra occasione – è la prerogativa per il riconoscimento sia dei sussidi che del reinserimento al lavoro, nel workfare è l’effetto della volontà di un soggetto che si rende disponibile al lavoro (ad essere cioè ‘occupabile’ che non significa avere un’occupazione, perlomeno ‘fissa’), alla formazione obbligatoria e a svolgere la corvée dei ‘progetti utilità alla collettività’ (Puc). In alcuni casi potrebbero risultare un illusorio reinserimento sociale di persone dimenticate dalla società. In realtà, alla lunga, saranno la doppia pena dei poveri: esclusi e poi costretti ai lavori gratuiti pena la perdita del sussidio. Sull’incapacità di riconoscere e criticare modelli già noti in altri paesi si misura la forza dell’egemonia neoliberale sulla sinistra e sui sindacati, fautori in Italia di questo workfare.
Questo processo forzoso e a tratti violento – da menzionare le campagne livorose per cui il reddito di cittadinanza equivaleva al diritto al divano – rimanda ad un eterno ritorno della storia del capitalismo, all’“attualità della preistoria”, per adoperare una felice locuzione di Sandro Mezzadra, titolo della sua rilettura del capitolo 24 del primo libro del Capitale di Marx, “La cosiddetta accumulazione originaria”. In questo saggio, Mezzadra restituisce con lo sguardo della critica postcoloniale quel processo sempre attuale, che è presupposto del capitale e il risultato della sua riproduzione, per cui il rapporto capitalistico non può esistere se l’individuo non è costretto a vendere la propria forza lavoro. Parimenti a quanto ricostruito da Karl Polanyi nell’Inghilterra della Rivoluzione Industriale, fra il XVIII e il XIX secolo, ossia il processo di proletarizzazione tramite l’abolizione della Speenhamland Law, la legge sul diritto di vivere che si scontrava inevitabilmente con l’esigenza di creare un mercato del lavoro e una classe lavoratrice che vivesse esclusivamente di salari.
Si può andare oltre nell’opera di smontaggio della grande narrazione neoliberale e della sua razionalità normativa – al cui centro vi è la norma di vita numero uno del mercato, cioè, la concorrenza – se adottassimo la “teoria del valore-lavoro”, come misura del valore del surplus, adattandola al sistema capitalistico e al succedersi di diverse modalità di accumulazione, al processo di valorizzazione definito da Andrea Fumagalli, “biocapitalismo”, come “superamento della separazione tra tempo di vita e tempo di lavoro” e della “separazione tra produzione, circolazione e consumo”. Detto altrimenti, la povertà è una condizione inesistente nell’attuale modalità di accumulazione: è la vita messa a valore. Il che andrebbe riconosciuto sotto forma di remunerazione per tutte quelle attività che svolgiamo quotidianamente e che producono valore tramite un autentico reddito di cittadinanza: un reddito di base universale e incondizionato.
Il “che fare” passa dalla rottura del “ciclo neoliberale e invertire il suo senso politico”. Hic Rhodus hic salta. Lotta politica, costruzione di un potere sociale che scardini e rovesci la “pedagogia autoritaria del workfare […] con l’educazione alla potenza degli oppressi”, con la ripresa della lotta di classe, dei poveri e dei subalterni, “quella che incoraggia l’affermazione di virtù civili, pubbliche e politiche ispirate all’indipendenza, alla cooperazione, all’operosità. Riscopriremmo così il pensiero della liberazione a cominciare dalle pratiche femministe del partire da sé superando l’egolotria, dall’etica spinozista della potenza, della conoscenza e dell’agire e da quella che valorizza l’etica e la pratica della cura nelle relazioni sociali, economiche e politiche. Queste politiche, e i provvedimenti che possono generare, servirebbero a riorientare il welfare nella direzione di un commonfare, o di un welfare del benessere, delle libertà uguali e delle proprietà comuni.”
Il discorso di Ciccarelli non fa una piega e spinge a compiere un passo in avanti soprattutto alle analisi prodotte in questi anni, che sono anche programmi per un pensiero e per delle pratiche radicali all’altezza della sfida neoliberista. Sono tattiche per riacciuffare il bandolo della matassa e per incominciare a fargliela pagare. Il commonfare è un welfare del comune e della cooperazione sociale, di ciò che ci viene espropriato: un welfare adeguato al nuovo paradigma di accumulazione che, mettendo a lavoro e a valore la vita, estrae profitto espropriando la riproduzione sociale e il general intellect. Qualsiasi politica di welfare che abbia a cuore la coesione sociale non può quindi che partire dal comune. E, iuxta propria principia, come critica dell’economia politica, andrebbe ripresa la formula del “rifiuto del lavoro”. Formula che Toni Negri, in linea con il marxismo rivoluzionario, ci ha insegnato essere il baricentro della politica non dialettica di una relazione costruttiva, costituente, fra teoria e pratica rivoluzionaria. Situata dentro e contro lo sviluppo del capitale.



