di Piero Cipriano
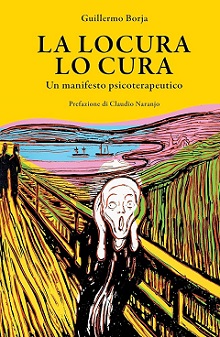 Basta con tutti questi terapeuti inutili, fabbricati con un manicomio nosologico che gli impedisce ormai di vedere persone ma – con occhiali psicopatologizzanti che non riescono più a levarsi dal naso – capaci di vedere solo diagnosi e malati. Non ci interessano più. Dico non ci interessano perché non solo non interessano me, ma non interessano centinaia migliaia milioni di persone patologizzate e diagnosticate che cercano una risposta, una cura, in questi terapeuti anodini e – come sapete tutti – non la trovano. Ci interessano invece i pochi terapeuti che hanno il coraggio di essere selvaggi. Anarchici e selvaggi. A cominciare da Jung che insegnò, a quelli che si ponevano dietro il divano – il suo maestro in primis, il neurologo viennese che non sapeva ipnotizzare e decise di lavorare con l’attenzione fluttuante ma per il timore di scottarsi con lo sguardo folle del paziente gli si mise dietro, protetto dallo sguardo contagioso dell’analizzando, e per essere ancora più protetto dal fuoco della follia stabilì che solo il tipo nevrotico può accedere all’analisi, il tipo psicotico no, troppo pericoloso da analizzare – a mettersi di fronte, e insegnò l’etica del sacrificio ovvero: imparare a scottarsi col fuoco della follia. Dopo di lui altri antifreudiani, da Otto Ranck che col trauma della nascita porta l’inconscio freudiano – fermo ai primi anni di vita – fin dentro l’utero, e poi Sándor Ferenczi che crede nella telepatia e poi Wilhelm Reich e altri ancora. Tra questi Eugène Minkowski, che stabilì la diagnosi per sentimento o per penetrazione o per intuizione – gefüldiagnose – ispirandosi a Henri Bergson. Un salto nel tempo di mezzo secolo e siamo a Timothy Leary, che prima di proporre il pasto psichedelico all’intera popolazione americana volle curare, coi funghi psichedelici, i detenuti considerati psicopatici – ovvero senza sentimento – di un carcere di massima sicurezza. E poi Ronald Laing che a Kingsley Hall prova a convivere con la schizofrenia di quelle persone ugualmente a David Cooper che a Villa 21 si spinge oltre, riuscendo a diventare schizofrenico. Tentativi nobili e selvaggi quanto inefficaci finché uno psichiatra anarchico si trova a dirigere un manicomio e decide – è Franco Basaglia – che i dannati della terra, esseri umani seppelliti nella pancia del manicomio, devono ritornare in città. Basaglia è Ulisse che guida il cavallo blu in città, un cavallo coi folli stivati nella pancia, che hanno di nuovo il diritto di riabitare la città.
Basta con tutti questi terapeuti inutili, fabbricati con un manicomio nosologico che gli impedisce ormai di vedere persone ma – con occhiali psicopatologizzanti che non riescono più a levarsi dal naso – capaci di vedere solo diagnosi e malati. Non ci interessano più. Dico non ci interessano perché non solo non interessano me, ma non interessano centinaia migliaia milioni di persone patologizzate e diagnosticate che cercano una risposta, una cura, in questi terapeuti anodini e – come sapete tutti – non la trovano. Ci interessano invece i pochi terapeuti che hanno il coraggio di essere selvaggi. Anarchici e selvaggi. A cominciare da Jung che insegnò, a quelli che si ponevano dietro il divano – il suo maestro in primis, il neurologo viennese che non sapeva ipnotizzare e decise di lavorare con l’attenzione fluttuante ma per il timore di scottarsi con lo sguardo folle del paziente gli si mise dietro, protetto dallo sguardo contagioso dell’analizzando, e per essere ancora più protetto dal fuoco della follia stabilì che solo il tipo nevrotico può accedere all’analisi, il tipo psicotico no, troppo pericoloso da analizzare – a mettersi di fronte, e insegnò l’etica del sacrificio ovvero: imparare a scottarsi col fuoco della follia. Dopo di lui altri antifreudiani, da Otto Ranck che col trauma della nascita porta l’inconscio freudiano – fermo ai primi anni di vita – fin dentro l’utero, e poi Sándor Ferenczi che crede nella telepatia e poi Wilhelm Reich e altri ancora. Tra questi Eugène Minkowski, che stabilì la diagnosi per sentimento o per penetrazione o per intuizione – gefüldiagnose – ispirandosi a Henri Bergson. Un salto nel tempo di mezzo secolo e siamo a Timothy Leary, che prima di proporre il pasto psichedelico all’intera popolazione americana volle curare, coi funghi psichedelici, i detenuti considerati psicopatici – ovvero senza sentimento – di un carcere di massima sicurezza. E poi Ronald Laing che a Kingsley Hall prova a convivere con la schizofrenia di quelle persone ugualmente a David Cooper che a Villa 21 si spinge oltre, riuscendo a diventare schizofrenico. Tentativi nobili e selvaggi quanto inefficaci finché uno psichiatra anarchico si trova a dirigere un manicomio e decide – è Franco Basaglia – che i dannati della terra, esseri umani seppelliti nella pancia del manicomio, devono ritornare in città. Basaglia è Ulisse che guida il cavallo blu in città, un cavallo coi folli stivati nella pancia, che hanno di nuovo il diritto di riabitare la città.
Dimentico alcuni, perché ce ne sono di terapeuti selvaggi. Leo Zeff è un altro che ha vissuto per vent’anni come un criminale, avendo scelto di continuare l’attività di terapeuta con le molecole psichedeliche nonostante la proibizione del 1971. The secret chief, lo definisce Terence McKenna. Il capo segreto dei terapeuti psichedelici clandestini americani.
L’elenco sarebbe infinito, dei terapeuti selvaggi.
Che, se la psichiatria – arte di curare l’anima, che grande sciocchezza in quest’etimo: tu, misero psichiatra, pretendi di curare l’anima? Suvvia – ha ancora un po’ di senso è perché, ogni tanto, uno di questi terapeuti radicali e selvaggi ha messo piede nella casa della psichiatria. Per cambiarla – ristrutturarla – o per distruggerla.
Ma il più selvaggio di tutti i terapeuti selvaggi che hanno provato a inselvaticare la psichiatria – o la psicoterapia; insomma, la pratica di curare gli umani – è Guillermo Bojra. Ciò non significa che abbia fatto tutto bene e solo il buono, nei 44 anni che gli è stato concesso di vivere.
La locura lo cura, titolo del suo libro, editato da Spazio Interiore, potremmo eleggerlo a suo motto. O, anche, medico poeta y loco de todo tenemos un poco.
È stato un uomo brutale con tutti e soprattutto con se stesso, ciò che scrive Cèline di Ignàc Semmelweis – altro terapeuta selvaggio che non viene creduto nella sua scoperta della causa della sepsi puerpuerale e finisce i suoi giorni in manicomio – sembra attagliarsi bene a Guillermo Borja.
Così lo definisce Claudio Naranjo – che Borja aveva eletto a suo maestro. E sì perché Guillermo Borja, terapeuta che va in prigione perché cura con le piante visionarie, aveva avuto vari maestri, tutti altrettanto selvaggi. A cominciare da Maria Sabina, la sabia mazateca che curava coi teonanancàtl – la carne di Dio – e se non era selvaggia lei, illetterata che nemmeno lo spagnolo parlava. Ma sapeva leggere il libro dove tutto è scritto e sapeva parlare a tu per tu con gli Esseri speciali. Dopo di lei ebbe come maestro Salvador Roquet, altro terapeuta messicano selvaggio, che anticipa Borja finendo in prigione, perché un medico non può curare coi funghi. Ebbe come maestro anche uno sciamano huichol di nome Oswaldo. Finché viene arrestato, nel 1990, perché da anni celebrava, con un’indigena huichol, cerimonie peyotere nel deserto messicano.
È severo Naranjo nei confronti di Borja. Lo definisce una sorta di Rasputin capace di curare perfino col sesso. Sì. Il gran tabù di psichiatri e psicanalisti per Borja non era un tabù. Come Rasputin – scrive Naranjo – Borja era al tempo stesso persona benintenzionata e grande guaritore, ma anche tipo promiscuo e gran manipolatore, capace di violente esplosioni di rabbia. Finisce in carcere giusto in tempo – scrive Naranjo – per salvarsi. Pochi giorni dopo la diagnosi di sieropositività al virus Hiv. Sembra, il carcere, l’opportunità che gli viene data per curarsi. Per diventare più umano. La vita – osserva Naranjo – lo stava punendo per le sue azioni recenti, ma al tempo stesso gli offre la possibilità di riabilitarsi, lavorare su di sé.
Lì accade un’opportunità incredibile, una disgrazia necessaria come nemmeno Basaglia aveva avuto. Basaglia finisce in manicomio, d’accordo, un manicomio – quello di Gorizia – con 600 internati. E lui si ingegna per liberarli. Ma è pur sempre il direttore del manicomio. E li libera. E distrugge il manicomio. Prima Gorizia poi un manicomio ancora più grande, il doppio, 1200 internati. Tutti liberati. Eliminati 76 manicomi in Italia. E dopo muore.
Borja non è direttore del carcere ma un detenuto tra i detenuti. E la vicedirettrice lo informa di un settore del carcere, un edificio abbandonato con “settantadue psicotici nudi e pieni di infezioni su tutto il corpo”. Non ricevevano farmaci e “i medici neanche ci mettevano piede, l’équipe di psicologia aveva paura ed era il padiglione con il più alto tasso di violenze, suicidi e morti”. Senza acqua, le pareti coperte di feci. Una sorta di piccolo manicomio medievale dentro il carcere, dove settantadue psicotici vegetano tra merda e piscio, subendo le violenze degli altri detenuti, quelli sani. La vicedirettrice gli fa questa strana proposta. Occupati di quelle anime perse. Impiega un mese, Borja, per vincere la paura di quelli, non avevano più niente di umano, un mese per entrare nel padiglione dei sudici violenti catatonici disumani. E, senza farmaci senza fasce e senza infermieri si inventa la cura.
La cura. Qui entriamo nel tema – mai risolto – di cosa sia terapia. In cosa consista, di preciso, la terapia psichica. Sono i farmaci e le parole? Il binomio a cui si affida la moderna cura psichica? O è anche altro?
Una volta entrato la paura principale è di essere ucciso. Non c’era alcuna psicoterapia da fare, la prima cosa fu lavarli e raparli. Macchinette per tagliare i capelli, eliminare i pidocchi. Poi vestirli. Taglia loro le unghie di piedi e mani. Sembra ripetere il gesto di Cristo di lavare i piedi agli apostoli.
Arruola stupratori e assassini dagli altri settori per farne la sua equipe multiprofessionale. Sceglie i peggiori, coloro che avevano sperimentato l’abisso. Avvia un orto. Crea un allevamento di polli e anatre che, insieme a cani e gatti, diventano co-terapeuti. Certi animali adottano certi psicotici. Il catatonico affetto da violenza estrema dopo un mese smette di scalciare il gatto e gli dice ti voglio bene. Quei cuccioli facevano più miracoli degli psichiatri e degli psicologi (che continuavano a non entrare in quel padiglione). Fabbricano manufatti artigianali che vendono. Diventa una comunità quasi autosufficiente. Quel posto diventa il più bello dell’ospedale.
Lo psichiatra del carcere, all’inizio scettico e supponente – “ero un criminale, come potevo insegnargli io?” scrive Borja – pian piano inizia a mettersi in gioco. Borja gli suggerisce delle letture, Il regno della felicità di Krishnamurti, per esempio. Infine, lo psichiatra del carcere diventa il suo assistente, il suo allievo, il suo paziente.
La locura lo cura, dunque, è il suo manifesto. Ecco alcuni punti chiave.
- Il terapeuta è una persona, come lo è il paziente. Per sapere cosa accade al paziente il terapeuta deve essere stato paziente. Per sapere l’abisso dove abita il paziente il terapeuta deve essere stato in quell’abisso.
- I terapeuti per lo più non hanno il coraggio di dubitare di sé e perdere il controllo; pertanto, di fronte alla possibilità di naufragare e essere catalogati con le stesse etichette diagnostiche che essi adoperano, preferiscono non rischiare, restando sulle “sponde della malattia”, di qua, l’unico territorio che conoscono.
- “La psicoterapia profonda insegna al paziente un nuovo stile di vita”. Chi se ne frega della ricerca della salute, l’obiettivo è “trasformare il proprio cammino nella meta finale”. “Non possiamo accontentarci di essere persone funzionali” o educate.
- “Il vero terapeuta invita il paziente a rinascere”.
- Ci sono terapeuti che sono convinti di essere portatori della bandiera della salute, e che sia loro responsabilità guarire gli altri”. “Questi terapeuti, invece di riconoscere che, semplicemente, non sanno, passano la loro vita a spiegare”. “Non possono né tacere né accettare la loro ignoranza”. Ecco, qui Borja radicalizza l’epochè di Husserl già adottato da Basaglia. Li vedete, vero? Vi vengono in mente adesso, uno per uno, i terapeuti più o meno noti che discettano su tutto? Tutti gli chiedono tutto e loro rispondono a tutto, senza mai un dubbio, mai una volta sentirete un Recalcati o un Crepet o un Andreoli rispondere: E io che ne so?
- “La norma della vita è essere anormali”.
- “La terapia ufficiale è identificata con il potere di turno, poiché la sua egemonia dipende dalla non-salute. La cura profonda comporta una coscienza politica. Non si può parlare di benessere astenendosi dalla fraternità. Un essere cosciente è un essere olistico, preoccupato di difendere la natura, la prosperità, la terra, la vita, l’eredità di chi verrà dopo”. Quanti terapeuti conoscete che pensano o dicono ciò? Non è parte del problema il fatto che i terapeuti non concordino con ciò?
- “Il terapeuta che non ha svolto un lavoro personale è un robot, un malato in più, qualcuno incapace di portare il paziente da qualsiasi parte”. Ovviamente per lavoro personale Borja intende – essendo un terapeuta che ha lavorato sciamanicamente con piante e altri stati di coscienza – non certo farsi qualche anno di analisi o psicoterapia classica, ma lavorare davvero col dark side. E la quasi totalità dei terapeuti sono robot ignari dei propri stati di coscienza.
- “L’essenza della cura, nel lavoro con gli psicotici, è sapere che sono curabili, forse non come vorremmo noi, ma come vorrebbero loro”. Qui Borja radicalizza Jung e Minkowski. L’etica del sacrificio junghiana. Il terapeuta che con la sua prognosi invera la profezia. Il mago nero Kraepelin, che stabili l’inguaribilità di coloro che ricevono la diagnosi di dementia praecox (poi detta schizofrenia), ha fatto scuola. Gli psichiatri e gli psicoterapeuti a venire, perfino gli attuali terapeuti rinascimentalpsichedelici, sono nel solco di questa dicotomia kraepeliniana, e della prognosi di inguaribilità degli psicotici, ai quali non è riservato il tentativo, nemmeno compassionevole, della terapia psichedelica.
Fermiamoci qui. È più che sufficiente. Leggete il libro, a questo punto, se vi è venuta la curiosità. Dopo quattro anni, Borja esce dal carcere, per ricominciare, uomo nuovo, terapeuta selvaggio un po’ addomesticato. Aveva intenzione di mettere un cartello, sulla porta dello studio, con scritto: “Si accettano pazienti (purché come minimo assassini)”. Invece dopo quattro mesi muore. Capita così a questi psichiatri selvaggi, che portano a termine la propria impresa e muoiono. Basaglia muore due anni dopo la legge 180, con cui ci aveva liberato dal manicomio. Borja 4 mesi dopo che si era liberato del carcere.



