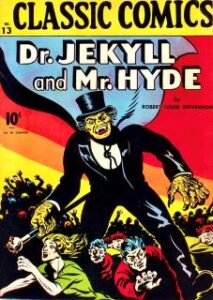di Diego Gabutti
Guardala, eccola in lontananza, l’Asia, l’Asia profonda al punto che ti viene da tremare al pensiero di quanto sia vicina a Mosca. (Vasilij Golovanov, Verso le rovine di Čevengur)
Ricordo benissimo in che occasione mi sono procurato Il dispotismo orientale di Wittfogel. Fu a Firenze nell’estate del 1971: era l’ammezzato d’una grande libreria del centro (adesso me ne sfugge il nome, e chissà se esiste ancora). Ma proprio non saprei dire dov’ero (e quand’ero) il giorno in cui mi è capitata per le mani la prima copia dello Strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886). Troppe versioni ne ho lette e palpate nell’altro secolo e in questo. Non so neanche se la prima volta ho letto il romanzo oppure un fumetto ispirato al romanzo (allora ne circolavano parecchi, alcuni molto belli, e ne appaiono di nuovi anche adesso) o se non era piuttosto un’«edizione ridotta» del libro (buona l’ultima, credo, ma chi lo sa). Sempre che il mio primo contatto col romanzo di Stevenson non sia stato né il romanzo né il fumetto, ma il film del 1941 con Ingrid Bergman (la bella) e Spencer Tracy (il dottore impasticcato).
 Ai tempi, quando la televisione era ancora una mezza novità, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, regia di Victor Fleming, candidato all’Oscar per la migliore fotografia black and white, passava spesso «sul piccolo schermo», come si diceva una volta, prima che gli schermi diventassero piccolissimi, tipo l’iPhone, o più piccoli ancora, come il mio primo iPod, che aveva uno schermo non più grande d’un francobollo (eppure io ci ho visto Ghostbusters, Lawrence d’Arabia e le tre stagioni della serie classica di Star Trek mentre marciavo sullo stepper, in palestra, macinando chilometri su chilometri senza mai arrivare da nessuna parte né togliermi mai dal punto). Immagino che, rivisto oggi, quel vecchio film babau sembrerebbe ridicolo (tutti quei peli, e quei denti, e il cilindro, le ghette) ma all’epoca mi aveva impressionato, da tenere la luce accesa sul comodino.
Ai tempi, quando la televisione era ancora una mezza novità, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, regia di Victor Fleming, candidato all’Oscar per la migliore fotografia black and white, passava spesso «sul piccolo schermo», come si diceva una volta, prima che gli schermi diventassero piccolissimi, tipo l’iPhone, o più piccoli ancora, come il mio primo iPod, che aveva uno schermo non più grande d’un francobollo (eppure io ci ho visto Ghostbusters, Lawrence d’Arabia e le tre stagioni della serie classica di Star Trek mentre marciavo sullo stepper, in palestra, macinando chilometri su chilometri senza mai arrivare da nessuna parte né togliermi mai dal punto). Immagino che, rivisto oggi, quel vecchio film babau sembrerebbe ridicolo (tutti quei peli, e quei denti, e il cilindro, le ghette) ma all’epoca mi aveva impressionato, da tenere la luce accesa sul comodino.
Solo Le sei mogli di Barbablù, quando passò in tv più o meno negli stessi anni di Jekill e Hyde, m’aveva spaventato di più: le povere soubrette da scannare, Totò sospeso sulle vasche piene d’acido, un Tino Buazzelli mannaro. Per anni, dopo aver visto le Le sei mogli di Barbablù, girato nel 1950 da Anton Giulio Bragaglia, regista nonché futurista della vecchia guardia, la faccia storta del Principe De Curtis mi è sembrata più agghiacciante di quella del Joker. Totò veniva inseguito da Aldo Fabrizi in Guardie e ladri, oppure finiva tra gli esistenzialisti capresi in Totò a colori, e io pensavo che al posto degli esistenzialisti con la mossetta ambigua e l’erre moscia, o di Aldo Fabrizi in divisa XXXL da questurino, mi sarei ben guardato dal frequentare Totò, il cui sorriso sghembo e scardinato, che ai babbani poteva sembrare buffo, era in realtà un rictus satanico, una smorfia loffia. Totò aveva due anime, pensavo io. Era un attore comico, ma anche un mostro.
 Avevo capito niente. Prima di tutto, e a ciascuno il suo, il mostro era Buazzelli e non Totò. E poi, anche se allora non lo sapevo e lo capisco soltanto ora, stavo confondendo Totò con Spencer Tracy, Isa Barzizza con Ingrid Bergman. Era Tracy, e non Totò, ad avere due anime.
Avevo capito niente. Prima di tutto, e a ciascuno il suo, il mostro era Buazzelli e non Totò. E poi, anche se allora non lo sapevo e lo capisco soltanto ora, stavo confondendo Totò con Spencer Tracy, Isa Barzizza con Ingrid Bergman. Era Tracy, e non Totò, ad avere due anime.
Stevenson, col suo apologo sulla location del bene e del male, aveva riscritto la Bibbia: non Caino e Abele ma Caino-Abele. Siamo stati creati doppi, con due anime, una luminosa, l’altra no. È questo che raccontava Lo strano caso. Stevenson non aveva ancora finito d’enunciare il suo filosofema che già era storia vecchia, neanche l’avessimo sempre saputo. E non lo sapevamo, qualunque cosa ci dicessimo dopo averlo letto.
Adesso so che cosa mi piace dello Strano caso, e quel che mi piace c’entra poco col romanzo ma c’entra con l’idea che me sono fatto dopo averci almanaccato su. Alcuni non hanno orecchio per la musica o per la poesia. Io non ho orecchio per la musica, per la poesia e per il romanzo gotico. È più forte di me: le storie de paura mi fanno paura. Mi agito nel letto, senza trovare sonno, dopo aver visto L’esorcista (e persino L’esorciccio) o dopo aver letto Frankenstein e Il miglio verde di Stephen King. Mai visto un serial di zombie, nemmeno i trailer. M’impressionano, e così li evito, i film sulla Shoah – compreso Schindler’s List, di cui tutti dicono un gran bene – e confesso di non avere mai letto, sempre per non sognarmelo di notte, Se questo è un uomo. Ci sono libri sul Gulag o sulle imprese d’ayatollah, talebani e alqaedisti di cui salto intere pagine. Appena qualcuno viene arso vivo o decollato io mi teletrasporto qualche capoverso più in là. Ma Lo strano caso non è voyeurismo. È una metafora illuminante. Ergo non può essere facilmente scansata. Stevenson ne fu il profeta.
 Al pari della felicità, che secondo Saint-Just era un’idea nuova in Europa, anche la natura doppia dell’homo era un’idea nuova, forse non particolarmente felice, però nuova, o abbastanza nuova, almeno in quella forma estrema. Non era la prima volta, infatti, che ricorrendo al concetto di doppiezza i filosofi s’affannavano a spiegare le difficoltà (Adorno, un ragazzo snob, le chiamava «aporie») nelle quali s’imbatte il pensiero quando gli si para di fronte qualcosa d’inspiegabile, «l’orrore! l’orrore» con cui si chiude Cuore di tenebra, la banalità del male di Hannah Arendt, Lee Marvin nell’Uomo che uccise Liberty Valance (1962) di John Ford, qualcosa insomma che fa disperare dell’umana natura, e che dà i brividi persino a chi non se ne aspetta niente di buono. Metti Iago nell’Otello di Shakespeare, metti Barbablù-Buazzelli nel film di Totò. Oppure metti il totalitarismo moderno, metti Gengis Khan, metti i terrificanti sistemi sociali d’India e Cina, oppure metti l’Unione Sovietica, come fa Karl August Wittfogel quando s’interroga sulla piega che, dopo il golpe dei bolscevichi a Pietroburgo, fino a poco prima San Pietroburgo e subito dopo Leningrado, hanno preso gli eventi, e prova a spiegarsi su quali radici prosperano le catastrofi sociali. Ma Lo strano caso era una primizia. Era cioè la prima volta che la natura doppia della natura umana, il segreto dei segreti, cioè che gli umanesimi e i disumanesimi sono (disilludiamoci) la même chose o poco ci manca, trovava il suo avatar, la sua icona o meglio, per così dire. la sua zazzera d’Albert Einstein, o di Che Guevara: Jekyll-Hyde. C’era già stato Giano, vero, ma Giano non era «bifronte» per via d’una doppia personalità, una altruista e l’altra bastarda, ma perché una delle sue facce era rivolta al passato, l’altra al futuro, tutt’altra partita.
Al pari della felicità, che secondo Saint-Just era un’idea nuova in Europa, anche la natura doppia dell’homo era un’idea nuova, forse non particolarmente felice, però nuova, o abbastanza nuova, almeno in quella forma estrema. Non era la prima volta, infatti, che ricorrendo al concetto di doppiezza i filosofi s’affannavano a spiegare le difficoltà (Adorno, un ragazzo snob, le chiamava «aporie») nelle quali s’imbatte il pensiero quando gli si para di fronte qualcosa d’inspiegabile, «l’orrore! l’orrore» con cui si chiude Cuore di tenebra, la banalità del male di Hannah Arendt, Lee Marvin nell’Uomo che uccise Liberty Valance (1962) di John Ford, qualcosa insomma che fa disperare dell’umana natura, e che dà i brividi persino a chi non se ne aspetta niente di buono. Metti Iago nell’Otello di Shakespeare, metti Barbablù-Buazzelli nel film di Totò. Oppure metti il totalitarismo moderno, metti Gengis Khan, metti i terrificanti sistemi sociali d’India e Cina, oppure metti l’Unione Sovietica, come fa Karl August Wittfogel quando s’interroga sulla piega che, dopo il golpe dei bolscevichi a Pietroburgo, fino a poco prima San Pietroburgo e subito dopo Leningrado, hanno preso gli eventi, e prova a spiegarsi su quali radici prosperano le catastrofi sociali. Ma Lo strano caso era una primizia. Era cioè la prima volta che la natura doppia della natura umana, il segreto dei segreti, cioè che gli umanesimi e i disumanesimi sono (disilludiamoci) la même chose o poco ci manca, trovava il suo avatar, la sua icona o meglio, per così dire. la sua zazzera d’Albert Einstein, o di Che Guevara: Jekyll-Hyde. C’era già stato Giano, vero, ma Giano non era «bifronte» per via d’una doppia personalità, una altruista e l’altra bastarda, ma perché una delle sue facce era rivolta al passato, l’altra al futuro, tutt’altra partita.
Unde malum? Unde Hyde?
Questo era il problema che illustrava (e a cui dava risposta, una risposta pop, gotica e moralistica) Robert Louis Stevenson, che giusto tre anni prima, nel 1883, aveva pubblicato L’isola del tesoro, dove il pirata Long John Silver, gamba di legno, un pappagallo sulla spalla, la stampella, era già una specie di Jekyll-Hyde, probo o infame secondo estro e convenienza. Perché Hyde? Perché Long John Silver? Da dove arrivano costoro? Chi li ha mandati? Arimane, il dio malvagio? E Ahura Mazdā, il dio buono… lui niente, lascia fare? Führer, Duci, Godzilla, Padrini e Gruppi Wagner, Segretari Generali? Com’è che ci sono i cattivi? Perché la fetta di pane cade sempre dalla parte imburrata? La verità, vi prego, su odio, vizio e «orrore! orrore!»
Stevenson ha un’intuizione da feuilleton, diventata col tempo e l’evoluzione dei media per l’intrattenimento un’intuizione da fumetto: il male siamo noi, ce l’abbiamo dentro, e basta molto poco per far emergere il lato oscuro, un beverone, le corna, una crisi economica, insomma l’occasione che fa l’uomo peccatore. A scatenare Hyde contro Jekyll, originando il gran conflitto metafisico, può essere un trauma, come dirà poi Sigmund Freud, o anche solo una botta in testa, come capita a Pippo nei fumetti, e allora il socio di Topolino cambia carattere, da scemo diventa un’aquila, da tamarro un intellò, era generoso e simpatico, ed eccolo avaro e gretto. Questa intuizione ha, volendo, anche un suo bel risvolto teologico, perché è evidente che, se Pippo è un intelligentone come Hulk è Bruce Banner, allora nessuno può fingere stupore, tant’è vero che nessuno lo fa, se salta fuori che Ahura Mazdā è Arimane, l’Alto il Basso e la Luce Tenebra. Nessuno come i nerd, niente come la cultura pop, ha mai preso così sul serio gnostici, manichei, albigesi e dolciniani (vedi, per dire, Il nome della rosa).
Nella cultura pop del Novecento Jekyll-Hyde ha avuto più imitazioni della Settimana Enigmistica: il turista tedesco di Morte a Venezia che sembra un tranquillo compositore e invece, «Two-Face» nelle storie di Batman, lo stesso Batman cavaliere oscuro e naturalmente anche tutti gli altri supereroi in maschera con i loro poteri misteriosi e le loro identità segrete, lì a dimostrare che abbiamo tutti qualcosa da nascondere (Flash e Lanterna Verde, Paperinik, il barista qui sotto, tutt’e quattro i Fantastici Quattro). Per non parlare del Sosia di Dostoevskij, col suo spirito beffardo e distruttore, o di Darth Vader nell’interminabile ciclo di Star Wars, che in gioventù era la speranza dei Cavalieri Jedi, forse il Prescelto medesimo, maiuscola e tutto, e che poi si trasforma nel monumento a cavallo del Lato Oscuro, di nuovo maiuscole e tutto. Sappiamo come Hyde si manifesta, così come sappiamo che per lui ogni occasione per far danni è buona, ma non sappiamo altro, la sua natura è fumosa, imprecisa, scontornata come le sequenze sfuggenti e disallineate dei sogni, le sue motivazioni arcane.
Mr. Hyde, il lato oscuro, «non è facile a descriversi», dice Stevenson dando espressaione alla difficoltà (o all’aporia) di descriverlo. «C’è qualcosa che non va nella sua fisionomia; qualcosa di sgradevole, qualcosa d’assolutamente detestabile. Non avevo mai visto un uomo che mi ripugnasse quanto Hyde mi ripugnava eppure non so neanche come mai. Deve avere un che di deforme: dà una forte impressione di deformità, benché mi sia impossibile specificarne la natura. È un tipo assolutamente fuori dal comune, eppure non saprei indicare niente d’insolito. No, signore, niente da fare… non riesco a descriverlo. E non per un vuoto di memoria; vi posso assicurare, infatti, che ce l’ho davanti agli occhi anche in questo momento».
Non sappiamo a quali leggi risponda, donde arrivi, né che aspetto precisamente abbia, perché soltanto l’Hyde cinematografico è sempre dotato di caratteristiche inconfondibili in tutte le sue multiple manifestazioni: le zanne à la Friedrich March, che fu Hyde nel film di Rouben Mamoulian dieci anni prima di Spencer Tracy, la mascella sbieca di Totò, Jerry Lewis senz’ombra di trucco da lupo cattivo nelle Folli notti del dottor Jerryl. Non sappiamo, semplicemente, a che scopo il fantasma di Mr Hyde infesti il nostro DNA, ma che il gene hydiano ci sia, questo sì, lo sappiamo. Evidentemente, in un lontano passato, tra gli ominidi o prima ancora, tra nostri antenati anche più remoti e pre-scimmieschi, quando persino l’albero delle banane era ancora nel mondo della luna, agire da orchi ha rappresentato un vantaggio evolutivo. È per questa via che si è fissato, come un post-it diabolista, nel nostro codice genetico.
Per capire il perché e il percome d’un tale fenomeno evolutivo ci vorrebbe la macchina del tempo di H.G. Wells. Così come sta la faccenda, e fin quando non si potrà viaggiare indietro negli anni, ci dovremo accontentare d’un feuilleton del 1886 e dei suoi derivati cinematografici e fumettistici. Ma sulle macchine del tempo, se posso aprire qui con permesso una parentesi, non farei nessun conto: gli scienziati dubitano che ce ne sarà mai una, ahinoi, e avanzano quale prova ontologica dell’impossibilità di muoversi attraverso il tempo l’affaire del Golgota, nel senso che se viaggiare nel tempo fosse possibile allora i viaggiatori nel tempo si dirigerebbero-dirigeranno-sarebbero diretti tutti lì, sotto le croci, a farsi i selfie con Barabba e Longino, e ci sarebbe – last but not least, ultimo ma non meno importante – anche un Vangelo secondo H.G. Wells. Ma c’è un romanzo di Poul Anderson – Tempo verrà, in originale There Will Be Time, e forse ci torniamo – in cui sul Golgota, confusi tra la folla, ci sono effettivamente parecchi crononauti, tutti ben camuffati, niente AppleWatch al polso, nessuno con lo smartphone o con gli occhiali scuri. Uno dei viaggiatori si rivolge al protagonista del romanzo: «Es tu peregrinator temporis?»
 Ammesso che non si possa viaggiare nel tempo, ok, non importa, consoliamoci, va bene lo stesso, che ci sono macchine del tempo a vapore: le biblioteche, i musei e la fantasia romanzesca degli storici, per venire finalmente a Karl August Wittfogel, che tuttavia non fu semplicemente uno storico, anzi fu ben altro che uno storico. Fu allo stesso tempo storico, filosofo e sociologo. Ce n’era di gente così a cavallo tra l’Otto e il Novecento. Anche Marx era uno di costoro: la storia è storia delle lotte di classe, uno spettro s’aggira per l’Europa, finem historiae, il comunismo primitivo, roba kolossal. Un altro era Oswald Spengler: l’Occidente al tramonto, la danza e contraddanza delle civiltà. C’era poi Johann Jakob Bachofen, giurista e antropologo, oltre che storico: decretò ab origine una società matriarcale, da cui le moderne società patriarcali derivano, frutto di preistorici tumulti «men-lib». Non dimentichiamo Freud, appena citato: ribattezzata l’anima «inconscio», ne fece una barretta di pongo plasmata dai palpeggi delle esperienze traumatiche, e con l’inconscio tutto acquistava senso, lo stesso senso, dall’edificazione delle piramidi al motto di spirito, dai sogni al sorriso della Gioconda.
Ammesso che non si possa viaggiare nel tempo, ok, non importa, consoliamoci, va bene lo stesso, che ci sono macchine del tempo a vapore: le biblioteche, i musei e la fantasia romanzesca degli storici, per venire finalmente a Karl August Wittfogel, che tuttavia non fu semplicemente uno storico, anzi fu ben altro che uno storico. Fu allo stesso tempo storico, filosofo e sociologo. Ce n’era di gente così a cavallo tra l’Otto e il Novecento. Anche Marx era uno di costoro: la storia è storia delle lotte di classe, uno spettro s’aggira per l’Europa, finem historiae, il comunismo primitivo, roba kolossal. Un altro era Oswald Spengler: l’Occidente al tramonto, la danza e contraddanza delle civiltà. C’era poi Johann Jakob Bachofen, giurista e antropologo, oltre che storico: decretò ab origine una società matriarcale, da cui le moderne società patriarcali derivano, frutto di preistorici tumulti «men-lib». Non dimentichiamo Freud, appena citato: ribattezzata l’anima «inconscio», ne fece una barretta di pongo plasmata dai palpeggi delle esperienze traumatiche, e con l’inconscio tutto acquistava senso, lo stesso senso, dall’edificazione delle piramidi al motto di spirito, dai sogni al sorriso della Gioconda.
 Erano filosofi, costoro e costruttori di cattedrali. Ce sono ancora, anche oggi, di simili pensatori in cinerama che proiettano le loro elaborate e barocche teorie fantasy su vasti – tra loro dissimili, e spesso (per non dire sempre) incompatibili – schermi accademici. Sono pensatori senza rete. Con un solo sguardo, e una sola idea fissa, abbracciano ogni orizzonte e spiegano ogni cosa. Ma sono talenti sempre più rari, e nessuno vale i primi della specie. Altro, e molto peggio, che viaggiatori nel tempo: il tempo sono loro.
Erano filosofi, costoro e costruttori di cattedrali. Ce sono ancora, anche oggi, di simili pensatori in cinerama che proiettano le loro elaborate e barocche teorie fantasy su vasti – tra loro dissimili, e spesso (per non dire sempre) incompatibili – schermi accademici. Sono pensatori senza rete. Con un solo sguardo, e una sola idea fissa, abbracciano ogni orizzonte e spiegano ogni cosa. Ma sono talenti sempre più rari, e nessuno vale i primi della specie. Altro, e molto peggio, che viaggiatori nel tempo: il tempo sono loro.
Quanto a me, personalmente sono un fan di questi pifferai di Hammelin del piffero (ci vuole poco, come dimostrano queste pagine, a incantarmi). Si può capire che mi appassioni allo strano caso illustrato da R.L. Stevenson. Ma cosa ci trovi, onestamente parlando, in Karl August Wittfogel, teorico grossier, prosatore noioso? Ci trovo, ci trovo. In primis l’enormità.
Raccolgo queste opere monumentali e talvolta le apro a caso, come faceva Betteredge – il maggiordomo della Pietra di luna (The Moonstone) di Wilkie Collins, un romanzo del 1868 – con La vita e le avventure di Robinson Crusoe, che consultava come l’I Ching, per aprirsi la strada a colpi di machete attraverso la giungla dei giorni. Più in piccolo, io cerco le citazioni di cui sono goloso, sia per hobby sia per lavoro (fossi un porco, non le chiamerei citazioni ma perle, che per l’uso che ne faccio siamo lì). In queste opere, oltre alle seduzioni spicciole, dico le frasi tirabaci, da biscotto della fortuna, colleziono e ammiro le visioni iperboliche, i concetti spropositati, che svettano alte come grattacieli, o minacciose come mulini a vento agli occhi dell’hidalgo, sulle culture del loro tempo, negandole ed esaltandole insieme.
 Wittfogel, lui, cominciò da drammaturgo nel primo dopoguerra. Fu membro del KPD, il partito comunista tedesco, quando il comunismo poteva sembrare ancora un’avventura (ma chi aveva la testa sul collo sapeva perfettamente che già non lo era più, e che anzi non lo era mai stata). Prese in fretta le distanze. Comunista di sinistra, conseguì un dottorato in sinologia. Rimanendo sempre un drammaturgo, e sempre sedotto dall’idea che cambiare il mondo poteva essere, chissà, «la più grande delle avventure», come la morte secondo Peter Pan, Wittfogel aderì alla Scuola di Francoforte intanto che scopriva l’Asia e il suo enigma. Perché libertà e diritto in Asia non facevano problema? Perché i khanati? Perché il modo di produzione asiatico, come l’aveva battezzato Marx, non funzionava in maniera razionale ma era un affare curvo, gobbo, sadomaso: schiavitù, lavoro servile, la frusta, le caste, il bushido, la pelata e i colori di guerra di Marlon Brando-Kurtz in Apocalypse Now, poi l’occhio torvo di Martin Sheen che emerge dalle acque del Mekong e (aritanga) «l’orrore! l’orrore!»
Wittfogel, lui, cominciò da drammaturgo nel primo dopoguerra. Fu membro del KPD, il partito comunista tedesco, quando il comunismo poteva sembrare ancora un’avventura (ma chi aveva la testa sul collo sapeva perfettamente che già non lo era più, e che anzi non lo era mai stata). Prese in fretta le distanze. Comunista di sinistra, conseguì un dottorato in sinologia. Rimanendo sempre un drammaturgo, e sempre sedotto dall’idea che cambiare il mondo poteva essere, chissà, «la più grande delle avventure», come la morte secondo Peter Pan, Wittfogel aderì alla Scuola di Francoforte intanto che scopriva l’Asia e il suo enigma. Perché libertà e diritto in Asia non facevano problema? Perché i khanati? Perché il modo di produzione asiatico, come l’aveva battezzato Marx, non funzionava in maniera razionale ma era un affare curvo, gobbo, sadomaso: schiavitù, lavoro servile, la frusta, le caste, il bushido, la pelata e i colori di guerra di Marlon Brando-Kurtz in Apocalypse Now, poi l’occhio torvo di Martin Sheen che emerge dalle acque del Mekong e (aritanga) «l’orrore! l’orrore!»
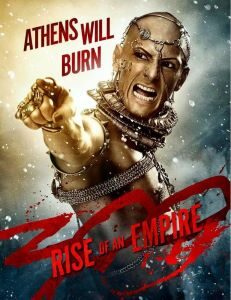 Wittfogel comprese che, dopo la prima, per numerare così la natura umana, era doppia anche la seconda natura, quella sociale, e che le comunità umane potevano essere distanti tra loro quanto Jekyll e Hyde. Già lo sapevano i greci, che una cosa sono le libere assemblee, un’altra i Gulag e le mandrie umane, una cosa l’Oriente, tutt’altra l’Occidente, di là Putin e noi di qua. Capì questo da comunista di sinistra: aveva visto avanzare Hyde in Occidente, prima via Comintern e movimenti operai filobolscevichi, poi via Wehrmacht, SS ed Einsatzgruppen a caccia di giudei. Era in corso l’ennesimo tentativo d’invasione, l’Orda d’Oro, i Turchi a Vienna, oggi Putin nel Donbass. Eravamo di nuovo lì, pensò forse Wittfogel (di sicuro non saprei, mica c’ero, ma lo credo). Eccoci, pensò, di nuovo a un passo dalle Termopili, minacciati dal Grande Re, come sempre deciso a estendere il suo Impero, infettandoci con la peste del suo modello sociale.
Wittfogel comprese che, dopo la prima, per numerare così la natura umana, era doppia anche la seconda natura, quella sociale, e che le comunità umane potevano essere distanti tra loro quanto Jekyll e Hyde. Già lo sapevano i greci, che una cosa sono le libere assemblee, un’altra i Gulag e le mandrie umane, una cosa l’Oriente, tutt’altra l’Occidente, di là Putin e noi di qua. Capì questo da comunista di sinistra: aveva visto avanzare Hyde in Occidente, prima via Comintern e movimenti operai filobolscevichi, poi via Wehrmacht, SS ed Einsatzgruppen a caccia di giudei. Era in corso l’ennesimo tentativo d’invasione, l’Orda d’Oro, i Turchi a Vienna, oggi Putin nel Donbass. Eravamo di nuovo lì, pensò forse Wittfogel (di sicuro non saprei, mica c’ero, ma lo credo). Eccoci, pensò, di nuovo a un passo dalle Termopili, minacciati dal Grande Re, come sempre deciso a estendere il suo Impero, infettandoci con la peste del suo modello sociale.
Quel vale per Jekyll, sempre sotto il bando di Hyde, vale anche per le società aperte, a loro volta minacciate da brutti e cattivi, dai fondamentalismi religiosi, sociali e socialreligiosi. Wittfogel lo sapeva, come lo sapeva Stevenson, ma lo sappiamo, per istinto, anche tutti noi: la possibilità della catastrofe ci scorre nel sangue, e semina memi ideologicamente mortali nelle nostre culture, specie le più progressiste, dove si nascondono meglio, agghindate da retto pensiero, woke, politically correct.
 È a questo, d’altra parte, che servono le metafore: ad aprire gli occhi quando le cose si fanno confuse. Mai state così confuse, a memoria d’uomo e d’elefante, come nella seconda parte del secolo breve, che caduto il comunismo avrebbe dovuto chiudersi lì, bon, la storia è finita, ma che invece s’allunga nel XXI secolo, alimentandosi di social, guerre sante, cancel culture, brutti film, talk show. Non so se le metafore, oggi, possono erigere barricate abbastanza alte da scoraggiare gl’Imperi dell’Acqua, come li descrive (ma è un’altra storia) Wittofogel, e da esorcizzare le mattane cannibali di Mr. Hyde.
È a questo, d’altra parte, che servono le metafore: ad aprire gli occhi quando le cose si fanno confuse. Mai state così confuse, a memoria d’uomo e d’elefante, come nella seconda parte del secolo breve, che caduto il comunismo avrebbe dovuto chiudersi lì, bon, la storia è finita, ma che invece s’allunga nel XXI secolo, alimentandosi di social, guerre sante, cancel culture, brutti film, talk show. Non so se le metafore, oggi, possono erigere barricate abbastanza alte da scoraggiare gl’Imperi dell’Acqua, come li descrive (ma è un’altra storia) Wittofogel, e da esorcizzare le mattane cannibali di Mr. Hyde.
Circolano, temo, pochi libri giusti, e con giusti non intendo i buoni autori né i buoni titoli, ma i formati, le edizioni giuste. Quand’ero bambino, negli anni cinquanta e primi sessanta, c’erano collane specializzate nelle edizioni ridotte dei classici della letteratura: Taras Bulba, I viaggi di Gulliver, Tartarino, Senza famiglia, Pel di carota, L’ultimo dei Mohicani, I miserabili, Il piccolo Lord, Moby Dick, Ivanhoe, Il giro del mondo in ottanta giorni, I ragazzi della Via Paal, Zanna bianca, David Copperfield, Le avventure di Tom Sawyer. Erano libretti smilzi, facilmente leggibili, tirati un po’ via, qualche incertezza sui congiuntivi ma niente fuffa letteraria. Da passarci in perfetto relax pomeriggi interi. Erano edizioni Bemporad, o Bemporad-Marzocco, se ricordo bene, ma di sicuro ce n’erano anche altre edizioni che mi sono scordato. Erano stampati su cartaccia. Costavano due lire, oppure li potevi prendere a prestito, se eri un bambino buono, dalle biblioteche di classe, all’epoca molto fornite (dagli stessi scolaretti, che mettevano qualche loro libro a disposizione). Io ne avevo per casa pile alte mezzo metro da terra. C’erano, ricordo di preciso, anche le edizioni ridotte di tutti o quasi tutti (non so) i romanzi d’Emilio Salgàri, che non ho mai capito se mi piacesse o no, ma più no che sì. Epurato dall’aggettivazione troppo esclamativa, ripulito, igienizzato, sfrondato della prosopopea da osteria, Salgari ci guadagnava parecchio. C’era qualcosa di doppio, a pensarci, anche in lui, per tornare da dove siamo partiti una o due digressioni fa: Emilio Jekyll era uno scrittore che anelava a rispettabilità e quieto vivere, mentre Emilio Hyde anelava ai bagordi esotici e i suoi personaggi erano tutti killer e massacratori.
Fumetti e film a parte, è certamente in edizione ridotta – su qualche panchina ai giardinetti di Piazza Cavour, a Torino, o in qualche viale alberato di Alassio, o Diano Marina, nelle lunghe estati dell’Italia miracolata dal boom – che ho letto per la prima volta il romanzo di Stevenson. Avrei letto volentieri e con profitto, sempre in edizione ridotta, anche Il dispotismo orientale del professor Wittfogel, se qualcuno avesse provveduto a metterne in commercio una sintesi per piccoli bibliomani, ma niente, Bemporad o Bemporad-Marzocco non ci hanno mai pensato, e così m’è toccato spiluccare poche pagine qua e là (teleportandomi spesso da un capitolo all’altro) parecchi anni dopo, scoraggiato dall’impianto troppo dottoreggiante. Non so cosa ne avrei concluso, riguardo a nature prime e seconde, ma qualche bislacca idea da nerd sociologico mi sarebbe venuta.
Tutti parlavano malissimo, e lo fanno ancora, pomposi e incompetenti, delle edizioni ridotte, rovina dei giovani, e oggi infatti non se ne scrivono né se ne ristampano più. Ci sono, in compenso, edizioni per giovani e giovanissimi con su la scritta in caratteri boriosi e soddisfatti «edizione integrale». Fai e fai, i ridottofobi hanno ottenuto quel che volevano: che nessuno dai sei anni in su sappia più leggere niente di buono o di utile, e soprattutto niente di più complicato di Gianni Rodari. Vien da piangere a leggere i titoli dei libri che la scuola consiglia ai bambini. Ne citerei qualcuno, come per esempio Gli adoratori del ragù d’alga, o Le mitiche avventure di Capitan Mutanda, ma mi viene il magone e rinuncio.
Abolito il mercato delle edizioni ridotte dal piano quinquennale delle edizioni integrali e dei libriminchia, perché non consigliare ai giovani la lettura di buoni, solidi fumetti, diciamo Tex Willer, ranger e capo navajo? A me da bambino, quando cioè avrei dovuto leggerlo come facevano tutti, m’era un po’ sfuggito. Conoscevo in pratica giusto i primi dieci-dodici volumetti, da La mano rossa al Figlio di Tex. Avrei rimediato a New York, quattro o cinque anni fa. Era primavera, e niente, dice Meg Ryan in C’è posta per te, «è come New York in primavera». Avevo scaricato sull’iPad, prima di partire, l’intera collezione di Tex, 600 volumetti e più, e me li lessi tutti, dal primo all’ultimo, dove vivevo, nella 98th, e sulle panchine del Central Park. Un pomeriggio, mentre leggevo Tex Willer, Danny Aiello (o qualcuno che gli somigliava molto) sedette nella panchina accanto alla mia.