Questa intervista è la trascrizione di una lunga chiacchierata con un archeologo molto conosciuto in ambito specialistico, in particolare per i suoi studi di archeologia della produzione, archeologia teorica e metodologia della ricerca.
Membro dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale di Genova, Enrico Giannichedda ha condotto ricerche in varie regioni italiane e insegnato, come docente a contratto, in numerose università. Fra i suoi lavori a stampa: “Archeologia della produzione”, insieme a Tiziano Mannoni (Einaudi, Torino, 1996, ma anche Barcellona 2004), “Uomini e cose. Appunti di archeologia” (Edipuglia, Bari 2006), “Archeologia teorica” (Carocci, Roma 2002, e 2016 per un’edizione ampliata), “Quasi giallo. Romanzo di archeologia” (Edipuglia, Bari 2018), “Fulmini e spazzatura. Classificare in archeologia” (Edipuglia, Bari 2021).
È appena uscito, sempre per Edipuglia, Il tesoro di Dorak. Archeo inchiesta, un saggio su un controverso (e forse mai avvenuto) ritrovamento archeologico: un gruppo di oggetti provenienti da Dorak (Turchia nord-occidentale), simili a quelli della Troia di Schliemann, che furono pubblicati nel 1959 dall’archeologo inglese James Mellaart.
Giannichedda si definisce uno studioso borderline, non so se per modestia o per il fatto di non occupare ruoli istituzionali. Se, effettivamente, si muove sulle linee di confine dello sfaccettato (e ignoto ai piú) mondo dell’archeologia contemporanea, forse è anche per scelta, perchè da lí è piú facile non prendersi troppo sul serio e osservare quel mondo curioso, imprevedibile, profondo e superfluo nello stesso tempo. E ogni tanto attraversarlo con qualche linea diagonale ben tracciata.
Quest’intervista vale appunto come un’incursione rapida e diagonale nell’archeologia “tout court”: leggera, libera e un po’ naïf.
Una volta ti ho sentito dire, alla domanda “Cos’hai trovato nell’archeologia?”: “Ho trovato me stesso”. Puoi spiegare meglio questa affermazione?
L’ho detto un po’ perché suonava bene come risposta, un po’ perché è vero. Ho detto “me stesso” pensando a una forma di realizzazione, non economica, e di autostima. Ma non credo che se uno domani mi togliesse l’archeologia, o l’archeologia di questi ultimi 10 anni o 20 anni, diventerei una persona che non si piace più.
Senza l’archeologia saresti diverso?
Sicuramente sì. Tutti quelli che fanno archeologia se vanno in giro, ad esempio in un centro storico, fanno caso a qualcosa che altri non notano, anche senza guardare nel dettaglio le stratigrafie murarie. Un qualche modus operandi o “pensandi” si è radicato. Uno sguardo diverso, una consapevolezza differente verso le cose, le case, che hanno dentro dei pezzi di storia. Ovviamente analoga considerazione vale se, anziché muoverci in una città, ragionassimo di altri territori di qualsivoglia natura. Però sto dicendo parole che stanno un po’ nella mezza retorica; le apprezzerei se le dicesse un altro, mentre io vorrei dirne di più intelligenti.
A cosa serve l’archeologia? Immagina che la domanda ti venga posta non da un’archeologa, ma da qualcuno che incontri per caso, in coda dal panettiere, con un tono un po’ irritato.
A niente. Penso che l’archeologia non serva a niente. È una di quelle cose di cui si può fare a meno, come tante altre: il bagno in mare, la cioccolata fondente, i viaggi per godere di posti belli, la musica. A niente.
Cosa rimane, quindi, che serve? Mangiare, dormire, …
Rimangono le cose che probabilmente rendono felice il signore che ha fatto la siffatta domanda. Forse però gli verrà in mente che ogni tanto un pezzo di cioccolata se la mangia anche lui e forse fa anche molte altre cose che non hanno una utilità pratica, immediata…
Ma se invece la domanda fosse sincera e non provocatoria, se te la facesse uno che davvero non sa a cosa serve, cosa risponderesti?
Gli risponderei in maniera probabilmente retorica: l’archeologia serve per costruire la storia, non la nostra ma piuttosto la storia di tutti, soprattutto la storia di quelli che non sono come noi. Conoscere il passato ci aiuta a immaginare che possono esistere dei futuri diversi da quello che possiamo ipotizzare guardando solo all’oggi. L’oggi ci fa pensare che il futuro sarà soltanto mercato: case migliori, telefoni più performanti, macchine più potenti. Ovviamente, non per tutti; ma questo è un dettaglio e poco importa a chi sta dal lato giusto della barricata. L’archeologia ci mostra che ci sono modi di vivere alternativi, non sappiamo se parimenti felici, forse anche più felici. Modi alternativi di vivere con le cose, e con le cose in relazione ad altre persone. Questa è la risposta che darei a uno onesto ma anche tanto ingenuo da accettare una risposta di questo tipo. Però in realtà penso che l’archeologia non serva. O, anticipo le critiche, serve per cose che si potrebbero ottenere anche in altri modi; ad esempio muovendo le masse turistiche verso parchi giochi anziché verso aree archeologiche nella medesima logica del pane et circenses.
 Dalla tua risposta – l’archeologia ci mostra modi di vivere alternativi – sembra che l’archeologia non sia tanto diversa dall’etnologia: lo studio di comunità diverse da noi. L’archeologia si occupa in prevalenza di comunità che non ci sono più, ma se lo scopo è conoscere modi di vita alternativi, è davvero necessario anche il passato remoto? Perché studiare anche le società, i paesaggi, la cultura materiale del passato?
Dalla tua risposta – l’archeologia ci mostra modi di vivere alternativi – sembra che l’archeologia non sia tanto diversa dall’etnologia: lo studio di comunità diverse da noi. L’archeologia si occupa in prevalenza di comunità che non ci sono più, ma se lo scopo è conoscere modi di vita alternativi, è davvero necessario anche il passato remoto? Perché studiare anche le società, i paesaggi, la cultura materiale del passato?
- Si potrebbe rispondere in due modi. Il primo è che lo studio delle società del passato ci può chiarire delle modalità di uso del territorio, ad esempio delle conoscenze specifiche di materiali naturali, a cui non arriveremmo se non avessimo l’esempio degli antichi. Gli esempi al riguardo potrebbero essere numerosi. Lo stesso vale sul fronte dell’arte, e con meno evidenza in altri, ad esempio relativamente alle tecniche: gli stimoli che riceviamo da reperti archeologici di determinati tipi, non penso solo all’arte classica, possono essere rielaborati nelle società moderne o attuali, come è già successo con il Primitivismo, con Picasso. A riprova che l’archeologia rientra tra quelle discipline di cui si può fare a meno, però, dobbiamo ammettere che tante società attuali, sub-attuali o del passato non si preoccupavano di cosa era successo prima di loro se non in maniera mitica. Noi potremmo fare come loro ma, mi contraddico ancora una volta, in realtà servono, tutte queste discipline e il non rispettarne le partizioni fra l’una e l’altra, per sentirci parte di una comunità che non è solo l’attuale. Io non sarei quello che sono se non avessi un retroterra che, in qualche caso, è familiarmente palesato in qualche generazione, ma talvolta è maggiormente radicato nel tempo. Un ciliegio selvatico in un bosco spesso non è lì per caso, ma è la traccia residua di una storia ininterrotta che ha origini in un passato che è comunque il nostro.
O che noi abbiamo scelto di considerare nostro… A questo proposito, una storia bellissima è quella di Ishi, un nativo americano che, nel 1911, si presentò in una cittadina californiana e fu arrestato. Senza alcun motivo, semplicemente perché incongruo in un paese che si era messo alle spalle le guerre con gli Indiani ed era ormai ‘normalizzato’. A salvarlo giunsero degli antropologi e la storia, su cui non mi dilungo, è interessante perché è l’incontro fra vinti e vincitori, fra passato e futuro, fra chi decide di scrivere la storia di tutti e gli altri. Questo episodio, non a caso, accade in un periodo di formazione delle discipline antropologiche e archeologiche…
L’archeologia moderna è parte della cultura dell’età industriale, ha scritto Andrea Carandini. Pensi che nell’Antropocene, nell’era digitale, essa sparirà o saprà rinnovarsi?
Non lo so ma penso che dovremmo partire dall’idea che l’archeologia come la conosciamo è un’invenzione soprattutto occidentale. Ci sono posti dove non c’era o non c’è; pensiamo ad esempio ai restauri che si facevano in Cina, dove non c’era un’attenzione filologica come la intendiamo noi, ma si sostituivano i pezzi di un edificio antico nello stesso modo in cui si restaura la propria abitazione: per continuare a viverci, senza preoccuparsi di mantenere l’antico nelle sue forme esatte. Quindi, in futuro l’archeologia potrebbe non esistere più o esistere in forme completamente diverse. Forse una prospettiva credibile è che si torni alla “bella archeologia”, l’archeologia come storia dell’arte o ricerca di pezzi belli. Una volta costruita la trama storica a partire dai reperti di vita quotidiana e dagli insediamenti più comuni, può darsi che si apprezzeranno soltanto i musei e i siti che incassano, che fanno biglietti, quelli che creano l’evento.
Non dico che questo è ciò che voglio, anzi, ma non lo escluderei. Certamente c’è chi lavora in tale direzione.
Nell’opinione pubblica italiana l’archeologia è percepita in modo ambivalente: osannata da una parte (un lavoro affascinante, che porta alla scoperta di oggetti belli e civiltà scomparse) e dall’altra disprezzata (un lavoro parassita, inutile, in particolare in relazione a tutta l’archeologia da cantiere, quella che si interseca con i lavori pubblici e privati sul territorio). Facendo un confronto ardito, a me sembra che la duplicità di considerazione ricordi quella che nei sistemi sociali patriarcali molti hanno avuto e hanno della donna: “santa o puttana”. Nel caso della donna, la dicotomia si fonda sull’uso del corpo che quella donna fa. Il controllo del corpo femminile è la massima aspirazione dei sistemi di cui sopra; la donna non può usare come le pare il proprio corpo e tutto quello che passa attraverso (la sessualità, la procreazione, ecc). Non ti sembra che l’archeologia sia percepita, ugualmente, come santa e puttana? I resti materiali del passato – e l’uso che se ne fa – sono un po’ la controparte del corpo, nella nostra metafora.
Forse la metafora è ardita, sì, ma potrebbe essere utilmente rovesciata. Tu ipotizzi che l’archeologia “santa” sia quella dei ritrovamenti nobili, belli, meritevoli per l’opinione pubblica. E “puttana” quella che rompe le scatole bloccando i lavori pubblici, di urbanizzazione eccetera. Forse è il contrario: l’archeologia, spesso, sputtana i propri rinvenimenti migliori rendendoli eventi. Il rischio dei ritrovamenti molto notevoli è che vengano poi variamente sviliti del loro potenziale informativo proprio per offrirli a tutti, per metterli sul mercato come una merce qualsiasi. Mentre l’archeologia di scavo, che non arriva quasi mai all’opinione pubblica ma che costituisce la massa critica dei dati archeologici, forse la si potrebbe definire santa perché per lo più finisce nei magazzini, per pochi addetti al culto i quali spesso non si preoccupano di pubblicare o di rendere disponibili i dati, se mai ci fosse qualcuno interessato a conoscerli. Il problema vero, a mio avviso, è questo: mentre di fronte a un archivio cartaceo di 100.000 documenti, in costante crescita, nessun archivista si pone l’intento di leggerli tutti e di farne il regesto, l’archeologo pensa che per studiare un sito deve conservare e studiare tutti i materiali contenuti in tutte le cassette dei reperti, strato per strato, e questo santifica le testimonianze materiali. Gli archivi e le biblioteche sono luoghi di selezione, perché tutto non si può conservare né studiare; in archeologia è un po’ diverso.
Di recente, parlando in una conferenza, ho detto che avevo studiato una ventina di recipienti di un certo tipo, una persona è intervenuta e mi ha detto che forse avrei dovuto studiarne 200, e ovviamente avrebbe potuto dire 2000 o 200000. Certo, se ne avessi studiati 2000 sarebbe stato meglio che studiarne solo 20 ma non sarei sopravvissuto e, fino a prova contraria, avrei ottenuto i medesimi risultati di fronte all’obiettivo che mi ero posto con quel lavoro. Ovviamente, altre domande potevano necessitare studi più ampi, ma comunque finalizzati. Perché il limite siamo noi stessi e la legislazione che, in Italia, impone agli archeologi di essere accumulatori seriali, e conservatori acritici senza riflettere su cosa ciò comporti.
Quindi forse la metafora si potrebbe capovolgere. I grandi rinvenimenti spesso vengono un po’ sputtanati, nel senso che nel proporli al pubblico si abbassa il livello della comunicazione e così via. Mentre gli altri, per quanto comuni, vengono messi in una teca di cristallo (leggasi magazzini chiusi al pubblico e a potenziali studiosi) e restano nella disponibilità di un culto burocratizzato che si è affermato negli ultimi 50 anni in un numero limitato di paesi occidentali.
Una santificazione interna…
Una santificazione a uso del funzionario, del docente, del responsabile che tiene per sé i reperti e i dati come fossero reliquie. Penso sia capitato a molti archeologi di trovarsi in situazioni in cui uno ti dice: ti faccio vedere una cosa però non lo deve sapere nessuno perché la stiamo studiando, la studieremo in futuro. Ma, partecipe del gioco, tu sai benissimo che a volte nessuno sta studiando quel reperto o quel contesto. E sai che sarà pubblicato, nei casi migliori, solo dopo 20 o 30 anni dalla sua scoperta.
Penso che una parte del problema nasca dal non sapere né potere discriminare, perché la legge prevede che lo Stato debba farsi carico di tutti i siti e di tutti i reperti mobili. Di fronte a questa scelta legislativa l’archeologo interviene, almeno in teoria, ma non discrimina in modo critico perché tutto vale e dal calderone che ne deriva non se ne esce. L’archeologia, spesso, sa di naftalina, un sostitutivo laico dell’incenso.
 L’archeologia mainstream, quella della divulgazione, è fatta di grandi scoperte, emotività a fior di pelle, retorica della bellezza, orgoglio identitario; perché l’altra archeologia, quella che non è solo grandi scoperte e non è focalizzata su un determinato passato ma piuttosto guarda ai cambiamenti nel tempo, alla diacronia, non passa a livello di divulgazione? Colpa degli archeologi, del “sistema”, dei media che prediligono un’archeologia più innocua?
L’archeologia mainstream, quella della divulgazione, è fatta di grandi scoperte, emotività a fior di pelle, retorica della bellezza, orgoglio identitario; perché l’altra archeologia, quella che non è solo grandi scoperte e non è focalizzata su un determinato passato ma piuttosto guarda ai cambiamenti nel tempo, alla diacronia, non passa a livello di divulgazione? Colpa degli archeologi, del “sistema”, dei media che prediligono un’archeologia più innocua?
Non penso che ci sia qualcuno, un sistema, che abbia un piano. Chi ha un piano va in altre direzioni: valorizzare le risorse per un ricavo economico. Può essere giusto o sbagliato. Se fare un po’ di mercato avvicina delle persone a interessarsi a cose che altrimenti eviterebbero e procura loro un po’ di benessere, perché no. Se per ottenere questo risultato bisogna fare operazioni non corrette, solo di facciata, forse non è il massimo. Credo che l’archeologia che definivi puttana, quella di tutti i giorni, dei mille cantieri, dell’inedito, dello scavato non studiato, l’archeologia ripetitiva in cui si trovano più o meno sempre gli stessi oggetti, le stesse forme, gli stessi colori, simili in un luogo e in un altro, quell’archeologia lì avrebbe forza se le persone ‘comuni’ e interessate potessero prendere in mano gli oggetti e ragionarne. Se questo non accade, le sintesi che l’archeologo ne ricava probabilmente non appagano più di tanto. Inoltre, credo che sia inutile tentare di fare un’archeologia migliore se non ci sono delle persone migliori. Ad esempio, sono quasi 20 anni che è stato abolito lo studio della preistoria nelle scuole medie. Nelle elementari si studia una preistoria all’acqua di rose e ben poco attraente, dove i primitivi stanno nelle caverne. Questo fatto comporta che poi le persone non abbiano gli strumenti per apprezzare certe esposizioni museali e siano cieche di fronte a una realtà che si cerca poi di proporgli altrimenti. Ma a quel punto puoi solo proporgli lo scavo clamoroso, perché se racconti di un villaggio dell’età del Bronzo o di un insediamento neolitico, non ti capiscono. Non ti capiscono e si gireranno da un’altra parte, se non sono state educate alla complessità dei periodi.
L’archeologia è un po’ isolata rispetto alle altre discipline? Che uno storico, un antropologo, vada a leggere le pubblicazioni degli archeologi per trarne dati e confronti per le sue ricerche è più raro del contrario. Ernst Gombrich, lamentando l’isolamento degli studi di storia dell’arte, nel 1963 scriveva di essersi posto il compito di “formulare i risultati delle proprie ricerche in maniera che non abbiano un carattere ultraspecialistico, idiosincratico, o esoterico, ma siano accessibili ai colleghi di altre discipline, così come noi stessi desideriamo poterci valere di quanto è accessibile a noi nelle scoperte loro”.
Gli altri studiosi leggono gli archeologi? Se li leggono li capiscono o gli archeologi scrivono in un modo che si capiscono solo tra di loro?
Secondo me il passaggio debole non è come scrivono gli archeologi, ma il fatto che molti non tentano di passare dal proprio scavo, dall’analisi dei reperti e delle testimonianze a una qualche sintesi storico-archeologica. Anche se forse non è giusto essere troppo pessimisti: per tanti macro-temi (ad esempio l’altomedioevo, la storia dell’alimentazione, la protostoria) penso che il lavoro degli archeologi ha dato dei frutti di cui gli altri non possono fare a meno e non hanno fatto a meno. È che forse manca questo momento intermedio tra l’analisi puntuale del singolo sito e la grande sintesi; mancano delle storie archeologiche a base regionale, intermedia, in cui le competenze dell’archeologo riescono a fare la storia di territori e di periodi abbastanza lunghi. Ne esistono, ma talvolta l’archeologo si ferma un passetto prima.
Secondo te è per questo che gli archeologi non vengono mai invitati ai festival di cultura generale ma quasi soltanto agli eventi connotati specialisticamente, a differenza di storici, antropologi, sociologi, …? Si potrebbe porre la stessa domanda anche facendo un altro esempio: perché nelle librerie il settore Archeologia spesso non esiste o è ridotto al minimo nella sezione iniziale di Storia antica?
Secondo me ci sono molte ragioni. Ad esempio, non c’è una tradizione in quella direzione. Gli archeologi giovani che vogliono far carriera sanno che la divulgazione, anche la divulgazione alta, non paga. Preferiscono scrivere un saggio per un editore che pubblica poche copie a prezzi alti e che nessuno legge, piuttosto che uno scritto in cui ci si mette in gioco per un pubblico più ampio. Nella classifica italiana dei libri più venduti l’archeologia non compare mai, se non qualcosa legato alla famiglia Angela ma in quel caso ad attirare non è il tema ma l’autore e la proposta televisiva che è associata. Gli archeologi si mettono raramente in gioco, non paga per la carriera.
Ma quello non paga neanche nelle altre discipline, tutto sommato.
Però forse nelle altre c’è una tradizione. In Italia credo che i principali giornali non abbiano un archeologo di riferimento. Di fronte a una notizia, intervistano qualcuno di spicco. Pensiamo alla polemica sul Papiro di Artemidoro; i giornalisti hanno intervistato chi una parte chi quella opposta, rappresentate dai due studiosi di riferimento che avevano nelle proprie rubriche telefoniche [Luciano Canfora e Salvatore Settis, ndr]. Due studiosi importantissimi ma nessuno dei quali è davvero un archeologo. Ovviamente, almeno per come io intenda l’archeologia.
 Prima hai parlato dell’archeologia ripetitiva o cumulativa che porta al ritrovamento più o meno sempre degli stessi reperti e hai detto che quell’archeologia avrebbe più forza se le persone potessero prendere in mano gli oggetti e ragionarne. Questo mi fa venire in mente una cosa che hai scritto in un articolo, dove hai accennato allo “scandalo” che generano i materiali archeologici. Hai scritto che essi generano scandalo non solo quando sono raccolti abusivamente, senza rispettare le leggi; o quando giacciono inediti nei magazzini ma “generano scandalo quando riconosciamo che, con tutta evidenza, raccontano storie che non vorremmo rimanessero inascoltate. Storie che possono essere ricostruite, o perse definitivamente, a seconda dei modi in cui, nella società attuale, si interagisce con i manufatti”. Secondo te questo “scandalo” potrebbe diminuire permettendo anche a chi non è archeologo non solo di prenderne in mano i reperti – che sembra quasi una concessione feticista – ma anche di ragionarne e produrne storie? Lo scandalo è che, di fatto, solo pochi hanno la possibilità di produrre una forma di cultura a partire dai materiali?
Prima hai parlato dell’archeologia ripetitiva o cumulativa che porta al ritrovamento più o meno sempre degli stessi reperti e hai detto che quell’archeologia avrebbe più forza se le persone potessero prendere in mano gli oggetti e ragionarne. Questo mi fa venire in mente una cosa che hai scritto in un articolo, dove hai accennato allo “scandalo” che generano i materiali archeologici. Hai scritto che essi generano scandalo non solo quando sono raccolti abusivamente, senza rispettare le leggi; o quando giacciono inediti nei magazzini ma “generano scandalo quando riconosciamo che, con tutta evidenza, raccontano storie che non vorremmo rimanessero inascoltate. Storie che possono essere ricostruite, o perse definitivamente, a seconda dei modi in cui, nella società attuale, si interagisce con i manufatti”. Secondo te questo “scandalo” potrebbe diminuire permettendo anche a chi non è archeologo non solo di prenderne in mano i reperti – che sembra quasi una concessione feticista – ma anche di ragionarne e produrne storie? Lo scandalo è che, di fatto, solo pochi hanno la possibilità di produrre una forma di cultura a partire dai materiali?
Il termine scandalo non è da prendere alla lettera ma forse sì, in quel caso sarebbe minore. È ovvio che le competenze sono da riconoscere; non tutti possono fare tutto e lo studio dei reperti archeologici necessita competenze non comuni. Questo però non vuol dire che le persone non potrebbero avvicinarsi a un’archeologia raccontata da un non-archeologo e un pochino più partecipata. Partecipata è un termine che è diventato di moda nell’archeologia pubblica, ma che spesso non è associato a progetti che colmano la distanza tra gli oggetti e le persone. I progetti di archeologia partecipata sono progetti in cui i non-archeologi hanno, quasi sempre, una posizione che è quella degli ascoltatori, degli utenti. Potrebbero forse avere dei ruoli più attivi. Come nelle scuole può esserci un erbario o un campionario di rocce del territorio, potrebbero esserci delle vetrine di pezzi antichi scelti appositamente che stimolano curiosità riguardo alla ceramica, alle macine, ecc. Forse con piccole iniziative come questa il distacco sarebbe minore.
Questo che dici rimanda alla questione dell’immagazzinare a oltranza tutti i reperti che vengono ritrovati. Di fronte al problema del futuro dei magazzini e dei musei, a una mole di reperti destinata ad aumentare, viene da chiedersi se potrebbero esistere alternative, legislative e culturali – o più che altro scelte parallele – a quella della statalizzazione indistinta di tutti i reperti.
La conservazione e la statalizzazione di tutti i reperti archeologici sicuramente determina problemi di ordine economico e gestionale e la necessità di risorse sempre maggiori per materiali per lo più inutilizzati. Inoltre, un oggetto o un contesto di oggetti non è salvo per sempre solo perché si trova in un museo. Basti pensare al saccheggio del museo di Baghdad o ai saccheggi di cui già si parla in Ucraina.
Al di là delle situazioni limite – i reperti archeologici danneggiati e rubati – certi oggetti, di determinati periodi o categorie, possono essere declassati, cioè tolti da una collezione museale e riposti nuovamente nei magazzini, magari a favore di altri. Secondo te si possono riconoscere dei trend di moda anche per i reperti archeologici?
Stiamo parlando a ruota libera senza dei dati specifici a supporto, ma pensiamo al caso in cui tantissimi musei sono stati alleggeriti del numero di pezzi esposti, nell’idea che un numero minore consentisse al visitatore una maggiore leggibilità e comprensione. Dove c’erano 100 selci se ne sono esposte 5 o 20 significative. È una scelta. Così come quella di non esporre i reperti di ferro perché si corrodono, i reperti organici perché richiedono un micro ambiente che ne garantisca la conservazione. Per cui sì, le selezioni nell’esposizione si fanno, inevitabilmente. Però magari non lo si esplicita. Anche nei musei storico-artistici non si dice che ci sono altri 1000 quadri nei depositi, si mostra quel che si ritiene di dover mostrare mentre i depositi sono a uso e consumo degli addetti.
Chi visita un museo archeologico rimane deluso?
Ma chi va nei musei archeologici?
 Ecco, chi ci va? Chi porta i figli piccoli pensa che il museo archeologico restituisca una qualche esperienza morale?
Ecco, chi ci va? Chi porta i figli piccoli pensa che il museo archeologico restituisca una qualche esperienza morale?
Io ci vado quando sono in viaggio, quando sono in un posto dove non sono mai stato, perché è un modo per conoscere un pezzo di storia. Penso che tanti turisti facciano la stessa cosa; nei casi dei grandi musei come il Louvre, mettersi in coda per entrare è una cosa che va fatta, perché la fanno gli altri. Che poi le persone siano soddisfatte o meno non so, dipende dai motivi per cui ci vanno. Esistono sulla questione certamente moltissimi studi sulla base di questionari museali che registrano un po’ di risposte scritte più per compiacere chi propone il questionario che per fare osservazioni critiche. I musei dovrebbero essere luoghi di conservazione della memoria e anche di ricerca, dovrebbero suscitare curiosità più che felicità o appagamento. Però credo sia difficile che uno esca da un museo archeologico con l’idea di approfondire, a meno che non sia già impallinato su un determinato argomento. Ovviamente con tutte le eccezioni dl caso che, però, restano per l’appunto eccezioni.
I modi di allestimento dei musei archeologi forse non sono cambiati poi così tanto rispetto a un secolo fa: il visitatore medio si trova davanti a una sequenza di oggetti e reperti che, seppur incastonati in una contestualizzazione di superficie, non riesce a guardare con occhi tanto diversi da quelli che posa su un dipinto. Forse il nostro approccio visuale resta prevalentemente estetico.
Anche perché la storia che viene raccontata, la stessa didascalia, non permette di immaginarci nella condizione di tenere in mano il reperto (cosa che non si può fare per ragioni di tutela). La didascalia definisce l’oggetto, dice ad esempio “acciarino”; di alcuni oggetti descrive il motivo decorativo – se c’è – di altri magari la funzione; raramente ti stimola a pensare cosa significava avere un acciarino piuttosto che un fiammifero, o cosa significava cucinare con determinate pentole. Raramente sei messo nella condizione di capire davvero l’uso di quell’oggetto in associazione agli altri e al contesto in cui si viveva. Passi davanti a decine di pentole e le guardi come se fossero dei quadri, se sono decorate tanto più. Raramente nei musei si pongono domande ai visitatori e gli si forniscono risposte. Ricordo tante esposizioni di lingotti metallici e non mi sembra di non aver mai letto l’osservazione banale che quei lingotti non sarebbero dovuti arrivare a noi; erano predisposti per essere fusi in un lasso di tempo breve e forse la cosa da segnalare sarebbe: è successo qualcosa, perché non sono stati fusi? Perché le statue del ritrovamento di San Casciano dei Bagni di cui si è molto parlato, belle o brutte che siano, sono finite in una fossa e le persone del tempo non le hanno recuperate? Che cosa c’è in questo abbandono, probabilmente voluto? Più che la tipologia della singola statua, la domanda interessante potrebbe essere indirizzata al perché le hanno messe lì. Una domanda difficile, forse senza risposta, ma che può incuriosire. Come potrebbero incuriosire di più certi corredi funerari se fossero proposti insieme al ragionamento sul perché persone che avevano una certa disponibilità di beni hanno deciso di sacrificare o non utilizzarne più, una parte anche cospicua. Credo che normalmente alle persone non del mestiere non vengano raccontate le domande che l’archeologo si pone. Il caso di Ötzi, la mummia del Similaun, è forse il più evidente. Perché è morto? Per la freccia. Ma perché non l’hanno derubato degli oggetti che aveva? Già solo questa domanda potrebbe risultare interessante per qualsiasi visitatore. E così ci sono tanti casi. Nei musei spesso si racconta il come, si descrivono gli oggetti, li si data, ma non si ragiona dei perché. Perché li mettevano nelle tombe, perché sono interi o spezzati, perché ci sono delle cose e non altre. Ragionare sui perché è più difficile ma forse più interessante.
Anche sul perché oggi abbiamo scelto di esporli.
Anche. Spesso sono esposti i reperti più appaganti alla vista. Gli etnografi anni fa hanno scritto che esporre oggetti di legno tendenzialmente fa tristezza. Mentre un vaso di pietra o un falcetto di metallo può essere integro, l’oggetto di legno spesso è tarlato, polveroso, malandato e quindi sa solo di vecchio. Anche in archeologia il fatto di dover esporre cose che devono essere appariscenti fa sì che si scelga sempre nella stessa direzione. Al momento in cui devi raccontarlo a dei terzi, il pezzo bello funziona di più. Difficile che si espongano ossa animali, che belle non sono; o dei grandi carboni, per quanto possano raccontare una storia che a quel punto, però, dovresti provare a sviluppare anche con qualche artifizio narrativo o guardando a tecniche, comportamenti, saperi.
Oggi si parla molto di archeologia del presente, del contemporaneo. Ci sono archeologi che studiano gli oggetti persi dai migranti durante la traversata del Mediterraneo o nelle migrazioni dal Messico agli Stati Uniti: dispersi nei mari o rimasti sopra terra, non ancora sepolti. Un’archeologia spesso collegata a eventi drammatici e dove i manufatti suscitano necessariamente uno scandalo. Non c’è il rischio di sopravvalutare il potenziale informativo di quella cultura materiale scartata o dispersa (per volontà, per caso, per calamità sopraggiunte), volendo per forza vedere dati nello scarto emotivo che quegli oggetti ci suscitano?
Sì, da un certo punto di vista sì, a mio parere, ma l’aspetto emotivo è comunque un dato culturale. Permette di suscitare un interesse che altrimenti forse non ci sarebbe. Sono reperti che ci obbligano, se vogliamo ricostruirne la storia, ad occuparci anche di fonti extra-archeologiche strabordanti: le fotografie, i rilievi, i messaggi telefonici, i dati di archivio, la demografia attuale. Se pensiamo ai migranti, c’è tutto un mondo che documenta la stessa storia da punti di vista diversi; bisognerebbe guardare i registri delle capitanerie, i registri delle navi, le norme legislative, tutti elementi che determinano il ritrovamento di certi oggetti piuttosto che altri. Riguardo a situazioni complesse come le guerre mondiali, le testimonianze extra archeologiche sono numerosissime e quindi forse non vale più la regola che in archeologia spesso si dovrebbe adottare, quella di campionare quando non si può raccogliere tutto: ma come si fanno a campionare i proiettili della Seconda Guerra mondiale? Con quali criteri? Queste ricerche hanno tra i propri pregi quello di scandagliare dei metodi di raccolta dati che possono essere innovativi e di legare l’evidenza materiale a una storia già nota altrimenti. Mentre per il passato la storia è incognita, per il presente o sub-attuale la storia è, bene o male, nota: possiamo vedere come si concretizza nei materiali e quindi definire una teoria sul perché, ad esempio durante le migrazioni, le persone portano con sé determinate cose e non altre; una teoria che forse potrebbe valere, o bisogna valutare se può valere, per altre situazioni e categorie.
 Dopo molti anni di lavori sul campo, studi, scrittura di saggi e articoli, nel 2018 hai pubblicato un romanzo, Quasi giallo, dove la trama narrativa – un classico giallo con omicidi, ricatti, ma anche amicizie e sentimenti – si dipana in un dipartimento di archeologia, durante un seminario dedicato all’interpretazione di casi archeologici famosi. Hai scelto la forma narrativa perché ti sei reso conto che non riuscivi a dire quel che volevi in forma saggistica oppure perché volevi rivolgerti a un pubblico non strettamente archeologico?
Dopo molti anni di lavori sul campo, studi, scrittura di saggi e articoli, nel 2018 hai pubblicato un romanzo, Quasi giallo, dove la trama narrativa – un classico giallo con omicidi, ricatti, ma anche amicizie e sentimenti – si dipana in un dipartimento di archeologia, durante un seminario dedicato all’interpretazione di casi archeologici famosi. Hai scelto la forma narrativa perché ti sei reso conto che non riuscivi a dire quel che volevi in forma saggistica oppure perché volevi rivolgerti a un pubblico non strettamente archeologico?
Entrambe le cose. Nella forma del romanzo pensavo di arrivare a più persone e ingenuamente credevo che sarebbe stato più semplice che scrivere un saggio corredato di note e bibliografia. Soprattutto pensavo che un saggio sull’argomento dell’interpretazione sarebbe interessato davvero a poche persone. Poi mi sono accorto che costruire un romanzo è parimenti faticoso… Però il romanzo consente in maniera più libera di contrapporre più voci e i personaggi rappresentano scelte, e possono fare cose, che non devi giustificare. Possono ad esempio azzardare interpretazioni che, come autore di un saggio, dovresti scrivere con maggior cautela, con dei distinguo e simili, mentre nel contesto narrativo le fai avanzare a qualcuno che non sei te, e quindi non ti assumi quella responsabilità. Puoi semplificare e rendere i concetti in maniera più diretta.
È un escamotage riuscito?
Non so, tanti archeologi hanno scritto romanzi e molti più illeggibili del mio.
Però Quasi giallo si distingue da altri romanzi in quanto è meta-archeologico: non ha solo un’ambientazione archeologica e personaggi che nella vita fanno gli archeologi, ma parla di archeologia, il tema portante è la questione interpretativa in archeologia…
Sì, gli altri di solito sono romanzi con ambientazione archeologica, come anche alcuni di Agatha Christie: c’è lo sfondo, ma di archeologico c’è poco. Con un libro di Agatha Christie, ad esempio Non c’è più scampo [Murder in Mesopotamia, 1936, ndr], se uno facesse l’esercizio letterario di cambiare ambientazione, e quindi anziché in uno scavo archeologico ambientarlo in una missione umanitaria o in un ospizio, il racconto funzionerebbe ugualmente bene, basterebbe cambiare gli elementi di contorno e le attività dei personaggi.
Secondo te sei stato preso meno sul serio dai colleghi, proprio perché questa storia dell’interpretazione l’hai raccontata sotto forma di finzione invece che di saggio?
Penso che basti guardare alle recensioni. Ne ho avute una decina, che tutto sommato è tanto. Un testo come Archeologia della produzione [un libro chiave nella letteratura archeologica italiana, pubblicato da T. Mannoni, E. Giannichedda nel 1996, Einaudi, ndr], spesso citato come un libro importante, non ha avuto quasi nessuna recensione. Quasi giallo molte di più, soprattutto da parte di blogger-archeologi, mentre quasi nessuno tra gli accademici ha ritenuto di scriverne, forse proprio per la forma oppure perché non erano interessati alla questione interpretazione. Penso che la scelta romanzo abbia funzionato perché ha dato una diffusione molto maggiore. Ma se fosse stato un saggio breve forse sarebbe stato adottato in qualche università, mentre attualmente credo non sia suggerito in quasi nessuna neanche come lettura eventuale: non perché è già passato qualche anno dalla pubblicazione – mediamente, in archeologia i libri di testo sono vecchi di qualche decina di anni – ma perché obbligherebbe i docenti a spendere due parole sul perché è scritto in quel modo.
Dopo Quasi giallo sei tornato alla saggistica e hai scritto un testo sul classificare in archeologia [Fulmini e spazzatura. Classificare in archeologia, 2021, ndr]: sul perché gli archeologi classificano i manufatti, e come, e sulla base di quali concetti e approcci; un libro che, anche, racconta di molti illustri classificatori, archeologi e non, e dei loro sistemi di pensiero. Un tema denso, complesso, da perderci un po’ la testa. Non hai avuto la tentazione di trattare l’argomento di nuovo in forma narrativa? Di mettere in scena un’archeologa tormentata e assai riflessiva che passa le sue giornate in un magazzino dei reperti e si domanda perché fa quello che fa in un modo piuttosto che in un altro…
Forse non ci ho pensato perché Quasi giallo e Fulmini e spazzatura hanno retroterra diversi. Quasi giallo è stato il tentativo di rendere leggibili delle tematiche che in quel momento credevo di padroneggiare abbastanza: come si interpretano le evidenze materiali. Il libro sul classificare è invece nato quando non ero ancora sufficientemente preparato sul tema; esso ha preso forma via via che approfondivo la questione. Paradossalmente, Quasi giallo è molto più cerebrale (mi si passi il termine), è un continuo discutere sulle testimonianze, mentre Fulmini e spazzatura parte da una situazione pratica, l’archeologo che mette le mani tra i reperti.
Classifichiamo per ridurre la complessità del reale, scrivi. Non la ridurremmo un po’ di più e meglio, questa complessità, se smettessimo di fare archeologia? La domanda è provocatoria. Ma non è un po’ folle che donne e uomini di questo tempo decidano di conservare, studiare, molto spesso addirittura (come prima cosa) disseppellire, manufatti ormai privi di ogni funzione, di restituire ad essi – in qualche modo – un ancoraggio alla realtà, a questa realtà contemporanea?
Sì, forse è un po’ folle, tant’è vero che da qualsiasi parte ci giriamo vediamo che quelli che si preoccupano di fare archeologia, di ricostruire il passato, sono una esigua minoranza. Essendo in qualche modo fra gli addetti ai lavori, noi conosciamo decine di archeologici e storici, ma chi non fa questo lavoro spesso non ha idea di cosa sia l’archeologia, non conosce nessun archeologo meno che mai celebre. Mentre conosce il nome di Sgarbi e lo collega alla storia dell’arte, o quello di Barbero alla storia medievale, non conosce un archeologo che potrebbe essere di riferimento per la comprensione del territorio in cui vive. Quindi si tratta di una disciplina che, volenti o nolenti, dobbiamo riconoscere di nicchia. Se prendiamo un romanzo a caso, non prevede quasi mai che i protagonisti si scontrino con le tracce materiali del passato remoto; vivono nel presente, pensano al futuro e fanno a meno dell’archeologia.
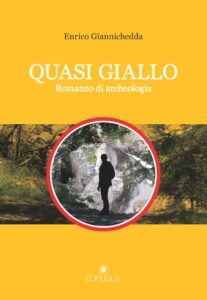 Beh, gli oggetti vecchi spesso sono usati come escamotage per rievocare il passato (una lettera, una fotografia o la madeleine proustiana) ma è più raro che un personaggio di finzione si metta alla ricerca della materialità perduta.
Beh, gli oggetti vecchi spesso sono usati come escamotage per rievocare il passato (una lettera, una fotografia o la madeleine proustiana) ma è più raro che un personaggio di finzione si metta alla ricerca della materialità perduta.
Il passato compare, la geografia e le vicende della famiglia sì, ma è difficile che ci sia un rimando esplicito all’archeologia o a un passato remoto che vada al di là di qualche generazione. La nostra memoria individuale, anche materiale, in genere è riassumibile in poche generazioni. Se non si appartiene a un casato aristocratico, le persone non sanno andare indietro oltre le 3-4 generazioni. Nonni, bisnonni e poi siamo nell’indeterminatezza.
Una minoranza però si butta in quella indeterminatezza…
Sì, perché quell’indeterminatezza a qualcuno interessa e perché c’è una società che riconosce, seppur pigramente, importanza e autorevolezza a studi che sarebbero evitabili. Si tratta comunque di una minoranza, talvolta rumorosa ma minoranza. Per la maggior parte delle persone l’archeologia è turismo. Se in spiaggia non si può stare perché c’è vento si va a vedere il sito archeologico nell’entroterra; lo si fa 15 giorni all’anno, un giorno su 100. O molto meno e talvolta solo in certe fasi della vita: durante le gite scolastiche, quando i media gridano all’evento o, per l’appunto, durante le vacanze.
È appena uscito un tuo nuovo saggio, direi meno impegnativo per il lettore rispetto a Fulmini e spazzatura, una “archeo inchiesta” su un controverso ritrovamento archeologico: il tesoro di Dorak (un gruppo di oggetti simili a quelli della Troia di Schliemann) di cui diede notizia nel 1959 James Mellaart, un importante archeologo inglese. Del tesoro si sono perse le tracce, rimangono soltanto i disegni di Mellaart; non si sa se sia effettivamente mai esistito. Le indagini, in primis delle autorità turche, non hanno chiarito la questione.
Cosa hai trovato di interessante in un archeologo molto discutibile come Mellaart?
Ho trovato tre aspetti interessanti. Primo, che un archeologo giovane e di potenziale prevedibile successo si sia infilato capo e collo in una vicenda dove qualsiasi persona di minimo buon senso avrebbe capito che ci si poteva solo fare male. Quando pubblica quel tesoro di cui forse ha inventato delle parti, o che forse ha inventato completamente, di cui come minimo non padroneggia le informazioni di base, Mellaart si infila in un prevedibile guaio. E questo mi ha incuriosito: perché una persona fa una cosa da cui è prevedibile tragga solo degli svantaggi. Come secondo motivo d’interesse, mi ha incuriosito il fatto che questi reperti hanno comunque contribuito alla storia delle conoscenze archeologiche per un cinquantennio e non sappiamo ancora se siano un pezzo della storia antica dell’Anatolia, oppure se siano elementi che inquinano, come tutti i falsi, la ricostruzione storica. Il terzo elemento è il fatto che Mellaart avrebbe dovuto essere espulso dal mondo accademico o difeso a oltranza, a seconda se si riteneva che fosse un pericoloso falsario o una vittima del comportamento illecito di altri. Questo, però, non è stato fatto. Si è, invece, messa a tacere la vicenda del tesoro e lo si è chiuso in un bozzolo dove ha continuato a insegnare. Addirittura a fare il professore di archeologia nell’università di Londra, non in un liceo di periferia. I suoi colleghi sono stati conniventi con quello che potevano pensare come un falsario o un incredibile ingenuo; in ogni caso sono stati conniventi.
Mellaart raccontò di aver incontrato, sul treno diretto a Smirne, una giovane e avvenente donna che indossava un particolare braccialetto d’oro. In risposta alle sue domande, la donna, di nome Anna Papastrati, avrebbe portato l’archeologo nella sua casa e gli avrebbe fatto vedere molti altri simili reperti antichi provenienti da Dorak: il tesoro, appunto. Secondo te Anna Papastrati è esistita?
La donna del treno è un po’ come le donne dei fumetti: talmente bella e desiderabile da sospettare che non sia mai esistita, che sia riconducibile a un sogno-miraggio. È la stessa donna che, se vera, conclude la lettera che invia anni dopo a Mellaart per autorizzarlo a pubblicare i reperti, con “Love, Anna”, forse prendendolo in giro o suggerendo la possibilità di una qualche relazione ignota ai più (Mellaart all’epoca era già sposato). È una donna che compare solo nel racconto che Mellaart fa della scoperta del tesoro e scompare senza lasciare tracce. Chi si è occupato della vicenda 50 anni fa non ha fatto le verifiche che andavano fatte. In ogni caso, la metterei tra gli incontri desiderabili ma non verosimili.
A te l’archeologia fa stare meglio?
Direi di sì, perché quando mi occupo di archeologia ho un modus operandi sufficientemente distaccato, per cui anche se mi altero non è mai l’archeologia a deludermi. Credo che l’archeologia sia una fra le discipline di possibile conforto. Se non si ragiona di soldi, che sono quasi sempre carenti, e di burocrazia, credo che sia una buona compagna di viaggio perché offre molteplici stimoli, ma quando è l’unica fonte di reddito la si vive probabilmente con maggiore difficoltà.
Chi legge penserà che tu sia un ereditiero o l’ennesimo archeologo dilettante.
Né l’uno né l’altro. Personalmente, ho trovato un modus operandi in archeologia che potrei definire borderline e di cui, dopo tanti anni, non mi lamento. Devo ammettere che nessuna Università mi ha voluto fra i propri docenti in pianta stabile e, non aspirando a ruoli da burocrate, mi sono dato da fare. E qualcosa ho fatto ma non spetta a me giudicarmi. Semmai dovrei ringraziare le tante persone che mi hanno aiutato a fare archeologia e a cui devo davvero molto. E comunque dilettante non è, di per sé, un termine disdicevole: colui che si diletta, e non è poco.




