di Mario Coglitore
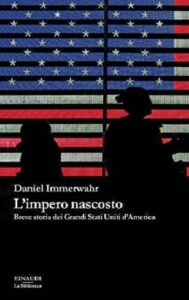 Daniel Immerwahr, L’impero nascosto. Breve storia dei Grandi Stati Uniti d’America, Einaudi, 2020, pp. 603, euro 34.
Daniel Immerwahr, L’impero nascosto. Breve storia dei Grandi Stati Uniti d’America, Einaudi, 2020, pp. 603, euro 34.
Ha scritto molto tempo fa Alfred Korzybski, ingegnere e matematico – a lui si deve la fondazione della cosiddetta Semantica generale –, che “la mappa non è il territorio”. Di più, sosteneva ancora Korzybski, anticipando di alcuni decenni le riflessioni dello stesso Foucault, “la parola non è la cosa” (Molto brevemente, per comprendere i fondamenti della General Semantics: secondo Korzybski gli esseri umani hanno dei limiti piuttosto consistenti nell’atto del conoscere il mondo a causa della struttura del loro sistema nervoso e dei loro linguaggi. La realtà viene essenzialmente sperimentata attraverso “astrazioni”, impressioni non verbali che provengono appunto dal sistema nervoso e che vengono poi portate alla coscienza e verbalizzate per mezzo della lingua che ciascuno di noi utilizza).
Questi due concetti si attagliano perfettamente all’analisi che Daniel Immerwahr ci propone nel suo corposo e vibrante saggio, interpolando i lemmi della storia, dell’economia, della politica e, buona ultima ma essenziale, della geografia, in un’opera di ampio respiro che a tratti è capace di sorprendere per la ricchezza delle informazioni e degli aneddoti forniti, tutti egualmente importanti per ricomporre le tessere del complicato puzzle che ci ritroviamo davanti a fine lettura.
Siamo abituati, nella nostra proiezione immaginativa, a far coincidere gli Stati Uniti con la mappa-logo, così la definisce l’autore, costituita dall’insieme degli Stati federati che confina a nord con il Canada, al sud con il Messico e a Ovest ed Est rispettivamente con l’oceano Atlantico e l’oceano Pacifico; dimenticando quasi sempre, sia detto en passant, l’Alaska che, troppo in alto forse per il nostro sguardo accidentato, sfugge nove volte su dieci alla corretta evidenza che pure lo rende una formale porzione degli States. La mappa rimanda visioni del territorio imperfette durante le quali si manifesta davvero l’assoluta distanza tra le parole e le cose, anche a causa, se vogliamo, della scarsa importanza che viene tradizionalmente attribuita alla geografia nella nostra cultura, e nell’apprendimento scolastico di ogni ordine e grado fino agli studi universitari.
Il significato complessivo che si ricava dal perspicuo studio di Immerwahr, a cui egli ha dedicato quasi una decina d’anni, emerge, pagina dopo pagina, sempre più evidente: la storia degli Stati Uniti, esemplare sotto molti punti vista tanto l’intero pianeta ne è stato condizionato e trasformato, da Oriente a Occidente senza soluzione di continuità, è storia di un impero mai formalmente riconosciuto e abilmente non caratterizzato dalle conquiste e annessioni colonialiste che vedono la luce con le prime avventure dei portoghesi, e poi degli olandesi e degli spagnoli, in terre d’oltremare invase e depredate senza tanti complimenti, sino alla fase coloniale tecnologico-economica otto e novecentesca così ben incarnata dalla spietata Gran Bretagna e dall’altrettanto intrusiva Francia, passando per Belgio, Germania e persino, in formato ridotto ma non per questo meno letale, Italia. È storia quella americana di un imperialismo diffuso e reticolare del quale, a tratti, si è cercato di delineare i contorni, tentando di far riemergere dalla secche della ricostruzione storica un “paesaggio” sottratto ai più e lasciando che il flusso degli eventi della storia mondiale percorresse i consueti, tradizionali percorsi; anche qui utilizzando l’aggettivo “americana” per identificare la mappa-logo di cui si diceva e prendendo una parte per il tutto, dato che il termine America dal punto di vista geografico non è assimilabile ai soli Stati Uniti. L’Impero statunitense rappresenta, in sostanza, un rimosso. Ma, secondo quanto ci ha insegnato Sigmund Freud, il rimosso tende a ritornare spesso come sintomo. Negare l’esistenza di questa “conformazione imperiale” ci impedisce di apprezzare alcune sensibili variazioni nelle vicende che sono occorse al pianeta negli ultimi duecento anni circa, determinando la nascita e lo sviluppo di pratiche economiche, militari, sociali e culturali capaci di cambiare il corso degli eventi, e di segnarne possibilità e tipicità.
Ritorniamo alla geografia e al fascino che esercitano le mappe. Sapremmo dire, senza pensarci su troppo, dov’è l’isola di Guam? O dove sono collocate esattamente le Hawai’i? Sapremmo indicare in un attimo, senza smarrirci nell’imprecisabile, dove si trovano Puerto Rico o le Isole Marianne settentrionali? Forse no. La mappa-logo ci costringe a puntare gli occhi soltanto lì dove la potenza territoriale degli Stati Uniti ha fatto bella mostra di sé in una mitopoiesi carica di genealogie addomesticate: lungo le carovane dei coloni che si spostavano verso il “favoloso” Far West, a totale detrimento della popolazione pellerossa gradualmente e implacabilmente messa in condizione di non nuocere e sterminata poco a poco, oppure lungo i binari della ferrovia – oggetto di altrettanta mitizzazione cui la cinematografia hollywoodiana contribuì esportandone l’immaginario simbolico ovunque – che congiunse i due oceani poc’anzi nominati. Praterie sterminate e branchi di cavalli selvaggi, mandrie di bisonti alla cui caccia spietata Buffalo Bill, prima di girare per l’Europa con il suo improbabile Circo, non si sottrasse, canyon sontuosi e imponenti, fiumi dal corso impetuoso e dalla straordinaria lunghezza e portata, e mille altre suggestioni colmano la nostra fantasia di incalliti occidentali.
La carta geografica declina la sostanza di un mezzo continente che già nelle premesse sembra contenere il futuro destino della grandezza delle sue genti di importazione, giunte dalla Vecchia Europa, incredibilmente più piccola e insignificante, e della missione cui la storia ha chiamato quel nuovo costrutto politico e culturale che, a tutt’oggi, per gli statunitensi è la “nazione” con la sua robusta e immarcescibile identità. Secondo Immerwahr è questo insieme di sollecitazioni socio-antropologiche che va messo in discussione. Ridisegnando la mappa, per l’appunto.
Per farlo, si tratterà di dare un’occhiata oltre i confini di terra e stabilire, se mai sarà possibile, quelli di mare. L’oceano Atlantico è stato oggetto di decine di opere letterarie, dai romanzi ai saggi, che ne hanno dipanato l’epica narrativa e le stagioni. Decisamente meno si parla del Pacifico, non fosse altro perché, probabilmente, non è identificato tout court con la storia dell’Occidente. Eppure è in quelle acque e tra quelle correnti, dentro alle quali si mosse la Pequod di Melville all’inseguimento di Moby Dick, che gli Stati Uniti hanno trovato la ragion d’essere del proprio affrancamento continentale verso una strategia insulare di tutto rispetto, agendo in una rete di isole grandi e piccole con conseguenze nella maggioranza dei casi tragiche, all’insegna del conflitto permanente e del sangue, sparso dappertutto.
Ci racconta, così, l’autore, delle guerre che hanno lacerato le Filippine, territorio dalla densità politica e militare rilevante e dallo sconcertante tasso di mortalità tra gli abitanti sottoposti prima al dominio spagnolo, di seguito a quello americano e giapponese, e infine di nuovo a quello americano; e ancora, costretti a feroci contrapposizioni tra gruppi di isolani accerchiati dal dominio di nazioni che si contendevano un territorio strategico, adagiato nel Sud-est asiatico da decenni teatro di aspre contese. Ma sono le isole minori del Pacifico a destare la maggior curiosità nel momento in cui esse diventano punti di torsione di una cartografia militare che dà sostanza al potere statunitense ben prima che il governo di Washington decidesse di partecipare alla Seconda guerra mondiale. Segnando il tempo della onnivora conquista di geografie e mercati, delle migliaia di morti in un esercito mandato a combattere su più fronti nel pianeta e di una spettacolarizzazione della violenza, culminata con i due tremendi ordigni nucleari sganciati sul Giappone ai primi d’agosto del 1945.
A tutto ciò fece seguito l’approntamento di un efficiente e compulsivo sistema tecnico-economico, le cui premesse datavano già dall’intervento durante la Prima guerra mondiale, che ha fatto del Novecento il “secolo americano”, come ha ben argomentato parecchi anni fa con grande dovizia di particolari Geminello Alvi1.
Spartiacque tra un prima e un dopo durante i quali idealmente si ricongiunsero meditati approcci a politica ed economia, esaltando una pervasiva logica del dominio – di altro non si può parlare in questo atlante del potere in cui sono state fatte scorrere al meglio le risorse, codificandole e ottimizzandole in funzione degli obiettivi prefissati –. la Seconda guerra mondiale ha contribuito ad espandere al massimo l’impero americano con una popolazione dei territori d’oltremare che in termini numerici superava di gran lunga, negli anni successivi alla fine delle ostilità, quella del continente. In questo raffinato dispositivo strategico l’influenza esercitata prescindeva dall’esistenza o meno di colonie e, anzi, un classico impianto coloniale avrebbe impedito lo sviluppo del complessivo assetto di controllo.
Furono alcune innovazioni introdotte a partire dalle esigenze belliche a fare la differenza. La prima, e più importante, fu lo sviluppo della tecnologia aerea; la seconda, certamente l’approntamento di basi militari. Il sistema di comunicazione che gli aerei garantiscono in termini di duttilità, efficacia, velocità e sicurezza – non dimentichiamo il radar la cui tecnologia fu sviluppata proprio in quello scenario bellico dagli stessi americani a sostegno delle flotte dei cieli – non ha paragoni con il trasporto via nave che ugualmente aveva reso possibile lo spostamento di persone e merci tra Ottocento e Novecento. Oltre al ruolo determinante che l’aereo ebbe sul piano militare per dar voce tonante a quella che potremmo chiamare la “filosofia” del bombardamento negli anni dal 1940 in poi, non dobbiamo trascurare il fatto che, al pari di ciò che è stato il treno per tutto il XIX secolo e oltre, l’aereonautica sarebbe diventata settore di punta dell’industria mondiale; in aggiunta, gli studi sulla tecnologia del volo avrebbero presto condotto alla realizzazione di vettori da spedire nello spazio o, molto prosaicamente, di testate missilistiche da lanciare contro il nemico, chiunque esso fosse, evitando di compromettere, o compromettendo molto meno, la sicurezza e l’incolumità degli esseri umani che si occupavano di quell’operazione.
Quanto alle “basi”, esse possono diventare totalmente indipendenti da rifornimenti via terra, costosi e molto spesso soggetti ai pericoli legati alla natura del terreno e alle sue insidie, e possono essere dislocate lontano dalla madrepatria, pur servendone gli scopi. L’aereo, d’altronde, garantisce proprio questo elemento fondamentale per la collocazione di una “base”, vale a dire il fatto che è in grado di coprire distanze molto ampie. E su questo giocarono, e giocano ancora, gli Stati Uniti istituendo quello che Immerwahr chiama l’Impero “puntillista”, soltanto in apparenza caratterizzato da un forte radicamento territoriale nel continente. Di puntino in puntino, grande e meno grande, la “disposizione imperiale” di piste d’atterraggio intorno alle quali fioriscono strutture logistiche interconnesse che diventano presto ampie come città alimenta la catena di controllo planetaria riverberando i suoi effetti perfino nel territorio che circonda la “base”, quando esso appartiene ad altra sovranità. Una buona parte delle attuali 800 installazioni militari statunitensi sparse nel globo lo dimostrano con relativa facilità, se appena pensiamo all’Italia di Aviano e alla micro-economia sorta attorno alla “base” laggiù attiva che prospera in virtù della presenza del personale americano in quell’area.
Non esclusivamente aerei, ci ricorda Immerwahr: ma anche elettronica, medicina, e persino cultura popolare; il “puntillismo” a stelle e strisce ha promosso opportunità scientifiche sostenute da solidi enti di ricerca e creato ex novo, o semplicemente modificato con la sua invasiva permanenza, interi ambienti sociali, inducendo evoluzioni e conseguenze del tutto particolari.
Dahran, Arabia Saudita; un posto dimenticato da Dio e dagli uomini. Negli anni Trenta del Novecento l’Aramco (conglomerata statunitense che comprende all’epoca Standard Oil, Texaco, Exxon e Mobil) si stabilisce tra quelle sabbie inospitali per estrarre petrolio con il permesso del governo locale. Vanno costruiti degli insediamenti per ospitare operai e personale tecnico e l’azienda americana se ne assume l’onere. Tra i manovali ce n’è uno particolarmente esperto e energico che non tarda a fiutare l’affare e a mettersi in proprio con il consenso del suo Paese e il gradimento dell’Aramco, fondando una piccola impresa di costruzioni. Muhammad Bin Laden entra nella lobby imprenditoriale giusta: molto petrolio, molti affari, molta espansione. Gli Stati Uniti premono affinché i Sauditi collaborino fattivamente, tenuto conto che considerano l’Arabia uno snodo centrale delle linee intercontinentali di trasporto. Dal 1945 al 1962 ottengono in affitto una grande base aerea a Dahran per la quale c’è bisogno di ulteriori lavori di costruzione, in piccola percentuale affidati al rampante Muhammad che inizia così una proficua collaborazione anche con gli americani a suon di lauti contratti più o meno ufficiali per non destare sospetti nel suo Re. Quando i rapporti con coloro che il popolo saudita considera di fatto “invasori” e per di più “infedeli” si fanno tesi e la concessione del terreno viene sospesa, l’esercito USA abbandona il luogo nel 1962. Ma Muhammad vola già alto e qualcuno dei suoi 54 figli se ne va a studiare direttamente negli Stati Uniti.
Alla sua morte nel 1967, alcuni dei rampolli si dedicano agli affari di famiglia per potenziare un’azienda che valeva già svariate centinaia di milioni di dollari. Tra loro spicca per impegno e dedizione il giovane Osama, che di questioni tecniche sembra capirci parecchio. Quando all’ingegneria dei materiali l’erede Bin Laden affianca anche la politica, la strada appare segnata. Contro l’imperialismo occidentale Osama si schiera fin da subito e non può sottrarsi all’appello che nel 1978 i Mujahidin lanciano a tutti i veri credenti dopo che l’Unione sovietica ha invaso l’Afghanistan. Arriva a Peshàwar vicino al confine afghano dove mette subito a frutto la sua perizia nello scavare tunnel e costruire strade; non gli mancano certo i mezzi, che fa affluire abbondanti in Pakistan, e la competenza. La jihad prende piede e chiama a raccolta i suoi devoti apostoli. Nel 1988 Osama fonda una piccola organizzazione per dirigere la sua guerra santa; la chiamerà al-Qaida al-Askariya che in arabo significa “la base militare” e più tardi sarà conosciuta semplicemente come al-Qaida, “la base”. Il resto della vicenda è abbastanza noto alle cronache. Quel che preme sottolineare qui, e che certo lascia interdetti, è la concatenazione di eventi che porta dal misconosciuto muratore analfabeta Muhammad, cresciuto professionalmente nel brodo di coltura promosso dagli Stati Uniti in quello specifico frangente della loro espansione “puntillista”, alla lotta di resistenza benedetta da Allah che il figlio Osama intraprende contro Mosca all’inizio della sua carriera di condottiero. In qualche modo, l’“Impero nascosto” ha colpito ancora.
Si veda Geminello Alvi, Il secolo americano, Milano, Adelphi, 1994. ↩



