di Francesco Festa
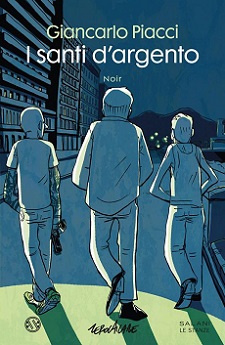 Giancarlo Piacci, I santi d’argento, Salani, 2022, pp. 334, € 16.00
Giancarlo Piacci, I santi d’argento, Salani, 2022, pp. 334, € 16.00
La lettura di un libro assai spesso viene pungolata o ispirata se non istradata da una colonna musicale. Prima di imbatterci nel ventre del romanzo, vale la pena di offrire qualche consiglio su come affiancarne la lettura. Di certo, un brano che ha ritmato, en pendant, l’incedere del testo, come un camminare onomatopeico incomincia così: “Allero ‘miezo ‘a via/ annascunnuto mai/ cu ‘a cumpagnia / ‘e ‘na 10 ‘e niro / pazzeo pecché sto chino ‘e guaje”. È dei 24 Grana, la canzone, Stai mai cca’. Giovano anche altri brani della band partenopea. E, va da sé, a seguire alcune canzoni dei 99 Posse, fra tutte, indubbiamente, Napoli: “Napoli/ Ma tenimmo ‘o sole ‘a pizza e ‘o mandulino/ Tarantelle canzone sole e mandulino/ A Napoli se more a tarallucce e vino / Napoli / Na-Na-Na-Na Napoli”.
Ce ne sarebbero altri, di brani o di autori, per lasciarsi istradare: fra i tanti, il rinvio tosto è a Pino Daniele, e ai suoi primi brani del movimento Neapolitan Power, essi avrebbero accompagnato con complicità la lettura del libro, ma vi sarebbe stata una distanza anagrafica con lo stesso testo, ché invece parla della città di metà e dei tardi anni Duemila, sullo sfondo narrativo vi sono infatti i cambiamenti repentini della città dai mille piani e dalle molteplici stratificazioni, oggetto dell’economia turistica mordi e fuggi. Poco male, in realtà, poiché la storia di tre millenni insegna come Napoli porti con sé una dote straordinaria, quella di essere camaleontica: assorbe tante mutazioni, serbando sempre la sua misteriosa vitalità e potenza.
Per chi ha vissuto a crepapelle il Centro storico di Napoli, fra decumani, cardini e fondaci di epoca greco-romana, non può non identificarsi con quelle colonne musicali. Né tantomeno può isolarsi dalla pervasività della vita cittadina. Non vi sono mezze misure. La “Napoli porosa”, com’ebbe a chiamarla Walter Benjamin, è in grado di trascinare i vissuti e farli propri. È quella dimensione sociale e urbana di compenetrazione di aspetti assai diversi, che si mescolano inesorabilmente in un’unica immagine della città: nulla a Napoli è chiuso in sé stesso, nulla è definitivo e definito: “Nessuna situazione, per come essa appare, è pensata una volta per sempre. Nessuna figura reclama il suo ‘così e non altrimenti’”.
Sono delle istruzioni per l’uso, queste, utili per provare a dirimersi all’interno del dedalo biografico della città, e per essere informati come si conviene al primo romanzo di Giancarlo Piacci, I santi d’argento (Salani, 2022, pp. 334). Vi è difatti una fusione, un sentirsi complici, fra le sue pagine con la “Napoli porosa” o anche con la Napoli subalterna. La Napoli che appare fra le righe è una sorta di contrappunto alla città turistificata e gentrificata, che va travolgendo la sua identità.
In I santi d’argento traspare un “materialismo geografico”, un rapporto di conoscenza ferreo con la città partenopea e con le sue contraddizioni e ingiustizie – come una sorta di “odio mosso d’amore”, per dirla con un brano dei 99 Posse, è quello che affiora durante la lettura. Mentre la città appare come una geografia del desiderio, ordita di una composizione sociale che ambivalentemente e conflittualmente ne vive i suoi stati umorali e porosi; e a mo’ di osmosi ne trasmette i propri, di umori. Se ne evince, così, un’antropologia urbana icasticamente composta di militanti – i cosiddetti “giovani dei centri sociali” (in realtà militanti di formazioni antagoniste e autorganizzate) – che vivono passo passo la roccia vulcanica dei sampietrini, coltivando una missione quasi francescana: “fare la rivoluzione”, o come ricordava Valerio Evangelisti, “essere scintilla per far scoppiare tumulti”. Tale missione convive in quella antropologia con coloro che sopportano lo “stato di cose presenti”, subendo il dominio e la violenza dello Stato – sotto forma istituzionale oppure politico-criminale.
All’interno di tale matassa urbana e sociale, Piacci cuce un romanzo che definire avvincente è poco. Pagina dopo pagina inchioda il lettore a seguirne le trame: i passi di Vincenzo, di ritorno da Bacoli verso Napoli, come un Enea, dall’esilio volontario in provincia, che in realtà è estensione della città stessa, si volge a districare alcune vicende mai conchiuse, le quali riportano alla luce un passato col quale, né con gli psicofarmaci, né con l’isolamento, ha fatto pienamente i conti.
A Napoli, sradicato dal suo esilio, Vincenzo si mette alla ricerca del suo passato e di Giovanni, riannodando i fili di quella matassa: s’incunea nei dedali del Centro storico, e seguendo la narrazione, sembra di camminare insieme a lui, per giungere infine al suo quartiere natale. Qui, l’autore offre un affresco del Centro storico. Forse è una dimensione resistente alla mercificazione, a tratti premoderni, per dirla con Ernst Bloch, la “contemporaneità del non contemporaneo”; di certo è molto lontana da quella ormai soggiogata al turismo di pizze e “cuoppi fritti”.
Cerco di non pensare a casa mia. A quanto peraltro sia improprio definirla ‘mia’. Non credo di essere pronto a tornare. A vivere ancora la vicinanza che anima i vicoli. A respirare quelle vite sempre strette le une alle altre. Ormai sono abituato a non vedere nulla se non la monotona orizzontalità del mare che non fa domande e ti lascia stare. Nel vicolo, invece, tutto è senza barriere. Il vicolo scompone il concetto di famiglia e di proprietà. Si spazza, si lava, si mettono fiori e santini sulle urne della Madonna. Oppure si invidia sfacciatamente, si urla una bestemmia, si riparano le buche, si smista la posta. Tutto è in comune. Le litigate, la televisione, i profumi della tavola. Anche l’amore. Nessuno si scandalizza se nelle notti d’estate, mentre si combatte con il ronzio di una zanzara, si sentono sospiri e gemiti da una finestra vicina. È il vicolo che ama, che si riproduce o che tradisce. (p. 48)
Una volta a casa, Vincenzo, in cerca di Giovanni e di un omicidio o suicidio, s’imbatte in un corteo dove è certo di ritrovare qualcuno che sappia dargli informazioni. Poco dopo si trova in mezzo a scontri con la celere. Un altro brano dei 99 Posse fa da eco alla lettura del brano: “Il sole splende forte a Piazza Plebiscito/ le sirene il cellulare sono mezzo tramortito / a Roberta il mio pensiero non ti ho neanche salutato / schedato, picchiato, insultato, provocato / e intanto il sole splende a Piazza Plebiscito”. Il corteo è per la morte di un ragazzo per mano della polizia, in una città in cui la vita di un ragazzino di famiglia proletaria vale una pallottola in corpo. Un rinvio assai poco velato ai recenti episodi di Davide Bifolco e Ugo Russo: due ragazzi, fra tanti, su cui un’associazione di centri sociali e attivisti va chiedendo verità e giustizia, ricacciandone l’oblio.
Cammino sul marciapiede seguendo lateralmente l’avanzare di questo corteo disordinato che ha radunato centinaia di persone. Alcune sono a torso nudo, le magliette le hanno avvolte sul viso per rendersi non identificabili. Hanno la pelle chiara e i fisici asciutti degli adolescenti. Mi guardo intorno cercando qualche faccia conosciuta […] Intanto, tra le file della polizia qualcosa si muove, arrivano i primi lacrimogeni. La folla si separa. Per alcuni secondi si fa il vuoto attorno ai candelotti che disperdono il gas, poi qualcuno li calcia di nuovo in direzione dei doni della celere. La maggior parte delle persone della mia età tossisce e si strofina gli occhi. Da un bar spuntano alcune bottiglie d’acqua. Riesco a prenderne una e a sciacquarmi la faccia. “Il limone, metteteci il limone. Vi passa subito” mi suggerisce il ragazzo rasato con la bandana e la vitiligine che ho visto prima. Porgendomene una metà. Lo guardo un po’ interdetto poiché non mi è chiaro se vuole che lo sprema nella bottiglia o che me lo strofini sul viso. Lui mi legge l’indecisione sul viso e mima il gesto di passare il frutto intorno agli occhi e sulle palpebre. Mi sento uno di quei vecchi che gioca a fare le cose dei giovani senza rendersi conto di fare ridere, o peggio, di essere patetico. Per un momento mi assale anche la sensazione che quest’idea possa essere estesa a tutta questa storia. A me che, completamente fuori di testa, vengo fino a qui per fare luce su un suicidio. A chi la voglio raccontare? La realtà che rifuggo è esattamente come la immaginavo. Un mondo in rivolta con due fazioni distinte che si fanno la guerra, con me nel mezzo che ne ignoro le regole d’ingaggio, i valori e le sfumature. (p. 52)
I santi d’argento ti abbranca, e lo si nota da questo stralcio. Un noir che ti risucchia nella lettura. E l’autore ha fuor di dubbio una strada spianata in tale genere. Ciò nondimeno, la sua virtù è di introdurre il lettore, e poi di interpellarlo, nelle contraddizioni dei rapporti sociali e nei cortocircuiti relazionali di una città liminare, com’è Napoli, situata sulla soglia di diverse fazioni che convivono e, alle volte, si contrappongono. Insomma, non è il solito noir di pregio, esso smuove le viscere, in realtà, sbalzandone gli strali lungo i vicoli, i cui effetti sono ancor più acuti se si riconoscono ambientazione e vicissitudini.
Detto fuori dai denti: la narrazione del corteo di protesta contro l’uccisione del ragazzino fa a pugni con le immagini stereotipate e positiviste, dal sapore lombrosiano, del prodotto turistico da mettere in mostra. Per altri versi è la concretizzazione dell’“orientalismo”, dello sguardo esterno verso Napoli e i napoletani, quali oggetti reificati, nonché sommatoria di alterità. È un discorso che Piacci riesce con intelligenza a smontare e a détournarne senso e messaggio: un esercizio che alla lunga può mettere in scacco proprio quell’intellighenzia, specchio della borghesia proprietaria, se non assenteista e parassitaria, che non si esime a difendere le ingiustizie dello Stato e le illegalità della propria classe di riferimento, in nome di una giustizia aleatoria o di istituzioni completamente assenti. Un esempio è proprio la morte del diciassettenne Davide Bifolco, avvenuto l’8 settembre 2014 nel rione Traiano, per mano di un poliziotto, dopo un breve inseguimento per un mancato fermo a un posto di blocco. In quell’occasione il noto storico, accademico e giornalista napoletano, Paolo Macry scrisse sul Corriere del Mezzogiorno un editoriale tranchant, pregno di rappresentazioni essenzializzanti sulle periferie secondo quello schema dicotomico, additato dal protagonista de I santi d’argento: da una parte, la legge, dall’altra, l’anomia. Tertium non datur.
A Napoli esistono i ghetti – scrive Macry – nella Parigi di Victor Hugo o nella Londra di Charles Dickens il confine di classe […] è lungamente il confine di razza, a Napoli è il confine della legalità. Scampia, Forcella, il Rione Berlingieri, il Rione Luzzatti, costituiscono aree economicamente degradate e urbanisticamente fatiscenti, ma sono anche il luogo di una contrapposizione dei cittadini allo Stato […] È qui che si nascondono i latitanti, che la gente cerca di resistere con la forza agli arresti della polizia, che i conflitti tra interessi vengono risolti da una giustizia privata e cruenta e le guerre tra bande armate avvengono alla luce del sole […] Sono insomma ghetti perché riflettono un contesto infernale ma anche perché, in qualche modo, si sentono essi stessi ghetti […] territori separati dal resto del tessuto urbano, soggetti a codici speciali, abituati a proprie gerarchie di potere, fidelizzati con ricompense di varia natura dalle organizzazioni criminali.
Nelle periferie i canoni istituzionali mutano differentemente che in altre parti della metropoli: vi sono caratteri straordinari (extra legem), mentre il monopolio della forza adotta una condizione di eccezionalità permanente. Così i confini della cittadinanza divengono giocoforza dislocati in base a un’asimmetria di poteri e a seconda dei quartieri cittadini. Il tutto condito da una serie di cliché: da una parte, un classico dell’orientalismo su Napoli, l’allusione all’inferno, immagine pittoresca ripresa da Benedetto Croce da aneddoti settecenteschi, Un paradiso abitato da diavoli; dall’altra, una concezione tipica della letteratura sulle classi subalterne e le classi pericolose (“la reazione della gente del Rione Traiano, l’assalto alle auto delle forze dell’ordine, le dichiarazioni di amici e passanti, il corteo aggressivo segnalano un fenomeno da non sottovalutare)”. Anche se fra gli storici, vi è chi come Eric Hobsbawm – un po’ più noto del summenzionato – il quale ha riconosciuto proprio nelle rivolte e nelle sollevazioni dei subalterni “forme primitive di rivolta sociale”, ossia “forme prepolitiche che ancora non sono riuscite a trovare un linguaggio”, che non sono state integrate nelle forme politiche e istituzionali borghesi, e che enucleano in sé forme ante litteram di partecipazione politica.
Lungo questo crinale, mutantis mutandis, si possono ascrivere tutte le saghe e le fiction di Gomorra e delle sceneggiature di Roberto Saviano, con cui, a nostro parere, I santi d’argento fanno i conti. Scorrendone le pagine si prende senno di un’altra Napoli rispetto a quella savianea – che è redatta di frusti stereotipi, di frame storici neopositivistici, di descrizioni morali di una popolazione preda inguaribile dei suoi incubi atavici. L’abilità di Piacci sta proprio nel détournare la dinamica manichea, ossigenando il testo grazie a interpretazioni compenetranti le molteplicità sociali e urbane.
I santi d’argento decostruiscono, dunque, l’ordine del discorso manicheo. E per ciò ci pare che un’ultima virtù di questo romanzo è quella di aver dato lustro al New Italian Epic. Un genere coniato da Wu Ming 1 nel 2008, con la pubblicazione del Memorandum di teoria letteraria, in cui descriveva lo scenario letterario italiano durante la Seconda Repubblica, dal 1993, dall’attacco alle Torri Gemelle e il G8 del 2001, fino ai tardi Duemila. Il testo wuminghiano suscitò subito un accesissimo dibattito. Fra gli interventi, da annoverare è quello di Carlo Lucarelli. Lo scrittore bolognese enucleò i tratti comuni di tale flusso letterario – romanzi, narrativa, saggistica – i cui addentellati erano: un tratto epico (imprese storiche o mitiche, sia epocali, sia minori, con la fusione talvolta di aspetti storici e leggende, avocando anche il soprannaturale); un tratto geografico e storico, vale a dire la storia politico-sociale e geografica dell’Italia: paese dalle gambe fragili e dal terreno instabile, per cui quanto accaduto durante la Prima Repubblica è stato appannaggio di uno stato di eccezione permanente, dove la conventio ad excludendum ha tenuto fuori i movimenti sociali, così come le forze del cambiamento, a favore delle forze post-fasciste della reazione e della conservazione.
Con queste caratteristiche, le opere realizzate nei vent’anni del New Italian Epic hanno il fascino della frontiera, una prassi liminare e di sfida con un nuovo far west: una frontiera sia fisica (ambientazioni e mondi da esplorare), sia narrativa (trame, avventure, tecniche di montaggio, emozioni), sia infine stilistica (nuovi assemblaggi e costruzioni scritturali, ciò che i Wu Ming definiscono i “romanzi mutanti”). Una narrativa con tanti affluenti e respiri per raccontare mondi complessi, traducendoli con un linguaggio concreto e ficcante; e soprattutto l’esercizio di uno “sguardo obliquo”, tale da osservare la realtà da altri punti di vista, narrando posizioni altere e condotte fuori dai cliché della normalizzazione e dell’apparire.
Ci pare che questo libro riesca a raccontare un’altra città, anzi, racconta la città reale, ridonandole la potenza di città di frontiera e camaleontica, perciò figlia di un tempo non incasellabile dentro le forme di contemplazione effimera e di mercificazione in cui pare essere precipitata. Dopo tutto, Napoli, come in una profezia nietzschiana, tornerà a vivere “ancora una volta e ancora innumerevoli volte” quanto già vissuto nei suoi tre millenni d’età.



