di Franco Pezzini
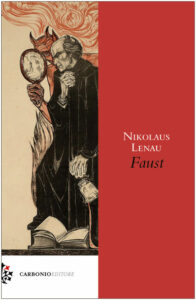 Nikolaus Lenau, Faust, trad. e introd. di Alberto Cattoi, Carbonio, pp. 259, € 16, Milano 2022.
Nikolaus Lenau, Faust, trad. e introd. di Alberto Cattoi, Carbonio, pp. 259, € 16, Milano 2022.
L’idea che Goethe ha già scritto un Faust non può spaventarmi. Faust è un comune possesso dell’umanità, non un monopolio di Goethe. Non si dovrebbe, allora, scrivere più alcuna poesia sulla luna, perché questo o quel grande poeta l’ha già fatto?
Nikolas Lenau, lettera 11 novembre 1833 a Georg Reinbeck.
Molti, molti anni fa, nel profondo di anni Ottanta oggi spesso acriticamente celebrati come epoca d’oro (l’età del riflusso, della profanissima alleanza Thatcher-Reagan, del craxismo dilagante e, sì, a grandi numeri di una maggiore ricchezza), e che per me e la generazione dei Sessanta potevano essere gli anni dell’Università – molto grigi, almeno a giurisprudenza – ci trovavamo con frequenza in quattro amici per un progetto (visto oggi) delirante. Incentrato sulla lettura di tutti i testi relativi al mito di Faust – almeno da quelli dove figurasse il personaggio virtualmente storico, in avanti. In modo confuso, ci sembrava che “l’ambiguo mito del ciarlatano” (ne parlavamo in tali termini in un nostro prodotto dell’epoca) fornisse una chiave per capire la realtà in cui eravamo immersi: e a distanza di tanto tempo, possiamo oggi dire che forse non avevamo tutti i torti.
Ci trovavamo cioè a leggere e discutere insieme, annotando compulsivamente su un quadernetto i discorsi emersi (vorrei poterlo ritrovare), davanti a una bottiglia di vino e quattro bicchieri. E non solo, visto che si mangiava anche, nel luogo principe dei nostri incontri – almeno il preferito – cioè la vecchia piola (cioè osteria, a Torino) del Palazzo degli stemmi, che abbraccia coi portici un lato a metà di via Po. Si entrava da alcuni gradini sulla via laterale, e ci si trovava in un locale che per aspetto avrebbe potuto frequentare il vecchio Johann Georg Faust (ca. 1480 o 1466 – ca. 1541): soffitto altissimo, muri scabri bisognosi di una mano di bianco, tavoli e panche di legno come da secoli in simili locali. Il Faust storico però difficilmente avrebbe potuto beneficiare dei panini con acciughe e bagnèt verd che accompagnavano il vino.
Si era iniziata la lettura dal Faustbuch dell’editore tedesco Johann Spies (ca. 1540-1623) – meglio Historia Von D. Johañ Fausten/dem weitbeschreyten Zauberer vnnd Schwartzkünstler, edito 1587, in Italia Storia del Dottor Faust, ben noto mago e negromante, Garzanti, 1980 –, ancora arcaicissimo e favoloso nel suo orecchiare i primi racconti orali. Si era passati poi a The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus di Christopher Marlowe, c. 1592-1593, di cui pochi anni prima Tino Buazzelli aveva offerto un’entusiasmante versione teatrale presentata in televisione (Il Fausto di Marlowe, 1978, regia di Leandro Castellani)… e poi ci si era arenati, perché incontrarsi in quattro restava piuttosto complicato. Per di più, come in una scena congrua alle nostre letture, una primavera di pioggia ossessiva (per intenderci, alla Blade Runner) aveva fatto crollare vari palazzi del centro storico di Torino: anche il Palazzo degli Stemmi era stato dichiarato inagibile, e insomma la nostra amatissima piola aveva chiuso. (Un corto viaggio sentimentale, abbondantemente onirico, tra i luoghi delle piole storiche chiuse in quegli anni potrebbe condurre a risultati narrativamente felici.)
Poi ovviamente ci eravamo fatti qualche idea almeno sulle principali letture che sarebbero dovute seguire: come ovvio Goethe, con gran timore Mann, ma anche il più gestibile testo di Grabbe (Don Juan und Faust, 1829) e altri che avevamo trovato soltanto citati, senza conoscerne i contenuti. Come per esempio, spesso menzionato, il Faust di Nikolaus Lenau, 1836, intrigante anche per il fatto di arrivare a ridosso di un’opera-mondo come la versione di Goethe, 1808 (pubbl. I parte) e 1832 (pubbl. II parte).
Il testo di Lenau, un precipitato di tutto il più tempestoso sentire romantico che ispirerà il Mephisto-Walzer di Liszt (quattro brani 1859-1885, in particolare il primo), arriva ora proposto in una gran bella edizione da Carbonio, ottimamente curata da Alberto Cattoi. E lo stacco da Goethe appare stridente: non solo nel diverso taglio dell’opera, qui infinitamente più contenuta rispetto al monumento goethiano, ma nel profilo stesso del protagonista – per certi versi più vicino al sentire odierno.
Partiamo dall’autore. “L’immagine di Lenau accreditata dalla tradizione critica è quella di un tipico Zerrissener, di un dilacerato, sospeso tra epigonismo romantico e velleità di rivolta” (così Cattoi nell’Introduzione). Per affrontarlo adeguatamente, “Il primo passo consisterà nel rifiuto di vedere in queste opere ‘minori’ (e nel Faust in particolare) solo l’espressione di una posa romantica, una mera esibizione ed enfatizzazione del sentimento”. Se le cadute del suo impegno ideologico – che gli procureranno le bacchettate di Heine – non permettono di annoverare Lenau tra gli intellettuali progressisti del periodo della Restaurazione, non si può certamente neppure ascriverlo al fronte conservatore. Col disagio del provinciale inurbato costretto a trasferirsi a Vienna (era nato a Csatád cioè oggi Lenauheim dal suo nome, nel Banato ungherese, attualmente Romania), eterno studente che cambia sempre facoltà universitaria (Filosofia, Legge, Agraria, Medicina) ma poi anche casa (Austria – dove morirà nel 1850 –, Svevia, Ungheria), vive la “perdita del centro” come “condizione esistenziale irreversibile” anche nelle proprie dimensioni privatissime, sentimentali, e nelle scelte ideologiche altalenanti, fino a identificarsi con l’Ebreo errante: ed ecco il nucleo ideale di questo Faust spesso definito Wanderer, viandante, fin quasi a svuotarne le connotazioni canoniche.
Le stesse scene sono diverse da quelle “classiche” del mito di Faust: rupi montane dove pratica l’alpinismo, un teatro anatomico (dove Mefistofele fa la sua comparsa), una fitta foresta dove – forse anche a seguito dell’incontro con un monaco – si consuma il patto fatale, l’appartamento dove l’ennesimo benintenzionato, un vecchio amico, tenta di sistemarlo con la propria sorella, qualche scena in campagna con tanto di festa nuziale… Più consueto ai soliti sfondi faustiani il giardino di una reggia, dove Mefistofele consiglia un ministro, e una sala del palazzo reale. Ma poi torniamo alle libere trovate di Lenau con la bottega di un maniscalco, una processione notturna e paesaggi da dipinto di Caspar David Friedrich, la villa del duca Hubert dove Faust si rivela (ohibò) pittore e uccide il duca per amore della sua bella fidanzata, e nuovi paesaggi da quadro romantico – compreso il cimitero dove è sepolta la madre di Faust, un bosco e una spiaggia. Ma è soprattutto originale la soluzione del protagonista a bordo di una nave, della tempesta e della scena nella locanda dove i marinai, tra vino, danze e donne, festeggiano la propria salvezza. Poi di nuovo una spiaggia battuta dalla burrasca, dove Faust si uccide sbeffeggiando il diavolo:
Io sono un sogno che vola via dalla tua prigione!
Io sono un sogno fatto di piacere, di colpa e di dolore,
E sogno di immergermi il coltello nel petto!
Si pugnala.
Nel 1833 Lenau, tornato deluso dall’America (il viaggio per mare di Faust potrebbe trarne qualche suggestione), viene accolto a Stoccarda come grande poeta a seguito della pubblicazione di un volume di liriche per Cotta, l’editore che ha pubblicato non solo il suo Faust ma la seconda parte di quello di Goethe – da cui varie polemiche. Ma negli anni 1833-35 di redazione del Faust, Lenau è “in piena crisi esistenziale, in uno stato di completo smarrimento”: già caratterialmente facile a deprimersi e autocompiangersi, è tornato delusissimo dall’America paradiso degli affari e dello sfruttamento, ha incassato l’ascetica rinuncia impostagli da Sophie von Löwenthal – moglie di un amico – di cui è perdutamente innamorato e del cui fantasma resterà succube, e ha aperto un dialogo con il teologo danese Martensen che avrà un ruolo importante nel varo del Faust.
Il risultato sono ventiquattro quadri di genere misto (all’interno dello stesso episodio troviamo aspetti lirici, epici, drammatici…) come stazioni “di quella via crucis e circolo vizioso insieme, che è per Faust la vita dell’uomo”. E se Mefistofele offre a Faust l’unica verità in suo possesso, “pura e semplice negazione di ogni valore, come affermazione dell’io egoistico e istintuale”, ma nessuno dei benefit concessi in altre opere sul tema, al patteggiante manca la volontà/capacità di godere, e in radice forse quella stessa di desiderare e di essere felice. Perennemente disperato (Lenau passerà gli ultimi anni, 1844-50, ricoverato per demenza), può solo patire rimorsi, provar fastidio per i “poveri di spirito” e invidia per chi pecchi col cuore allegro. Vorrebbe soltanto dimenticare d’essere una creatura, confida nel monologo che precede il suicidio – e mostra prefiguranti affinità con il pensiero di Nietzsche.
L’età moderna è fortemente connotata, al suo sorgere, dal mito di Faust. In realtà con origini molto antiche, legate al tema degli aspetti oscuri del pattuire: se il mondo ebraico e poi cristiano sorge sull’idea di un Testamento quale impegno divino e il contratto stesso appare nel mondo indoeuropeo come istanza divina (si pensi a Mitra, il dio-contratto), già molto presto emerge in letteratura il tema del volto oscuro della contrattualizzazione. In fondo fin dal giuramento dei capi achei, pretendenti della fatale Elena, di difendere lo sposo che lei avrebbe liberamente scelto: una trovata di Odisseo, che gli si ritorcerà contro, spingendolo inutilmente a fingersi pazzo per sfuggire agli oneri di quanto giurato – la discesa in guerra a fianco di Menelao. Più conforme alla logica sofistica del diritto sarebbe stata a quel punto la risposta di Cinira di Cipro, che obbligato a mandare navi le spedirà di terracotta… Ma poi c’è tutta la sequela dei pre-Faust, Cipriano e Teofilo e tutti gli altri, fino all’arrivo di questo ciarlatano tedesco che, anche in grazia di una morte brutta e misteriosa, avrà la sorte di fornire un archetipo e forse il primo mito dell’età moderna. Ma di lì gli epigoni si sprecano: da Cazotte che, col suo delizioso Diavolo in amore rococò avvia la letteratura fantastica francese di età moderna, a Beckford col Vathek e il primo inferno per vocazione della letteratura, a Schiller col Visionario, dove il patto non è col diavolo ma con dimensioni oscure retrostanti la politica… a suggerire che tutta l’età moderna sia in fondo figlia delle tentazioni di un accordo losco, che porterà su lungo periodo un danno infinitamente superiore ai vantaggi. Un danno/dannazione metafisica, per chi continua a credere, o invece tutta mondana di una finta libertà che guasta dentro.
Il Faust di Lenau è un depresso, consumato da un inesausto male di vivere; e lo stesso finale in cui Mefistofele annuncia la sua dannazione resta metafisicamente ambiguo. La sensazione è che il finale resti aperto proprio perché tutto quanto vissuto da Faust appartiene al profondo del suo rovello interiore:
Faust è l’uomo che ‘subisce’ le proprie azioni; il male che egli commette non è imputabile a lui, ma alla sostanza negativa del mondo. Con questa concezione così radicalmente pessimistica, Lenau sembra ricusare in blocco tutto l’umanesimo quasi è venuto configurando nella cultura occidentale da Socrate in poi.
E Faust appare un fratello di Edipo che mira ad “annullarsi misticamente nel Tutto indistinto, […] progenitore di tanti moderni cultori dell’eclissi dell’io ed esteti dell’irresponsabilità”.



