di Giovanni Iozzoli
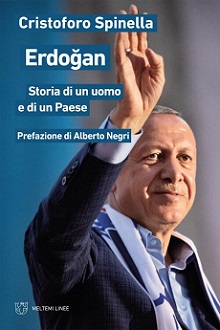 Cristoforo Spinella, Erdogan. Storia di un uomo e di un paese, Meltemi, Milano, 2021, pp. 208, € 16,00
Cristoforo Spinella, Erdogan. Storia di un uomo e di un paese, Meltemi, Milano, 2021, pp. 208, € 16,00
Fenomenologia di un autocrate, si potrebbe intitolare, questo interessante saggio di Cristoforo Spinella, che affronta in modo sistematico e rigoroso, la storia e la figura dell’uomo che da vent’anni è al centro della politica turca. Certo, si tratta di un autocrate un po’ speciale, un talento politico perverso e poliedrico che si fa fatica ad incasellare nelle categorie della contemporaneità: fonda sul revanscismo islamico la sua ascesa, ma non è ascrivibile a nessuna delle correnti del moderno islamismo politico post-11 settembre; ha stabilito con la maggioranza dei turchi un rapporto verticale e diretto di consenso, ma non si può ricondurre al ciclo populista tradizionale; ha molto in comune con Putin, ma non è figlio come lui degli apparati di Stato, anzi ha costruito la sua carriera nella contrapposizione ad essi. Insomma, un anomalo animale politico che usa (e getta) tutte le etichettature che la storia ha provato ad affibbiargli: da esempio virtuoso di un islam conservatore e liberale, coccolato dalle cancellerie europee e alfiere dell’integrazione turca nell’Unione, a spauracchio dittatoriale – Draghi dixit – che spaventa e irrita l’Europa, più per la mano sul rubinetto dei profughi che per le minacce alla vita democratica del suo paese.
Spinella racconta il “romanzo di formazione” del giovane Recep: come in tutte le biografie delle persone che contano, è difficile districare l’agiografia dalla verità storica. Certo è che – argomento costante del leaderismo populista – Erdogan ha sempre insistito sulle sue origini genuinamente proletarie: un “turco nero”, cioè un figlio della Turchia anatolica profonda, rurale, non occidentalizzata, cresciuto a Istambul in un quartiere di immigrati interni; una identità che si costituisce in opposizione al mondo dei “turchi bianchi” – le elite urbane europeizzate, che respingono l’eredità ottomana e sbandierano un laicismo autoritario, spesso inquinato da privilegi di classe e difesa dello status quo.
La vita del futuro capo dello Stato si svolge nei primi anni tutta intorno al rione popolare di Kasimpasa, intrico di vicoli su una collina che degrada a picco verso il Corno d’Oro, a margine della zona occidentalizzata di Beyoglu. Piazza Takshim non è lontana, il rifugio dei “turchi bianchi” di Nisantasi poco più in là, ma sembra un altro mondo. Il giovane Erdogan lo impara presto, portandosi dietro il corollario di astio e ambizione di rivincita sociale verso quei concittadini che non solo sono più ricchi, ma soprattutto li vedono come subalterni, estranei, istambulioti di serie B, quando li guardano: un’ostilità che animerà sempre il fantasma di apparire un parvenu, anche quando mezzo secolo dopo, gli eredi di quegli stessi ricchi industriali, finanzieri e commercianti correranno magari a lui per mendicare favori. E poi, in quei kemalisti lui percepisce un animo corrotto dall’alcol e dai vagheggiamenti parigini, per nulla assistito dalla fede in Allah e dall’amore per il popolo; per lui insomma non sono i veri turchi. E di dimostrarlo, rovesciando questi rapporti di forza, se ne farà una missione nella vita. (p. 36)
L’autore racconta efficacemente della lunga gavetta politica, intessuta di rapporti sul territorio e immersioni nell’infimo popolino della Istambul più profonda. Diventato responsabile del neonato partito islamico Refah, piccolo, ininfluente e sempre sulla soglia della censura militare, Erdogan si da ad un attivismo totale:
La leggenda più diffusa narra di un instancabile porta a porta di un quartiere, che non si fermava neppure sulle soglie dei viali della perdizione di Beyoglu. Anzi, sarebbe stato proprio lì, nella case da gioco e in quelle di tolleranza, tra i bar dove scorrono fiumi di raki e i peccaminosi locali della vita notturna, che intorno ai trentanni Tayyp inizia a darsi da fare per cercare di salvare le anime e, sulla strada della retta via, raccattare voti (…) Ad ogni modo l’idea di fondo è chiara e risulterà vincente: senza uscire dalle solite cerchie e dalla marginalità sociale, e con un sistema scolastico e statale che faceva pochissime concessioni al proselitismo islamico, difficilmente si sarebbero potute cambiare le cose. Bisognava partire dalla strada, per arrivare alle urne. (p. 40)
Il giovane Erdogan impara a guidare con maestria la macchina del consenso:
teorizza e divulga un populismo antelitteram, in cui per avvicinarli, e convincerli, i militanti si adattano agli elettori. Le donne hanno un ruolo chiave: velate o capo scoperto, a seconda delle porte a cui devono bussare, e del pubblico da convincere, sotto la sua gestione del partito ottengono forse per la prima volta un ruolo cruciale e pubblicamente riconoscibile nel movimento. (p. 43)
Dopo anni di scavo sotterraneo, incunenadosi dentro una dei frequenti stalli del quadro politico kemalista, Erdogan arriva a conquistare la poltrona ambitissima di sindaco di Istambul, nella primavera del ’94, per soli 100.000 voti di differenza, avviando una amministrazione di cui resterà traccia nella memoria diffusa:
A guidarlo ha un’ideologia – una fede direbbe lui – ma quando bisogna ritirare la spazzatura e affrontare gli ingorghi stradali conta fino ad un certo punto. Spesso e volentieri, soprattutto dietro le quinte, si affida ai tecnici, mentre i suoi assessori pii e magari meno preparati restano il volto pubblico delle riforme. Ecco allora che durante la sua sindacatura si si costruiscono decine di chilometri di nuove condotte per portare l’acqua là dove arrivava poco o poco pulita, si comincia ridurre l’onnipresente riscaldamento a carbone incrementando l’uso del gas naturale, autobus e metro iniziano a funzionare meglio. (p. 55)
Spinella insiste per smentire l’idea che questo genere di populismo viva nel regno delle emozioni o delle suggestioni: c’è una materialità delle condizioni popolari, che fanno da sfondo ai discorsi identitari o sovranisti; c’è un’attenzione alla propria condizione percepita dalla masse, magari per la prima volta; e senza questa base, assai concreta, il consenso “religioso” o nazionalista, sarebbe destinato a durare poco. Peron, Kaczynski o Orban, l’ascesa dei populisti marca una invarianza di fondo: alla base di questi successi c’è sempre un blocco sociale che si disgrega e uno nuovo che si rifonda e assegna la rappresentanza dei suoi interessi a una nuova classe dirigente che narra se stessa in termini di sana catarsi e incarnazione dell’interesse generale e nazionale.
Mentre Erdogan tesseva la sua trama egemonica, gli osservatori delle cancellerie occidentali – strumentalmente amanti del kemalismo, o meglio dell’idea rassicurante, modernizzatrice e tradizionalmente atlantista che si erano fatte di esso – non percepivano la crisi e il marciume della vecchia turchia “laica” e militare: decenni di corruzione, autoritarismo, golpismo militare e mafia – stavano consegnando nelle mani della nuova classe dirigente erdoganiana un paese desideroso di rivalsa, di orgoglio nazionalista e pronto a coltivare velleità di sviluppo economico da grande potenza.
Erdogan esibisce negli anni, uno spregiudicato eclettismo nelle alleanze, nel lessico, nell’agenda politica, nel posizionamento: il pragmatismo – spesso del tipo più cinico – è la cifra di quest’uomo e del ciclo politico che incarna da due decenni. Si dimostrerà, ad esempio, sapientemente pragmatico nella scelta di accettare stoicamente il carcere, a causa di un discorso pubblico che incitava a reimpugnare l’identità ottomana, intuendo che la reclusione lo consacrerà eroe del dissenso:
Erdogan pronuncia le parole che gli costeranno la galera il 12 dicembre 1997 durante un comizio a Siirt (…) Quel giorno di dicembre 1997, Erdogan dice: i minareti saranno le nostre baionette, le cupole i nostri elmetti, le moschee le nostre caserme e i fedeli i nostri soldati. La voce è sua, le parole – pur con qualche licenza interpretativa – di Mehmet Zya Gokalp, poeta turco del primo novecento e aedo del nazionalismo islamico.(…) Il sindaco di Istambul viene accusato di istigazione all’odio e alla violenza razziale e religiosa (…) Subisce anche una interdizione dai pubblici uffici che durerà fino al 2003. L’ingresso in prigione, il momento teoricamente più difficile, lo individua già come una tappa fondamentale del suo percorso verso il potere. Dalla prigione uscirà quattro mesi dopo, il 24 luglio, passando da una porta sul retro, nuovamente atteso da un valanga di sostenitori. (…) Come fosse già un uomo di Stato. (p. 58)
Sarà altrettanto pragmatico nella scelta di presentarsi a Europa e Usa, ancor prima di diventare premier, come alfiere della democratizzazione, in un paese chiave dell’assetto atlantico:
Sembra tornare ad essere l’alleato Nato che mancava in un paese che rischiava di sfuggire di mano, e nonostante un opinione pubblica non poco recalcitrante sul tema. Diventa anche lo spot perfetto per dire che con l’Islam si può continuare a collaborare anche nel post 11 settembre e che le guerre dell’America non sono poi di religione. Già nel dicembre 2003 , era solo il leader dell’AKP e non della Turchia , che ufficialmente lo considerava ancora ineleggibile, Erdogan viene invitato alla Casa Bianca da George Bush (p. 71)
E poi arriva la storia di oggi, ben descritta dall’autore: la crisi di Gezi Park, in cui Erdogan schiaccia senza ritegno le opposizioni di piazza; il tentativo del grande accordo di pace con l’arcinemico Ocalan, che finirà con una pioggia di fuoco sui territori curdi e la messa fuorilegge dell’HDP, secondo partito del paese; la crisi siriana, in cui sostiene il jhiadismo anti Assad e marcia indisturbato sulle trincee dell’autonomia confederale curda; e il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, che gli darà l’occasione di rovesciare le alleanze internazionali, stroncare l’ex potente alleato Gulen, fare piazza pulita dei residui militari a lui ostili, e stringere una cappa di repressione sulla società turca che ancora perdura e su cui regge molto del suo potere. E, tornando all’oggi, conviene citare un frammento della bella introduzione di Alberto Negri:
Ci sono diversi modi di guardare un paese. Cristoforo Spinella, giornalista esperto, corrispondente dell’Ansa da Istambul (…) ha scelto di farlo con una biografia di Erdogan che è anche quella di un’intera nazione in tutte le sue sfaccettature, come in un mosaico bizantino. Attraversa l’attualità, ma inevitabilmente anche una storia millenaria e le sue radici profonde. C’è lo sguardo d’insieme su un ventennio al potere del reis turco, ma ci sono anche i dettagli della sua vita, setacciati separando, anche con ironia, l’agiografia ufficiale dal reale. Uno è fulminante. In un’intervista al quotidiano Milliyet, del 14 luglio 1996, sette anni prima di andare al comando nel 2003, Erdogan, allora sindaco di Istambul dichiara: la democrazia è come un tram: quando raggiungi la tua fermata scendi. Da quel tram Erdogan è sceso da un pezzo e non si può dire che non fossimo stati avvertiti, nonostante la sua capacità di dissimulazione. Ma il suo progetto di egemonia politica e culturale sulla società turca, sia pure già radicato, non è detto che possa proseguire all’infinito e senza ostacoli. La Turchia riserva sempre delle sorprese. (p. 9)



