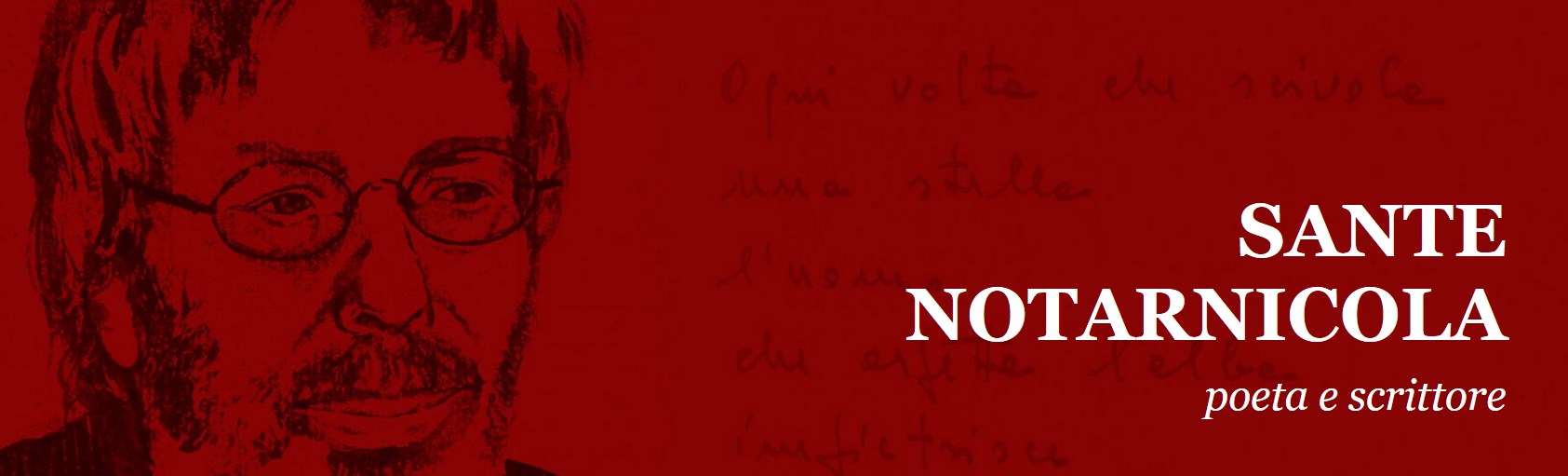di Giorgio Forni
 «La lotta di classe, che è sempre davanti agli occhi dello storico educato su Marx, è una lotta per le cose rozze e materiali, senza le quali non esistono quelle più fini e spirituali. Ma queste ultime sono presenti, nella lotta di classe, in altra forma che non sia la semplice immagine di una preda destinata al vincitore. Esse vivono, in questa lotta, come fiducia, coraggio, umore, astuzia, impassibilità, e agiscono retroattivamente nella lontananza dei tempi». (Walter Benjamin)
«La lotta di classe, che è sempre davanti agli occhi dello storico educato su Marx, è una lotta per le cose rozze e materiali, senza le quali non esistono quelle più fini e spirituali. Ma queste ultime sono presenti, nella lotta di classe, in altra forma che non sia la semplice immagine di una preda destinata al vincitore. Esse vivono, in questa lotta, come fiducia, coraggio, umore, astuzia, impassibilità, e agiscono retroattivamente nella lontananza dei tempi». (Walter Benjamin)
Ho incontrato per la prima volta Sante Notarnicola verso la metà degli anni Novanta in casa dello scrittore comunista Roberto Di Marco. Erano i primi tempi della sua «semilibertà» quando usciva dal carcere che era ancora buio, si infilava nel sotterraneo polveroso e poco illuminato della Standa in via Rizzoli per lavorare otto ore alla pressa comprimendo scatoloni e imballaggi di cartone e ne usciva solo per tornare a dormire in carcere quando veniva già buio.
Aveva un modo particolare di sorridere dondolando lievemente la testa come dire ‘va bene così, anche se non ci dovrebbe andare affatto bene…’. Insisteva ironicamente sulla parola «semilibertà» dicendo che bisogna guardare bene dentro le parole perché ci sono parole che nascondono le cose e parole che ce le rendono evidenti.
Sante è stato un comunista perché si sentiva parte della lotta per abolire le diseguaglianze e lo sfruttamento di classe ed è stato un poeta perché sapeva bene che le parole possono anche eludere manipolare opprimere e che ciò non sarebbe cambiato tanto facilmente persino in una società migliore e più giusta di quella in cui viviamo.
La poesia è stata per Sante un’altra forma di militanza materialista e rivoluzionaria, un altro modo di alzare lo sguardo al di là dei muri verso il possibile e l’ignoto, un diverso senso del futuro tra le costrizioni del presente. E le due cose, comunismo e poesia, stavano insieme con semplicità, con immediatezza, nel modo che aveva di stare con gli altri, nelle parole di ogni giorno, in un’intesa segreta tra le lotte di generazioni passate e la necessità pratica di trovare nel presente un varco, un cammino comune verso l’avvenire. Non c’era alcun autocompiacimento memorialistico.
Non si metteva in posa per la foto ricordo.
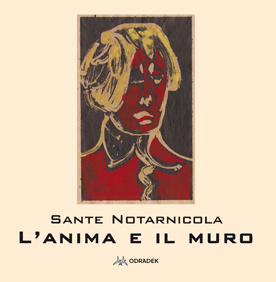 Anche per il suo formato anomalo, una delle ultime raccolte delle poesie di Sante, L’anima e il muro (Roma, Odradek, 2013), potrebbe certo ricordare un album di fotografie dove la bella introduzione di Daniele Orlandi e le puntuali note a piè di pagina paiono quasi una voce fuori campo che commenta e spiega l’occasione di ciascuna istantanea, le soste di una continua trasferta esistenziale fra prigioni e supercarceri, i dettagli e le date di una storia detentiva oscura e rimossa. E a questo effetto concorrono anche i disegni di Marco Perroni che accompagnano le poesie di Sante e accennano sempre a un’immagine che sfugge in un graffito provvisorio, insieme duro e quasi evanescente. «Il mio pittore», diceva sempre.
Anche per il suo formato anomalo, una delle ultime raccolte delle poesie di Sante, L’anima e il muro (Roma, Odradek, 2013), potrebbe certo ricordare un album di fotografie dove la bella introduzione di Daniele Orlandi e le puntuali note a piè di pagina paiono quasi una voce fuori campo che commenta e spiega l’occasione di ciascuna istantanea, le soste di una continua trasferta esistenziale fra prigioni e supercarceri, i dettagli e le date di una storia detentiva oscura e rimossa. E a questo effetto concorrono anche i disegni di Marco Perroni che accompagnano le poesie di Sante e accennano sempre a un’immagine che sfugge in un graffito provvisorio, insieme duro e quasi evanescente. «Il mio pittore», diceva sempre.
Ed è un dato su cui riflettere: in realtà, se Sante avesse voluto raffigurare la sua lunga detenzione di ergastolano con delle fotografie, non avrebbe mai potuto assolvere all’esigenza del tramando sensibile ed emozionale di un’esperienza difficilmente rappresentabile in termini di immagini. Vi è nel carcere una privazione così particolare ed estrema che solo la parola può raccontarla. Anzi, forse solo una parola marginale e straniante come quella della poesia.
In fondo, questo libro racconta per frammenti una storia o, se si vuole, una controstoria diversa e contrapposta alla Storia ufficiale: una controstoria che scava nei silenzi, nelle lacune, nelle crepe, nelle cicatrici prodotte da un dispositivo di potere come il carcere degli anni Settanta che fu in grado di rinchiudere e degradare la speranza rivoluzionaria di un’intera generazione fra sbarre, muri, torture e regolamenti.
Non sorprende che il soggetto che parla in queste poesie non sia propriamente un tradizionale «io» lirico che evoca una dimensione privata, ma un’identità collettiva, un «noi» in pubblico: «Noi viviamo, sapete», scrive Sante; e anche «vorrei ritrovare quella generazione…». Ed è una presa di parola che si configura anzitutto come rivolta, come resistenza all’oppressione, alla cancellazione. Nelle carceri infatti «era vietata la penna» (L’anima e il muro, p. 22): una delle ossessioni del potere era proprio quella che il prigioniero potesse scrivere, comunicare, vivere quell’esistenza riflessa che si affida alle parole.
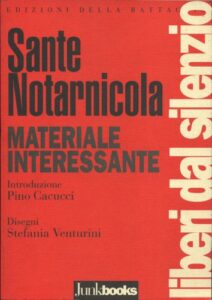 Ricorda Sante in Materiale interessante del 1997:
Ricorda Sante in Materiale interessante del 1997:
«Non mi ci volle troppo tempo a capire che il foglio di carta sarebbe stato uno dei pochi strumenti che mi avrebbero consentito di non farmi seppellire nel buco nero dell’ergastolo. Dunque: poesia come strumento di agitazione. Poesia per comunicare in condizioni difficili. Poesia per rompere l’isolamento a cui vorrebbero costringere corpo e cervello. Poesia come difesa dall’abbruttimento della prigione. Poesia per amare ancora».
Vi è nella sua poesia il bisogno di strappare le parole a un ordine oppressivo del discorso. Anche la parola collabora al funzionamento dei meccanismi della repressione e la scrittura poetica può diventare allora un atto di riappropriazione, di sabotaggio, di resistenza.
Non a caso numerose poesie dei primi anni Settanta riprendono e sovvertono dall’interno le procedure linguistiche della giustizia borghese: l’interrogatorio dell’imputato, il verbale, le formule del linguaggio burocratico, l’interrogazione parlamentare… Ed è una scelta per la parola isolata in cui il vocabolario compatto del potere può essere per un istante incrinato e capovolto in un controsenso ironico e sedizioso. Esemplare è la poesia Il Dizionario (L’anima e il muro, p. 119):
I guardiani saccheggiarono le celle, infine
Mi presentarono la lista delle privazioni:
«Da oggi un solo libro! Lo scelga…»
Il vocabolario mi sembrò la scelta più ragionevole:
per pensare, per amare, odiare e resistere… e magari
vivere la notte e consumarla tutta intorno ad una sola parola.
In questi testi vi è una stringente consapevolezza della materialità delle parole modellate dai dispositivi di dominio sociale come minimi ingranaggi di un ordine invisibile, ma vi è insieme la scoperta della concretezza della sovversione poetica («poi / a notte avanzata / un altro quesito: / il pensiero è materia?»). Ecco allora che «una sola parola», staccata dalla sintassi del potere, può diventare arma critica per «odiare e resistere». Ed è un’idea di poesia che forse oggi ha ancora molto da dire.
Non v’è dubbio che negli ultimi trent’anni la nozione di controstoria sia diventata una formula letteraria diffusa e consueta persino nell’ambito della letteratura commerciale, ma quella che Sante ha tracciato nel corso degli anni su fogli di fortuna è una controstoria che ha tratti tutti particolari anche al di là della sua appartenenza politica alla linea del comunismo intransigente – «dei soviet», come amava dire – perché si radica in un’idea della parola come luogo di scontro fra discorsi e identità storiche preesistenti e sempre già implicate in un gioco ineludibile di rapporti di forza.
Proviamo allora a considerare questo enunciato apparentemente banale:
La storia è sempre scritta dai vincitori. Quando due culture si scontrano, chi perde viene cancellato e il vincitore scrive i libri di storia.
È una di quelle frasi che paiono vecchie come il mondo. Ci sembra di averla sempre sentita, ma in realtà essa compare sulla superficie della cultura occidentale solo nei primi anni Ottanta e, come i ricordi dei replicanti nel film Blade Runner che è appunto del 1982, circola subito come una vecchia formula, una verità ovvia e risaputa. Nella formulazione appena citata si legge in Dan Brown, Il codice da Vinci, Milano, Mondadori, 2003, p. 299.
Soprattutto dopo il 1984 e le celebrazioni del grande romanzo di George Orwell si diffondono molteplici declinazioni di questo paradigma che diventa luogo comune.
Ecco ad esempio un’intervista a Günter Grass (Parla Günter Grass, “L’Espresso”, 20 aprile 1986, p. 115):
«La storia per lo più viene scritta dai vincitori. La letteratura colma queste lacune. La capacità di stare solo con se stessi e con un libro, di isolarsi, lontano dai rumori e dalla banalità, di immaginare le figure. Non è certo il vetro opaco della tv a poter rappresentare tutto ciò».
 Se la Storia cancella completamente le masse degli sconfitti, allora tocca alla letteratura proporre un mito capace di reinventare una collettività e di rifondare un discorso comune di appartenenza culturale, civile e politica.
Se la Storia cancella completamente le masse degli sconfitti, allora tocca alla letteratura proporre un mito capace di reinventare una collettività e di rifondare un discorso comune di appartenenza culturale, civile e politica.
Pare un ragionamento del tutto logico e coerente, ma in realtà contiene un elemento di incongruenza: la parola risulta sottratta alla dialettica concreta della storia nel momento in cui lo sconfitto non si trova iscritto in un rapporto di dominazione, ma viene «cancellato» e appare come «lacuna», spazio bianco che solo la narrazione letteraria può riscrivere e reinventare. In questo caso la controstoria si prospetta come smontaggio e reinvenzione dell’identità… Ma si può inventare l’identità, oppure è sempre una scelta di campo, un’identità storica, un modello antropologico di cui ci possiamo spogliare fino a un certo punto? Non vi è in questa idea del mito una manipolazione dall’alto delle identità storiche? E ha senso poi ragionare in termini statici di identità piuttosto che in termini di desiderio, di lotta, di cammino collettivo fuori dall’apocalisse neoliberale?
Sante amava i segni concreti del passato, i nomi, i luoghi delle lotte, i vecchi quartieri operai, le tombe dei partigiani, le colline insanguinate dagli eccidi nazifascisti perché vi leggeva non tanto un’identità, quanto una promessa di riscatto, di risveglio.
Senza dubbio nessuno quanto Sante avrebbe potuto inventare un piccolo mito di sé stesso e invece le sue poesie sono scritte non solo con una aggressività ironica contro tutte le forme dell’oppressione, ma anche con una tensione critica e autocritica che sospetta e mette in distanza la dimensione borghese e consolatoria del mito. «Ironico, come un gatto infedele», scrive di sé (L’anima e il muro, p. 64).
Sul piano dell’identità, la controstoria di Sante di fatto non inventa nulla; la sua è una scelta di campo, il posizionarsi in una lotta: è l’identità storica del comunista e del rivoluzionario come modello antropologico e, per così dire, come fatto umano.
È l’identità di chi sa, anche nei lunghi periodi in cella d’isolamento, che il senso di solitudine è un’emozione borghese («una fragilità / ch’è patrimonio / tutto borghese») e che ovunque qualcuno combatta e resista contro l’oppressione quella persona è come se fosse al tuo fianco, tuo compagno, tuo fratello. Sono le parole che risuonano anche nei canti dell’Italia partigiana e rivoluzionaria: «dovremo tutti quanti / aver d’ora in avanti / voi altri al nostro fianco / per non sentirci soli» (Morti di Reggio Emilia) e «chi ha compagni non morirà» (L’Internazionale di Franco Fortini).
Si può dire allora che quella di Sante è una controstoria dialettica che si rifiuta di inventare l’identità come punto di vista sul mondo.
È memoria di un desiderio collettivo di liberazione. Una piccola, grande lezione di scrittura rivoluzionaria.
– – – – – – – – – – – – – – –
I ritratti di Sante in questo articolo sono di Asparago (in apertura) e di Marco Perroni.
Poesie, testi e immagini di Sante Notarnicola sono disponibili sul suo sito web, che diventerà l’archivio digitale delle sue opere, degli scritti a lui dedicati e dei ricordi di chi lo ha conosciuto.