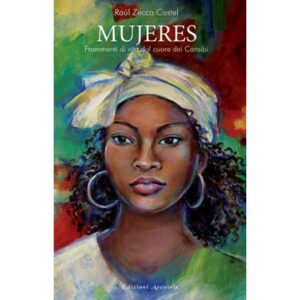di Raúl Zecca Castel
Zecca Castel, Mujeres. Frammenti di vita dal cuore dei Caraibi, Edizioni Arcoiris, Salerno 2020, pp. 212, 14.00 €. Postfazione di Annalisa Melandri. Quadro in copertina e illustrazioni di Magda Castel.
[Estratto dell’introduzione]
Questo libro raccoglie le testimonianze di Célestine, Flor, Yvette, Anabel, Nora, Arielle e Liliane, sette donne conosciute durante un lavoro di ricerca antropologica condotto in Repubblica Dominicana presso il batey Ciguapa, insediamento rurale le cui origini storiche risalgono al sistema di piantagioni e al regime schiavista coloniale che governarono l’intera isola di Hispaniola dal 1492 fino a parte del XIX secolo.
Come tutti i bateyes del paese, Ciguapa è una comunità che si caratterizza per la particolare composizione etnica e socio-culturale della sua popolazione, quasi interamente di origine haitiana, nera e di classe bassa. Perlopiù, si tratta di persone migranti e loro discendenti giunte o trafficate in Repubblica Dominicana per lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero, dove da generazioni vivono in baracche di legno e lamiera, spesso senza accesso a servizi fondamentali come l’energia elettrica e l’acqua corrente.
Se la maggior parte degli uomini che popola i bateyes dominicani è ancora oggi sfruttata dalle grandi imprese saccarifere come bracciantato agricolo – in condizioni di lavoro più volte definite in termini di schiavitù moderna -, la situazione che vivono donne e bambini, per certi versi, è ancora più difficile. Senza possibilità di accedere a fonti di reddito che permettano loro di garantirsi la sussistenza, infatti, molte donne instaurano rapporti di convenienza più o meno espliciti con gli uomini della comunità, esponendo sé stesse e i loro figli al rischio di gravi violenze fisiche e psicologiche.
Da questo punto di vista, le storie qui raccolte di Célestine, Flor, Yvette, Anabel, Nora, Arielle e Liliane non costituiscono percorsi di vita eccezionali, selezionati tra i casi più estremi di esistenze marginali. Al contrario, sono fortemente rappresentative di esperienze assai diffuse e ricorrenti tra le donne che abitano il batey Ciguapa. Subire abusi infantili, essere impiegate in lavori domestici o agricoli sin dalla tenera età, affrontare gravidanze precoci, stabilire relazioni precarie con uomini generalmente attempati e spesso violenti, generare numerosi figli da molteplici partner, soffrire ripetuti abbandoni, intraprendere la strada della prostituzione e farsi carico unilateralmente della crescita e dell’educazione dei propri figli sono costanti trasversali nelle traiettorie di vita delle donne di questa comunità e dei bateyes in generale.
Lungi da queste biografie, tuttavia, è la pretesa di voler parlare a nome di tutte le donne che in ogni angolo del mondo sperimentano condizioni di vita simili. Nessuna velleità universalistica né tantomeno moralista è chiamata in causa. Le storie qui raccolte non intendono corroborare l’idea fortemente essenzialista di quella che la sociologa indiana Chandra Talpade Mohanty ha criticamente definito come “la donna del terzo mondo”, categoria ideologica costruita sulla base del semplice connubio tra classe e genere, quasi che l’universo femminile potesse ridursi a un’unica natura uguale per tutte le donne marginalizzate. Il tentativo, al contrario, è quello di decolonizzare l’immagine astratta della donna, a favore del suo riconoscimento come soggetto concreto e reale, dunque nella sua infinita molteplicità. Le voci di questo libro, perciò, raccontano e rappresentano unicamente se stesse. E non è poco.
Per lungo tempo – per troppo tempo -, infatti, le parole delle donne e di tutti quei soggetti che la Storia occidentale (e non solo) ha relegato a una posizione di marginalità subalterna, sono rimaste inascoltate, rimosse o negate dal discorso pubblico. Nel migliore dei casi, altre voci hanno talvolta pensato di potersi arrogare il diritto di parlare in loro nome, dimenticandosi o ignorando il fatto che quei soggetti non fossero – non sono! -muti, e che le loro parole hanno il potere di risuonare come tutte le altre. Semplicemente, andrebbero ascoltate. Così, nonostante le buone intenzioni, non si è fatto altro che perpetuare quella stessa violenza simbolica contro cui, paradossalmente, ci si ergeva a paladini.
L’antropologia è stata spesso complice e protagonista più o meno consapevole di questa perversione. L’ideale fondativo della disciplina, basato sul proposito di “cogliere il punto di vista del nativo” si è più volte infranto in connivenze neo-coloniali e paternalistiche che hanno proiettato sui nativi, qui intesi come l’Altro da sé, il punto di vista unico dell’osservatore. Quando ciò non è accaduto, il rischio del fraintendimento e della mistificazione – in buona o cattiva fede – ha fatto il resto. Non è un caso, dunque, se proprio un’antropologa come Laura Nader, già agli inizi degli anni ’70 del Novecento, sentì il bisogno di invitare i ricercatori a non occuparsi più, o almeno non solo, di soggetti marginali, poiché – come avrebbe ben sintetizzato Philippe Bourgois – “tutto ciò che direte sarà usato contro di loro”.
Ecco allora che questo libro, nell’offrire al lettore le testimonianze dirette di queste sette donne, a tutti gli effetti le vere autrici del volume che avete tra le mani, non intende occuparsi di loro né intende coglierne il loro presunto punto di vista e, soprattutto, non intende proporre alcuna interpretazione né alcun giudizio morale sulle loro scelte di vita. Più semplicemente, lascia che sia ciascuna di loro a esprimersi, a parlare, a raccontarsi, ciascuna con la sua voce, ciascuna con le sue parole. In qualche modo, avete tra le mani quella che Clifford Geertz, con irridente sarcasmo, avrebbe liquidato come “un’etnografia sulla stregoneria scritta da una strega”, ovvero un’auto-etnografia.
Le pagine che seguono, dunque, lasciano la parola alle protagoniste delle vicende che loro stesse raccontano, nel tentativo di rompere quel silenzio etnografico che gli Ardener, una celebre coppia di antropologi, aveva individuato come uno specifico “problema delle donne” all’interno dell’antropologia. Restituire la voce silenziata, qui, si traduce nel ricorso all’oralità biografica quale fonte diretta di uno specifico racconto di vita, pur nella consapevolezza che rendere pubbliche le storie intime e private di soggetti marginalizzati può costituire un’arma a doppio taglio, poiché espone quelle stesse vite al pericolo di letture stigmatizzanti, dove la responsabilità degli eventi fallimentari che inevitabilmente caratterizzano ogni esistenza viene imputata a condotte esclusivamente individuali. Lettura, questa, che si fonda su – ed è complice di – una concezione specificatamente neoliberista e imprenditoriale di agency perfettamente funzionale all’ideologia della vittima colpevole. Si tratta di una concezione, per dirla ancora una volta con le parole di Bourgois, che “trascura l’influsso esercitato dalla storia, dalla cultura e dalle strutture politico-economiche sulle biografie individuali” e che sorvola dunque su fattori estremamente significativi come l’accesso alle risorse o le discriminazioni di genere: violenze strutturali che si muovono, molto spesso, lungo direttrici di classe e razza.
Nelle storie che le protagoniste di questo libro raccontano, la linea di frontiera tra libera scelta e necessità appare il più delle volte assai sottile, confusa e mutevole. Forse, irrilevante. In questo senso non ci sono eroine o vittime: nessuno da acclamare e nessuno da salvare. Quale ruolo e quale definizione di agency, intesa come la facoltà di esprimere ed esercitare liberamente la propria personalità, possa ricondursi a ciascuna di loro resta una domanda aperta che interroga le nostre stesse esistenze, invitandoci a riflettere anche sulla nostra capacità di scelta quotidiana. Resta valido, dunque, l’appello dell’antropologa femminista Saba Mahmood a esplorare le diverse declinazioni culturali che il concetto di agency può assumere di volta in volta nei diversi contesti locali e nelle singole traiettorie di vita, così da riuscire a scoprirne accezioni forse per noi inconsuete o perfino paradossali. Di qui, secondo Mahmood, “potremmo pensare all’agency non solo come la capacità di attuare un cambiamento progressivo ma anche, soprattutto, come la capacità di sopportare, soffrire e resistere”.
Senza ombra di dubbio, Célestine, Flor, Yvette, Anabel, Nora, Arielle e Liliane sopportano, soffrono e resistono: “masticano e ingoiano”, per dirla con le parole di Liliane. Allo stesso tempo, però, sognano, desiderano, amano e lottano per rivendicare spazi di libertà, autonomia e dignità, per loro stesse e per i loro figli. Inoltre, lavorano, cantano, pregano e ballano. Ma soprattutto, di nuovo: parlano. E mentre parlano, piangono e ridono, mio malgrado, anche di me.
Le loro parole sembrano moltiplicarsi e riprodursi in ogni direzione, facendosi eco e intrecciandosi con le parole sospese di infinite altre storie rimaste inascoltate. Parole – e corpi! – cariche di senso, pregne di esistenza, che rivelano sacrifici, ferite e cicatrici. Ma anche orgoglio, conquiste e gioia. Parole solidali e liberatrici. Parole consapevoli e, per questo, rivoluzionarie.