di Franco Pezzini
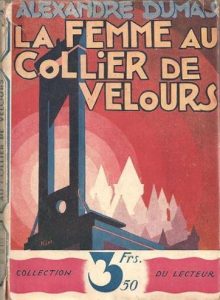 La decollazione nel boudoir (puntata precedente qui)
La decollazione nel boudoir (puntata precedente qui)
La donna dal collier di velluto è una storia di teste tagliate. Certo, lo erano anche le versioni di Irving e Borel, ma Dumas enfatizza il tema a più livelli. Anzitutto presenta una vicenda assai più articolata delle precedenti, passando dalla forma-racconto al romanzo e coinvolgendo il lettore con ben altra intensità emotiva – anche grazie alla sincerità malinconica dell’inizio. In secondo luogo innesta la storia fantastica in un’ampia panoramica sulla rivoluzione (al filtro di una lettura ideologicamente non neutra, sul tema non ci soffermiamo): e in particolare lo spettacolo della spaventosa fine sulla ghigliottina di Madame du Barry già prefigura al lettore in chiave di doppio visibile la successiva morte, questa non descritta e circonfusa d’ombre, della donna dal collier di velluto. Un’altra testa appare effigiata sulla tabacchiera del bizzarro medico-trickster conosciuto da Hoffmann all’Opéra – lo stesso che poi apparirà a sciogliere il collier nella fatale camera d’albergo: «una piccola testa di morto» (La donna, cit., p. 105), un «piccolo teschio di diamanti» (ivi, p. 106), estremamente rivelativo nelle mani di quel personaggio cangiante, sorta di medium o psicopompo a cavallo tra i mondi della vita e della morte, del delirio e dell’irruzione sovrannaturale. Inoltre, come vedevamo, la testa di Arsène rotola via come quella di Antonia sparisce dal ritratto, in un rapporto di parallelismo e oscura specularità.  E infine, chiuso il romanzo, Dumas lo inserisce nel ’51 in quell’ampia raccolta Les mille et un fantômes, il cui primo “capitolo” omonimo – a sua volta costituito da un mosaico di racconti – ritorna con insistenza sul tema delle esecuzioni capitali e in particolare delle decapitazioni, fino ai più macabri dettagli medico-legali (una bella edizione, I Mille e un Fantasma, con i Brogliacci di Paul Lacroix e il saggio introduttivo I fantasmi di Dumas e Lacroix, a cura di Marco Catucci, è da poco apparsa per i tipi Robin, Torino 2018). Lo scrittore – con il complice Lacroix che gli porge una serie di storie nel segno del bizzarro e dello spettrale –
E infine, chiuso il romanzo, Dumas lo inserisce nel ’51 in quell’ampia raccolta Les mille et un fantômes, il cui primo “capitolo” omonimo – a sua volta costituito da un mosaico di racconti – ritorna con insistenza sul tema delle esecuzioni capitali e in particolare delle decapitazioni, fino ai più macabri dettagli medico-legali (una bella edizione, I Mille e un Fantasma, con i Brogliacci di Paul Lacroix e il saggio introduttivo I fantasmi di Dumas e Lacroix, a cura di Marco Catucci, è da poco apparsa per i tipi Robin, Torino 2018). Lo scrittore – con il complice Lacroix che gli porge una serie di storie nel segno del bizzarro e dello spettrale –  sembra insomma particolarmente interessato a tale simbolica, ne esplora le suggestioni e la sviluppa in una serie di variabili. In effetti il tema della testa tagliata, separata dal corpo, reca una ricchissima serie di provocazioni. Solo a titolo di esempio, in rapporto a opere che negli ultimi decenni le hanno incalzate, pensiamo all’uso che ne fa Giuseppe Genna nell’intrigante e amarissimo thriller/noir Le teste (Mondadori, Milano 2009) o alla comparsa quasi contemporanea della traduzione italiana del grande saggio di Julia Kristeva, La testa senza il corpo. Il viso e l’invisibile nell’immaginario dell’Occidente, uscito in Francia nel 1998 (Donzelli, Roma 2009).
sembra insomma particolarmente interessato a tale simbolica, ne esplora le suggestioni e la sviluppa in una serie di variabili. In effetti il tema della testa tagliata, separata dal corpo, reca una ricchissima serie di provocazioni. Solo a titolo di esempio, in rapporto a opere che negli ultimi decenni le hanno incalzate, pensiamo all’uso che ne fa Giuseppe Genna nell’intrigante e amarissimo thriller/noir Le teste (Mondadori, Milano 2009) o alla comparsa quasi contemporanea della traduzione italiana del grande saggio di Julia Kristeva, La testa senza il corpo. Il viso e l’invisibile nell’immaginario dell’Occidente, uscito in Francia nel 1998 (Donzelli, Roma 2009).
 D’altra parte un secondo elemento emerge molto chiaro: ne La donna dal collier di velluto, come nel primo testo della raccolta del ’51, le teste che rotolano sono tutte di donne. Non sembra un caso che Dumas inserisca a un tratto nel dialogo i nomi di Sade e di Justine: e proprio l’icona del supplizio femminile sembra qui costituire il punto d’incontro più inquietante – e peraltro consono alla spettacolarità feticistica odierna – tra strazio del corpo e provocazione sensuale, inabissamento psichico e terrori della Storia. A un livello generale, di salutare messa a fuoco degli aspetti equivoci di questa connessione estetizzante, rinvierei al bel testo di Adriana Cavarero, Orrorismo – ovvero della violenza sull’inerme (Feltrinelli, Milano 2007), e in questa dimensione non mi addentro – del resto il rapporto tra sadismo e agonie romantiche è stato abbondantemente studiato. Tale chiave, comunque, non esaurisce il discorso.
D’altra parte un secondo elemento emerge molto chiaro: ne La donna dal collier di velluto, come nel primo testo della raccolta del ’51, le teste che rotolano sono tutte di donne. Non sembra un caso che Dumas inserisca a un tratto nel dialogo i nomi di Sade e di Justine: e proprio l’icona del supplizio femminile sembra qui costituire il punto d’incontro più inquietante – e peraltro consono alla spettacolarità feticistica odierna – tra strazio del corpo e provocazione sensuale, inabissamento psichico e terrori della Storia. A un livello generale, di salutare messa a fuoco degli aspetti equivoci di questa connessione estetizzante, rinvierei al bel testo di Adriana Cavarero, Orrorismo – ovvero della violenza sull’inerme (Feltrinelli, Milano 2007), e in questa dimensione non mi addentro – del resto il rapporto tra sadismo e agonie romantiche è stato abbondantemente studiato. Tale chiave, comunque, non esaurisce il discorso.
Tanto più che la testa (femminile) che cade è associata a un terzo elemento: una conseguenza fatale, inesorabile, che si abbatte sullo spettatore quasi folgorandolo – sia egli lo sciagurato Gottfried Wolfgang destinato alla follia, sia (a maggior ragione) l’Hoffmann che quel delirio, si immagina, proietterà nei suoi scritti come un’eredità virale. Ciò che Irving e Borel associavano alla pura epifania della Decapitata, Dumas lo riconduce a un meccanismo più complesso e interiormente devastante, legato a un giuramento sacro e a una morte a distanza, in rapporto con un Femminile che spiazza.
Ancora: il teatro di morte del romanzo si riferisce, come abbiamo visto, a un’epoca storica molto precisa. Un’epoca abbastanza vicina a Dumas – come ad altri narratori misuratisi sul tema – da recare un sapore di drammatica contiguità. Anzi un sapore che al narratore francese, erede dei valori di quella Rivoluzione, lascia un retrogusto amaro (o piuttosto dolciastro, ferrigno) e proietta ombre grevi. Tanto più che quei fantasmi, riproposti in infiniti memoriali, ma anche in tutta una ricchissima e pervasiva iconografia, sembrano strutturarsi secondo forme che accedono al mito.
Gli ingredienti, insomma, ci sono tutti. E come in quei giochi ottici dove dobbiamo rilasciare lo sguardo a cogliere un’immagine cifrata, e questa all’improvviso emerge in uno spessore virtuale nella confusione dei segni, il mostruoso rivela una prima immagine. Quel che Dumas sta richiamando sottotesto, attraverso echi e allusioni, è anzitutto il mostro che emerge in filigrana da infinite immagini dei giorni del Terrore: una Dea tremenda la cui icona è la testa tagliata e minacciosa, sollevata a segno pietrificante di un rito pagano. La Gorgone Medusa, insomma.
 A dare la stura al sottotesto mitico di tanta iconografia è il terremoto simbolico dell’esecuzione di Luigi XVI. Spigolando tra le innumerevoli stampe raffiguranti l’esecuzione del re, ne troviamo per esempio una tedesca, anonima, esistente in numerose varianti e in realtà simile a modelli francesi ma più cruda. Un collaboratore del boia appare mostrare al popolo la testa mozzata del consacrato da Dio: si coglie la terribile energia della postura di quest’uomo, l’espressione allucinata e la sensazione che sia spaventato dalla testa che cerca di allontanare da sé, e quasi pietrificato dallo spettacolo che sta offrendo al popolo (cfr. La ghigliottina del Terrore. Catalogo della mostra curata da V. Rousseau-Lagarde e D. Arasse, Torino 17 febbraio – 10 marzo 1987, Polistampa, Firenze 1986, p. 67). Si noti che questo bozzetto lo troviamo riproposto in seguito – stessa postura del carnefice – in un’immagine relativa all’esecuzione di Robespierre. Il nostro Hoffmann avrebbe potuto trovarsi tra le mani proprio questa stampa, e la sua febbre interiore ne sarebbe stata certamente sollecitata.
A dare la stura al sottotesto mitico di tanta iconografia è il terremoto simbolico dell’esecuzione di Luigi XVI. Spigolando tra le innumerevoli stampe raffiguranti l’esecuzione del re, ne troviamo per esempio una tedesca, anonima, esistente in numerose varianti e in realtà simile a modelli francesi ma più cruda. Un collaboratore del boia appare mostrare al popolo la testa mozzata del consacrato da Dio: si coglie la terribile energia della postura di quest’uomo, l’espressione allucinata e la sensazione che sia spaventato dalla testa che cerca di allontanare da sé, e quasi pietrificato dallo spettacolo che sta offrendo al popolo (cfr. La ghigliottina del Terrore. Catalogo della mostra curata da V. Rousseau-Lagarde e D. Arasse, Torino 17 febbraio – 10 marzo 1987, Polistampa, Firenze 1986, p. 67). Si noti che questo bozzetto lo troviamo riproposto in seguito – stessa postura del carnefice – in un’immagine relativa all’esecuzione di Robespierre. Il nostro Hoffmann avrebbe potuto trovarsi tra le mani proprio questa stampa, e la sua febbre interiore ne sarebbe stata certamente sollecitata.
Ma è proprio in seguito alla morte del re che si diffonde un tipo d’immagini anche più astratto e simbolico – anche questo poi riproposto per altri personaggi, Robespierre compreso. Particolarmente esplicito in una celebre acquatinta dell’editore rivoluzionario Villeneuve, il gesto del boia che solleva la testa mozzata del re, isolato però dal contesto,
si riduce a un avambraccio anonimo, rappresentante incontestabile della giustizia esercitata in nome del popolo. Viene così fissato una volta per sempre il valore di questo gesto dimostrativo che, nella tradizione delle immagini, è quello di Perseo che pietrifica Polidette mentre mostra la testa tagliata di Medusa. Nel rituale dell’esecuzione rivoluzionaria, l’esibizione della testa è destinata a terrificare, anzi, a pietrificare i nemici della patria. Di conseguenza, la testa del ghigliottinato diventa il suo vero volto smascherato nella morte e questo tipo di iconografia può essere definito “ritratto del traditore smascherato” [La ghigliottina del Terrore, cit., p. 51].
Nel senso che il volto dell’ultimo istante, come in un conato di terribile verità, coi suoi tratti e l’espressione assunta smaschererebbe il traditore: e in effetti, nel romanzo di Dumas, la testa tagliata è memoria e denuncia per Hoffmann del suo tradimento di Antonia e dei voti fattile.
Si noti che questo continuo ritorno delle immagini della morte del re e della sua testa, ostentata a pietrificare i nemici della patria, va ben oltre l’orizzonte delle stampe popolari: le troviamo su medaglie, coperchi di scatole e oggettistica varia, porcellane – dove magari la tazza cela l’immagine effigiata sul piattino sottostante, come nell’effetto moralizzatore della morte nascosta e poi rivelata delle anamorfosi…
Ma gli oggetti tradiscono lo spirito dell’epoca: e così, quando lo spiacevole medico dalla tabacchiera con la testa di morto brandisce un binocolo, la persona che si vede fissata attraverso quelle lenti, «chiunque fosse, trasaliva immediatamente e subito volgeva gli occhi verso chi la guardava, come se vi fosse stata costretta da un invisibile potere. E restava in tale posizione finché lo straordinario medico cessava di fissarla» (La donna, cit., pag. 109 – corsivo mio): restava cioè pietrificata da quello sguardo gorgonico. Certo qui Dumas strizza l’occhio all’Hoffmann narratore, ai cannocchiali dell’allarmante Coppola/Coppelius di L’uomo della sabbia, un figuro oniricamente bifronte come (scopriremo) questo medico che ha due diverse forme di apparizione. Ma il motivo della lente che ammicca a una visione diversa, e a una diversa messa a fuoco di quel mondo sottile ai confini indecidibili dell’incubo, per Dumas non si consuma nel semplice delirio. La gorgonizzazione legata alle lenti, infatti, non è imputabile solo alla personalità inquietante del medico: il binocolo, specifica questi, gli viene dall’amico Voltaire, dunque è in fondo, simbolicamente, la lente stessa dei Lumi. E come ad aggiungere un ulteriore livello di spiegazione, è a questo punto che il medico cita Justine di Sade: il suo accenno fuggevole a «una giovanissima donna che aveva letto quel romanzo» (ivi, p. 110) ed è «morta felicissima» (ibidem) – «E l’occhio del medico scintillò di piacere al ricordo delle cause di quella morte» (ibidem) – reca il senso della saldatura tra Lumi, libertinismo e orrore che qui sembra costituire un sotterraneo specifico, personale e culturale, dello sguardo gelido di Medusa. Non a caso, subito dopo viene dato il segnale del secondo atto (siamo all’Opéra) e il medico annuncia: «Ora vedremo Arsène» (ibidem).
Quando poi la danzatrice appare – bellissima, con la flessuosità di una lucertola (ivi, p. 112) a richiamare un’affinità coi rettili non incongrua in una parente delle Gorgoni – e Hoffmann si fa sfuggire un commento ammirato ad alta voce, lo sguardo di lei dal palco gli fa l’effetto di una scarica elettrica (ivi, p. 111): ancora una volta un occhio che folgora e mesmerizza, un occhio da basilisco o con effetto gorgonico. Evidente quando Hoffmann scopre di non poter quasi allontanarne lo sguardo, e per riuscirvi è costretto a «uno sforzo così doloroso che emise un grido, come se i nervi del collo, divenuti di marmo, gli si fossero spezzati in quel momento» (ivi, p. 114). Ma, come nota Hoffmann/Dumas, «una visibile correlazione si era stabilita tra i […] due sguardi» (ivi, p. 112) di Arsène e del medico, e anzi «vedeva distintamente i raggi che uscivano dai diamanti del fermaglio di Arsène [quello che trattiene il fatale collier di velluto viola] incontrarsi a mezza via con quelli che uscivano dalla testa di morto sulla tabacchiera del dottore in una linea retta, urtarsi, respingersi, e scaturire di nuovo in un fascio unico fatto di migliaia di scintille bianche, rosse e oro» (ivi, pp. 112-113). Uno scambio che parla il linguaggio del fato, e annuncia la sorte di Arsène ma insieme la potenza simbolica di un dramma, una sorta di riconoscimento del gorgoneion sulla strada di Hoffmann. Quella correlazione tra l’occhio del serpente e l’uccello che affascina (ivi, p. 121) inseguirà in forma allucinatoria Hoffmann anche in seguito: e ricordiamo che sarà proprio quel medico, alla fine del romanzo, a salire alla stanza riconoscendo il cadavere di Arsène. Suscitando nel lettore il dubbio che tutta la vicenda sia in realtà una rilettura a posteriori in chiave di delirio.
 Scopriremo anzi che il fermaglio del collier di Arsène ha forma di ghigliottina. «Sì, ne fanno di graziose» commenta il dottore «e tutte le nostre donne raffinate ne portano almeno una» (ivi, p. 115). Ma il giovane si è fatto passare il binocolo, e attraverso quelle lenti fatali, per un bizzarro effetto ottico (ancora le lenti de L’uomo della sabbia), il giovane tedesco ha una sorta di amplesso con Arsène – un amplesso necrofilo in cui si sovrappongono le emozioni della giornata, l’immagine danzante diventa quella di Madame du Barry con la testa mozza, o viceversa Arsène appare danzando fino ai piedi della ghigliottina e tra le mani del boia. Il desiderio monta a tal punto che Hoffmann, dopo aver invano cercato soccorso nel talismanico ritratto di Antonia (altra testa), è costretto a fuggire dalla sala. Quando più tardi torna però davanti all’uscita degli attori per rivedere Arsène, «agitato da quella strana apparizione» (ivi, p. 119), non nota nemmeno il freddo e la neve che cade, trasformando «la redingote tedesca in una statua di marmo» (ibidem). Ancora insomma la pietrificazione: come nel dramma mitico della Gorgone ma in termini liberissimi, gli elementi dello sguardo fatale e della mutazione in pietra vengono cioè riproposti in una serie di suggestioni, fino alle estreme latitudini del concetto. Come quando più tardi Hoffmann, arricchitosi al gioco per farsi bello con Arsène, torna alla casa di lei e pregusta «la gioia di coprire con tutto quell’oro il bel corpo che gli si era svelato e che, rimasto di marmo davanti al suo amore, si sarebbe animato davanti alla sua ricchezza, come la statua di Prometeo quando ebbe trovato la sua vera anima» (ivi, p. 160). Dove il richiamo a un procedimento inverso alla pietrificazione gorgonica denuncia in fondo l’arida Arsène come vuoto simulacro, statua di pietra, proprio attraverso la squallida prospettiva di un’animazione per lucro.
Scopriremo anzi che il fermaglio del collier di Arsène ha forma di ghigliottina. «Sì, ne fanno di graziose» commenta il dottore «e tutte le nostre donne raffinate ne portano almeno una» (ivi, p. 115). Ma il giovane si è fatto passare il binocolo, e attraverso quelle lenti fatali, per un bizzarro effetto ottico (ancora le lenti de L’uomo della sabbia), il giovane tedesco ha una sorta di amplesso con Arsène – un amplesso necrofilo in cui si sovrappongono le emozioni della giornata, l’immagine danzante diventa quella di Madame du Barry con la testa mozza, o viceversa Arsène appare danzando fino ai piedi della ghigliottina e tra le mani del boia. Il desiderio monta a tal punto che Hoffmann, dopo aver invano cercato soccorso nel talismanico ritratto di Antonia (altra testa), è costretto a fuggire dalla sala. Quando più tardi torna però davanti all’uscita degli attori per rivedere Arsène, «agitato da quella strana apparizione» (ivi, p. 119), non nota nemmeno il freddo e la neve che cade, trasformando «la redingote tedesca in una statua di marmo» (ibidem). Ancora insomma la pietrificazione: come nel dramma mitico della Gorgone ma in termini liberissimi, gli elementi dello sguardo fatale e della mutazione in pietra vengono cioè riproposti in una serie di suggestioni, fino alle estreme latitudini del concetto. Come quando più tardi Hoffmann, arricchitosi al gioco per farsi bello con Arsène, torna alla casa di lei e pregusta «la gioia di coprire con tutto quell’oro il bel corpo che gli si era svelato e che, rimasto di marmo davanti al suo amore, si sarebbe animato davanti alla sua ricchezza, come la statua di Prometeo quando ebbe trovato la sua vera anima» (ivi, p. 160). Dove il richiamo a un procedimento inverso alla pietrificazione gorgonica denuncia in fondo l’arida Arsène come vuoto simulacro, statua di pietra, proprio attraverso la squallida prospettiva di un’animazione per lucro.
Ma torniamo al Nostro pietrificato dal gelo. Arsène scompare immediatamente sulla carrozza di Danton, Hoffmann la insegue invano: e quando un paio di giorni dopo, ossessionato dall’immagine di lei, torna a teatro e apprende che i suoi gesti inconsulti durante e dopo lo spettacolo hanno segnato la rovina della diva e il suo allontanamento, il teatro e il medico stesso appaiono completamente diversi, privi di ogni lustro od orpello. Il visionario Hoffmann scopre così che l’ambiente visto due giorni prima apparteneva a una realtà passata – l’Opéra prima della rivoluzione, luccicante di gioielli ed eleganza – rievocata come per magia; il medico non ha tabacchiere preziose ed è un uomo qualunque, gli spettatori in sala sono poveracci, e persino i busti esposti (le ennesime teste) non raffigurano più Apollo e Tersicore come pareva a Hoffmann, ma Voltaire e Marat. Era la presenza di Arsène, spiega il medico, a trasfigurare tutto: «vi dico che l’amate, giovanotto, e che avete visto la sala attraverso il prisma del vostro amore» (ivi, p. 125). Eppure, ancora una volta, il discorso non si esaurisce qui: il dottore confida di non aver mai posseduto, neppure nei tempi più prosperi, una tabacchiera con pietre preziose come quella ostentata dal suo alter ego. Tutto ciò appartiene dunque a una dimensione sospesa tra l’allucinazione e qualche diverso piano della realtà: cioè Dumas rende partecipe il lettore, attraverso il suo gioco a più livelli, di una percezione sottotesto. Ed è con questo binocolo (per rifarci all’immagine già hoffmanniana delle lenti che colgono la realtà a una diversa distanza e profondità) che noi stiamo esplorando il romanzo, e troviamo la Gorgone. Come la Gorgone non si consuma in un’identità divina ma è al centro di una costellazione che comprende la testa tagliata e lo specchio, lo sguardo fatale, la pietrificazione e i serpenti, così anche qui ciò che rileva non è una banale identificazione tra Arsène e Medusa ma un contesto dinamico, un dramma mitico in cui i singoli elementi si compenetrano e si riassestano continuamente.
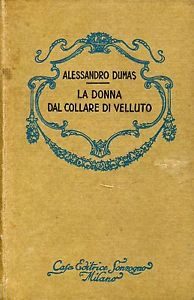 Così il dottore, come l’inquietante e indecidibile Coppola/Coppelius di L’uomo della sabbia riappare a Hoffmann qualche tempo dopo nel suo primo sembiante ingioiellato: spiega che il giovane avrebbe potuto rintracciarlo con facilità chiedendone l’indirizzo «al primo cimitero […] incontrato» (ivi, p. 131) e domandando del dottore dalla testa di morto (ibidem). Si definisce anzi il medico dell’Opéra (ibidem), ma alla fine del romanzo, davanti al corpo reclino di Arsène, spiegherà di essere il medico delle prigioni (ivi, p. 174): due ambiti in apparenza antitetici e saldati oniricamente attraverso la natura indecidibile di questa figura bifronte – ma con una tragica contiguità nel teatro del supplizio in piazza. Ridestandosi nell’Opéra ormai deserta dove si è assopito o passando nottetempo ai piedi della ghigliottina, Hoffmann si confronta con scene paradossalmente simili.
Così il dottore, come l’inquietante e indecidibile Coppola/Coppelius di L’uomo della sabbia riappare a Hoffmann qualche tempo dopo nel suo primo sembiante ingioiellato: spiega che il giovane avrebbe potuto rintracciarlo con facilità chiedendone l’indirizzo «al primo cimitero […] incontrato» (ivi, p. 131) e domandando del dottore dalla testa di morto (ibidem). Si definisce anzi il medico dell’Opéra (ibidem), ma alla fine del romanzo, davanti al corpo reclino di Arsène, spiegherà di essere il medico delle prigioni (ivi, p. 174): due ambiti in apparenza antitetici e saldati oniricamente attraverso la natura indecidibile di questa figura bifronte – ma con una tragica contiguità nel teatro del supplizio in piazza. Ridestandosi nell’Opéra ormai deserta dove si è assopito o passando nottetempo ai piedi della ghigliottina, Hoffmann si confronta con scene paradossalmente simili.
Comunque il giovane non si deve disperare per la scomparsa di Arsène, perduta nel labirinto di Parigi: ella infatti ha incaricato il medico di cercarle un pittore che la ritragga, e l’artista Hoffmann si offre con entusiasmo. Una carrozza tenebrosa chiamata dal dottore conduce il giovane a casa di Arsène, e la Bellissima appare da una porta nascosta «dietro uno specchio mobile» (ivi, pp. 135-136): come, viene da pensare, quello di Perseo. L’accesso all’immagine della Gorgone è possibile solo tramite uno specchio, e in queste pagine di epifania di Arsène il richiamo allo specchio torna ossessivamente. Arsène vuole farsi ritrarre in costume da Baccante, e la sconvolgente esperienza del suo denudamento vede una rifrazione entro gli specchi del boudoir; poi Hoffmann viene improvvisamente buttato fuori (è arrivato l’amante in carica), e umiliato comprende che per la mantenuta di lusso egli rappresenta un pittore qualunque, «una macchina da ritratti, come uno specchio che riflette i corpi che gli si presentano» (ivi, p. 142).
 Ma anche la locuzione “macchina da/per ritratti” è significativa: proprio la ghigliottina è stata definita come “macchina per ritratti”, nel senso che isolando la testa del ghigliottinato, la mette sotto gli occhi dello spettatore. Suggestivo constatare come nel romanzo, in parallelo all’isolarsi “in ritratto” della testa mozza di Arsène, sparisce quella del ritratto di Antonia. D’altra parte proprio il citato tema del “traditore smascherato” riconduce a un ritratto-maschera in cui si condensa e riassume tutta la storia dell’individuo e il senso della sua vita (La ghigliottina del Terrore, cit., pag. 169). Una maschera: il che da un lato richiama all’uso, proprio durante la rivoluzione, di maschere funerarie rapidamente modellate sui tratti dei giustiziati, come volti ingrigiti dalla pietrificazione gorgonica; e dall’altro alla stessa Gorgone, figura-maschera anche nell’accezione più materiale. Un po’ tutta la Rivoluzione francese – ma in particolare la sua fase più drammatica, il Terrore – è all’insegna di questo volto di dea irriconosciuta in demone, dea-maschera o dea-testa, sorta di Bafometto corrucciato (e a proposito dell’idolo-testa Bafometto ricordiamo la mitologia sulla vendetta dei Templari consumata proprio in quei giorni con l’esecuzione del re Capeto). Un mostro immagine di un Femminile scatenato e sconvolgente: simbolica adatta, del resto, a quella Rivoluzione Francese in cui le donne si conquistano la «scena pubblica come vittime e come mandanti. Una furia da baccanti [ricordiamo che così voleva vestirsi Arsène per il ritratto] aveva soffiato sulla storia, e le donne volgevano a se stesse un volto inconoscibile, troppo vicino all’indistinto primordiale» (V. Papetti, La “debole mano” della signora Radcliffe, Introduzione ad Ann Radcliffe, I misteri di Udolpho, Bur Rizzoli, Milano 2010, p. 23), tra aspersioni lunari di sangue, gioielli a forma di ghigliottine e carmagnole sfrenate in abiti da sacerdotesse – coi musicanti magari abbigliati da satiri. Se Dioniso aveva insomma casa in Francia nei giorni del Terrore, il volto terrifico della Dea lo accompagnava. E se la mutazione artistica del volto di Medusa, da grottesco com’era
Ma anche la locuzione “macchina da/per ritratti” è significativa: proprio la ghigliottina è stata definita come “macchina per ritratti”, nel senso che isolando la testa del ghigliottinato, la mette sotto gli occhi dello spettatore. Suggestivo constatare come nel romanzo, in parallelo all’isolarsi “in ritratto” della testa mozza di Arsène, sparisce quella del ritratto di Antonia. D’altra parte proprio il citato tema del “traditore smascherato” riconduce a un ritratto-maschera in cui si condensa e riassume tutta la storia dell’individuo e il senso della sua vita (La ghigliottina del Terrore, cit., pag. 169). Una maschera: il che da un lato richiama all’uso, proprio durante la rivoluzione, di maschere funerarie rapidamente modellate sui tratti dei giustiziati, come volti ingrigiti dalla pietrificazione gorgonica; e dall’altro alla stessa Gorgone, figura-maschera anche nell’accezione più materiale. Un po’ tutta la Rivoluzione francese – ma in particolare la sua fase più drammatica, il Terrore – è all’insegna di questo volto di dea irriconosciuta in demone, dea-maschera o dea-testa, sorta di Bafometto corrucciato (e a proposito dell’idolo-testa Bafometto ricordiamo la mitologia sulla vendetta dei Templari consumata proprio in quei giorni con l’esecuzione del re Capeto). Un mostro immagine di un Femminile scatenato e sconvolgente: simbolica adatta, del resto, a quella Rivoluzione Francese in cui le donne si conquistano la «scena pubblica come vittime e come mandanti. Una furia da baccanti [ricordiamo che così voleva vestirsi Arsène per il ritratto] aveva soffiato sulla storia, e le donne volgevano a se stesse un volto inconoscibile, troppo vicino all’indistinto primordiale» (V. Papetti, La “debole mano” della signora Radcliffe, Introduzione ad Ann Radcliffe, I misteri di Udolpho, Bur Rizzoli, Milano 2010, p. 23), tra aspersioni lunari di sangue, gioielli a forma di ghigliottine e carmagnole sfrenate in abiti da sacerdotesse – coi musicanti magari abbigliati da satiri. Se Dioniso aveva insomma casa in Francia nei giorni del Terrore, il volto terrifico della Dea lo accompagnava. E se la mutazione artistica del volto di Medusa, da grottesco com’era  nell’arte greca a più semplicemente femminile, ancorché anguicrinito e cereo, appare diffusa fin dal Rinascimento, la svolta definitiva può ravvisarsi proprio «in un tempo tanto mitologico», come lo definisce Dumas (La donna, cit., p. 100), quale la stagione rivoluzionaria: quando cioè la Gorgone decollata assurge a figura della “libertà alla francese” come – per gli intellettuali oltremanica – la saggia ed equilibrata Atena del contraltare “all’inglese”.
nell’arte greca a più semplicemente femminile, ancorché anguicrinito e cereo, appare diffusa fin dal Rinascimento, la svolta definitiva può ravvisarsi proprio «in un tempo tanto mitologico», come lo definisce Dumas (La donna, cit., p. 100), quale la stagione rivoluzionaria: quando cioè la Gorgone decollata assurge a figura della “libertà alla francese” come – per gli intellettuali oltremanica – la saggia ed equilibrata Atena del contraltare “all’inglese”.
Tra i mostri-femmina delle mitologie d’Occidente la Gorgone è forse il più emblematico. Una figura i cui protomodelli sprofondano in un passato lontanissimo, fino a quelle maschere neolitiche della Dea della morte che sembrano plausibili prototipi del gorgoneion, il pietrificante capo di Medusa, o persino più indietro. Il nome del resto che in greco suona una sorta d’epiteto (gorgós, “terribile”) potrebbe provenire dal sanscrito garjana, sorta di onomatopea di un ringhio bestiale (garg come urlo). Il tema della mutazione delle vittime in pietra legata alla fatalità della maschera sacra ben si sposa con la funzione (come per altri mostri ibridi) di protettrice di edifici. Ciò che non semplifica la comprensione agli imbarazzati mitologi del mondo classico, che si interesseranno particolarmente a Medusa, unica mortale di tre Gorgoni sorelle e caduta – in qualche passato remoto – sotto la spada falcata dell’eroe maschio Perseo. Comunque un mostro, bloccato nell’atto di una boccaccia apotropaica dal valore forse magico: eppure le sue caratteristiche (compresi i nessi del termine greco con una costellazione semantica legata all’idea di “regnare”, cfr. qui) finiscono col richiamarla a una dignità ben più alta, all’aspetto minaccioso della grande Dea della vita e della morte. Gli Orfici chiameranno non casualmente gorgoneion il volto della luna, e tale lascito lunare permarrà ancora nelle vamp spettrali romantiche e simboliste – compreso dunque lo spettro di Arsène. Perché, a grattare la vernice della maschera, la mostruosità di Medusa si rivela in fondo la minacciosità mitizzata, irriconosciuta della donna: e questo aspetto, in pulsioni, fremiti e polluzioni, erutterà nell’arte tra Otto e Novecento. Quando diventa oggetto di una vera e propria ossessione, spostando spesso l’attenzione dal contesto generale (Perseo sparisce) alla testa di lei: e non necessariamente tagliata, anche se il distinguo diventa relativo. Del resto nel mito gorgonico si intrecciano temi diversi e spesso (non sempre) equivoci: così, accanto al rapporto tra femminile e mostruoso – e tra donna e serpente –  troviamo il motivo della fascinazione fatale (la femme fatale, appunto) che pietrifica in una succube passività; il tema dello specchio, che permette di contemplare l’incontemplabile, fino alle ultime interpretazioni come metafora per il cinema; la decollazione da parte dell’eroe virile… Lo stesso urlo (garg), permette di decrittare anche in questa chiave il soggetto androgino – del resto l’antica Gorgone aveva connotati spesso bisessuali in un’identità femminile – di un’intera nebulosa di opere di Edvard Munch: emblematico è il bozzetto conservato al Bergen Kunstmuseum dove vediamo solo la testa urlante tra una foresta di mani disperatamente sollevate. Un tema insomma che impatta con incredibile potenza sulla modernità, sia in forme artisticamente “alte” – per le quali si rinvia a Jean Clair nel suo celebre saggio Méduse. Contribution à une anthropologie des arts du visuel (Gallimard, Paris 1989, tr. it.: Medusa. L’orrido e il sublime nell’arte, Leonardo, Milano 1989) – sia in altre di un immaginario molto più popolare.
troviamo il motivo della fascinazione fatale (la femme fatale, appunto) che pietrifica in una succube passività; il tema dello specchio, che permette di contemplare l’incontemplabile, fino alle ultime interpretazioni come metafora per il cinema; la decollazione da parte dell’eroe virile… Lo stesso urlo (garg), permette di decrittare anche in questa chiave il soggetto androgino – del resto l’antica Gorgone aveva connotati spesso bisessuali in un’identità femminile – di un’intera nebulosa di opere di Edvard Munch: emblematico è il bozzetto conservato al Bergen Kunstmuseum dove vediamo solo la testa urlante tra una foresta di mani disperatamente sollevate. Un tema insomma che impatta con incredibile potenza sulla modernità, sia in forme artisticamente “alte” – per le quali si rinvia a Jean Clair nel suo celebre saggio Méduse. Contribution à une anthropologie des arts du visuel (Gallimard, Paris 1989, tr. it.: Medusa. L’orrido e il sublime nell’arte, Leonardo, Milano 1989) – sia in altre di un immaginario molto più popolare.
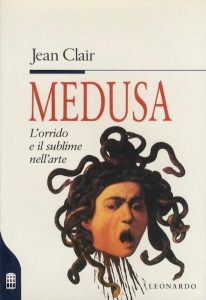 Infatti il rapporto della Gorgone con il genere horror è molto più stretto di quanto spesso si creda. Si pensi alla decapitazione di dark lady letterarie come Milady de Winter (cioè ‘dell’inverno’, un nome adatto al volto oscuro della Dea) che lo stesso Dumas pone in scena ne I tre moschettieri; o alle vampire di letteratura e cinema, eredi e ipostasi della Terribile Femmina in un tripudio di vagine dentate e denti fallici, che inevitabilmente dopo il trattamento col paletto richiedono il taglio della testa. Ma si è già accennato alla Gorgone portata in scena da Fisher per la Hammer: un film che narra di uomini alla deriva, e di una donna che suo malgrado e senza saperlo, travolta da amnesie lunari, è posseduta dallo spirito del Mostro-Femmina. Ancora il Bram Stoker’s Dracula di Francis Ford Coppola, 1992, vede una delle vampire del castello del Conte dotata di una chioma medusea con serpenti. Nel romanzo, infatti, davanti a una di loro, l’ospite Jonathan Harker ha la sensazione di averla già incontrata, senza però ricordare dove: e se oggi sappiamo trattarsi di un riferimento alla vampira del racconto-frammento Dracula’s Guest (o meglio di un testo simile nelle prime cento pagine rimosse del romanzo), tra le possibili identificazioni c’era appunto Medusa – e probabilmente di lì gli sceneggiatori mutueranno la suggestione del film. Certo il riferimento a un ricordo sfuggente, un conosciuto/non riconosciuto dalle forti implicazioni erotiche reca per noi un senso molto preciso nel segno del Perturbante. E che questo si associ alla Gorgone, mostro sottotesto di una storia plurimillenaria e dello stesso romanzo di Dumas che abbiamo tra le mani, pare qualcosa di estremamente rivelativo.
Infatti il rapporto della Gorgone con il genere horror è molto più stretto di quanto spesso si creda. Si pensi alla decapitazione di dark lady letterarie come Milady de Winter (cioè ‘dell’inverno’, un nome adatto al volto oscuro della Dea) che lo stesso Dumas pone in scena ne I tre moschettieri; o alle vampire di letteratura e cinema, eredi e ipostasi della Terribile Femmina in un tripudio di vagine dentate e denti fallici, che inevitabilmente dopo il trattamento col paletto richiedono il taglio della testa. Ma si è già accennato alla Gorgone portata in scena da Fisher per la Hammer: un film che narra di uomini alla deriva, e di una donna che suo malgrado e senza saperlo, travolta da amnesie lunari, è posseduta dallo spirito del Mostro-Femmina. Ancora il Bram Stoker’s Dracula di Francis Ford Coppola, 1992, vede una delle vampire del castello del Conte dotata di una chioma medusea con serpenti. Nel romanzo, infatti, davanti a una di loro, l’ospite Jonathan Harker ha la sensazione di averla già incontrata, senza però ricordare dove: e se oggi sappiamo trattarsi di un riferimento alla vampira del racconto-frammento Dracula’s Guest (o meglio di un testo simile nelle prime cento pagine rimosse del romanzo), tra le possibili identificazioni c’era appunto Medusa – e probabilmente di lì gli sceneggiatori mutueranno la suggestione del film. Certo il riferimento a un ricordo sfuggente, un conosciuto/non riconosciuto dalle forti implicazioni erotiche reca per noi un senso molto preciso nel segno del Perturbante. E che questo si associ alla Gorgone, mostro sottotesto di una storia plurimillenaria e dello stesso romanzo di Dumas che abbiamo tra le mani, pare qualcosa di estremamente rivelativo.
[3-Continua]



