di Franco Pezzini
 Hoffmann in Love (puntata precedente qui)
Hoffmann in Love (puntata precedente qui)
Quando Alexandre Dumas pone mano a La femme au collier de velours, 1849, in Francia le fantasie “alla Hoffmann”, storie oniriche e bizzarre popolate di spettri, non costituiscono più una novità. Anzi la stessa vicenda che qui Dumas narra non è, almeno a grandi linee, farina del suo sacco: tanto che lui dichiara di riferire semplicemente un racconto affidatogli dall’amico più anziano Charles Nodier, letterato elegante e fantasioso, eruditissimo bibliofilo e appunto cultore di storie strane, ormai sul letto di morte. «Adesso, la storia che leggerete è quella che mi raccontò Nodier», afferma Dumas a chiusura del primo capitolo (ed. cit., p. 36).
Non possiamo escludere che sia così, e non solo – come vedremo – per il tono tanto solenne dell’affermazione. Ma se dovessimo identificare una fonte letteraria diretta a ‘La donna dal collier di velluto’ dovremmo fare qualche altro nome – e per esempio un soprannome che, guarda caso, ci richiama proprio alla galleria dei mostri. Sto parlando del truce Pétrus Borel detto “Le lycanthrope”, al secolo Pierre Borel d’Hauterive, maestro del nero nella Francia del primo Ottocento, nonché leader di quella bohème artistica del petit-cénacle dell’inizio degli anni Trenta che annoverava Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Philothée O’Neddy, e altri nomi eccellenti. Si parlerà di Frenetismo per indicare la corrente di questi romantici – soprattutto Borel – che si compiacciono di cercare ispirazione in gotici come Walpole e “Monk” Lewis. E del resto quando nel ’43 Borel pubblica sulla rivista «La Sylphide» il racconto Gottfried Wolfgang – scritto probabilmente nel 1840 – si tratta proprio di un ripescaggio, una traduzione/appropriazione, di una storia nera in lingua anglosassone, cioè il racconto The Adventure of the German Student dell’americano Washington Irving.
Insomma, dietro Dumas troviamo Borel, e dietro a Borel c’è Irving – sotto lo pseudonimo di Geoffrey Crayon. È infatti così che l’autore americano firma la raccolta Tales of a Traveller, 1824, di cui fa parte The Adventure of the German Student. Si noti che l’opera è composta nel periodo in cui Irving vive in Europa, in particolare in Germania e a Parigi: dato non casuale ai fini del contenuto del racconto. Protagonista è lo studente Gottfried Wolfgang, imbevuto delle più visionarie dottrine metafisiche in voga in Germania, e tormentato dalla convinzione di una malvagia influenza che graverebbe su di lui. Gli amici pensano che la miglior cura per le sue ubbie consista in un cambio d’ambiente, e insomma fanno in modo che vada a finire gli studi in mezzo alle piacevolezze di Parigi. Peccato che, quando il giovane ci arriva, la situazione nella capitale francese stia esplodendo: si scatena la Rivoluzione, e Gottfried all’inizio è partecipe dell’entusiasmo collettivo. Visto però che è sensibile d’animo, gli eccessi e le stragi finiscono col disgustarlo: col risultato che ricomincia a vivere da recluso, ripiegato sui suoi studi di volumi dimenticati – al punto che Irving lo definisce «un ghoul letterario, nutrito nell’ossario della letteratura in dissoluzione» (Borel, nella sua traduzione-riscrittura, ripropone la definizione sostituendo solo il termine vampire al ghoul di Irving, e una traccia “ammorbidita” sembra trovarsi in Dumas nel riferimento a quel Nodier che «trovava fra i libri capolavori ignoti, che traeva dalla tomba delle biblioteche», p. 29).  Questa è la situazione quando una notte di temporale, nel periodo più buio del Terrore, il malinconico Gottfried si trova a passare in Place de Grève, proprio vicino alla ghigliottina; e lì, alla luce dei lampi, si accorge di una donna vestita di nero, seduta sotto la pioggia proprio sui gradini che conducono al patibolo. Commosso dall’aria desolata di lei, la avvicina: e resta sconvolto riconoscendo in quella giovane donna bellissima la protagonista di certi sogni che hanno continuato a visitarlo, lasciandogli addosso un febbrile innamoramento per lei. Ora se la trova innanzi in carne e ossa, e possiamo immaginare il tumulto interiore. La donna accenna di non avere amici né casa – o meglio, accenna di averla nella tomba – e lo studente non trova di meglio che offrirle ospitalità nella propria stanza per la notte. Lei accetta, e quando Gottfried può contemplarla alla luce del locale è «più che mai intossicato dalla sua bellezza»: per inciso, unico ornamento alla semplicità dell’abito nero è «una larga fascia nera attorno al suo collo, fermata da diamanti» (Borel specificherà che è di velluto). Già affascinato, Gottfried scopre nella donna uno spirito affine, come lui entusiasta e appassionata; e quando le rivela di averla amata attraverso i sogni, ella confida un parallelo misterioso impulso verso di lui. Arrivano anzi a promettersi reciprocamente per sempre, e Irving lascia pensare che la notte dei due insieme corra piacevole. Al mattino lo studente lascia dormire “la sua sposa”, e corre a cercare un alloggio più spazioso in cui trasferirsi insieme: ma quando rientra e cerca di svegliarla, lei non gli risponde ed è fredda. Gottfried chiama allora aiuto, accorre un poliziotto… e riconosce il corpo per quello di una donna ghigliottinata il giorno prima. Col risultato che, quando scioglie la fascia nera dal collo, la testa rotola sul pavimento (in Borel è lo studente a rimuovere la fascia ma – pare strano per un autore dalla fama tanto nera – manca il rotolare della testa). Insomma, Gottfried precipita nuovamente nelle vecchie angosce, si convince che uno spirito maligno abbia preso possesso di quel corpo (si trattenga questo dettaglio), e restiamo sospesi tra l’ipotesi spettrale e quella della follia – anche perché il povero Wolfgang finirà col morire in manicomio. Per chi ama il genere, una memorabile versione a fumetti della storia di Irving curata da Archie Goodwin e Jerry Grandenetti (Creepy Archives, Vol. 3) era stata antologizzata a suo tempo nelle vecchie raccolte di Zio Tibia.
Questa è la situazione quando una notte di temporale, nel periodo più buio del Terrore, il malinconico Gottfried si trova a passare in Place de Grève, proprio vicino alla ghigliottina; e lì, alla luce dei lampi, si accorge di una donna vestita di nero, seduta sotto la pioggia proprio sui gradini che conducono al patibolo. Commosso dall’aria desolata di lei, la avvicina: e resta sconvolto riconoscendo in quella giovane donna bellissima la protagonista di certi sogni che hanno continuato a visitarlo, lasciandogli addosso un febbrile innamoramento per lei. Ora se la trova innanzi in carne e ossa, e possiamo immaginare il tumulto interiore. La donna accenna di non avere amici né casa – o meglio, accenna di averla nella tomba – e lo studente non trova di meglio che offrirle ospitalità nella propria stanza per la notte. Lei accetta, e quando Gottfried può contemplarla alla luce del locale è «più che mai intossicato dalla sua bellezza»: per inciso, unico ornamento alla semplicità dell’abito nero è «una larga fascia nera attorno al suo collo, fermata da diamanti» (Borel specificherà che è di velluto). Già affascinato, Gottfried scopre nella donna uno spirito affine, come lui entusiasta e appassionata; e quando le rivela di averla amata attraverso i sogni, ella confida un parallelo misterioso impulso verso di lui. Arrivano anzi a promettersi reciprocamente per sempre, e Irving lascia pensare che la notte dei due insieme corra piacevole. Al mattino lo studente lascia dormire “la sua sposa”, e corre a cercare un alloggio più spazioso in cui trasferirsi insieme: ma quando rientra e cerca di svegliarla, lei non gli risponde ed è fredda. Gottfried chiama allora aiuto, accorre un poliziotto… e riconosce il corpo per quello di una donna ghigliottinata il giorno prima. Col risultato che, quando scioglie la fascia nera dal collo, la testa rotola sul pavimento (in Borel è lo studente a rimuovere la fascia ma – pare strano per un autore dalla fama tanto nera – manca il rotolare della testa). Insomma, Gottfried precipita nuovamente nelle vecchie angosce, si convince che uno spirito maligno abbia preso possesso di quel corpo (si trattenga questo dettaglio), e restiamo sospesi tra l’ipotesi spettrale e quella della follia – anche perché il povero Wolfgang finirà col morire in manicomio. Per chi ama il genere, una memorabile versione a fumetti della storia di Irving curata da Archie Goodwin e Jerry Grandenetti (Creepy Archives, Vol. 3) era stata antologizzata a suo tempo nelle vecchie raccolte di Zio Tibia.
Può interessarci fino a un certo punto se Dumas conoscesse entrambe le versioni (Irving e Borel) e, nel caso, quale abbia letto per prima. Quel che rileva è il bacino da cui attinge, e a cui attingono altri per storie analoghe, in quel periodo o più tardi, come Paul Lacroix, Gaston Leroux eccetera.
E infatti Irving si era ispirato a storie precedenti. Lui la sua versione l’aveva sentita dall’irlandese Thomas Moore, a cui però era giunta da Horace Smith, amico degli coniugi Shelley che ne aveva reso una variante più simile ai modelli originali, Sir Guy Eveling’s Dream, 1823: dove la città era Londra e la donna non era stata ghigliottinata ma impiccata, e il segno da tener nascosto era quello della corda. Ciò nel mondo anglosassone.
Mentre in Francia la storia correva per i repertori di storie fantastiche di cui i lettori erano ghiotti, come le Histoire des Fantomes et des Démons qui se sont montrés parmi les hommes, ou Choix d’anecdotes et de contes, De faits merveilleux, de traits bizarres, d’aventures extraordinaires sur les Revenans, les Fantômes, les Lutins, les Démons, les Spectres, les Vampires, et les apparitions diverses, etc. di Gabrielle de Paban, 1819, autrice il cui nome può non dirci molto, ma che qualcuno ha proposto di identificare in quella Clotilde Marie Paban (1793-?) cugina e moglie di Jacques Collin de Plancy, esperto di cose occulte e fantastiche e autore del famoso Dictionnaire infernal, 1818 (e a quel punto capiremmo meglio). Comunque nel testo di Paban il racconto si intitolava Le Revenant Succube, a rinviare idealmente a quel mondo di letti infestati – dai demoni succubi, appunto – che da secoli conciliano fremiti, timori e pruriti. La storia era piuttosto simile ma ancora più breve, rimandava al novembre 1613 e al posto della ghigliottina c’era (anche qui) una forca.
 Ancora precedente era la narrazione dell’episodio nell’anonimo Le Livre des prodiges, ou Histoires et Aventures merveilleuses et remarquables de Spectres, Revenans, Esprits, Fantômes, Démons, etc., rapportées par des personnes dignes de foi pubblicato dall’editore Pillot nel 1802, che però riproponeva quasi letteralmente il testo di un’altra opera anonima davvero seicentesca, Histoire prodigieuse d’un Gentilhomme auquel le Diable est apparu, et avec lequel il a conversé sous le corps d’une femme morte, advenue à Paris le 1er Janvier 1613, apparsa a Parigi per François du Carroy nello stesso 1613, che tornava allo stesso episodio, alla donna impiccata e al demone ne aveva posseduto il corpo per sedurre un giovanotto. Poi, davanti alla gente, quel corpo era sfumato (letteralmente) e forse il giovane aveva dato di testa. Il messaggio moraleggiante dell’opera seicentesca era di non farsi accalappiare dalle sconosciute (sappiamo che fin dai tempi delle empuse l’incontro per strada era stigmatizzato come pericoloso), con tutti i rischi della promiscuità: ma soprattutto col tempo prevale il piacere del frisson narrativo.
Ancora precedente era la narrazione dell’episodio nell’anonimo Le Livre des prodiges, ou Histoires et Aventures merveilleuses et remarquables de Spectres, Revenans, Esprits, Fantômes, Démons, etc., rapportées par des personnes dignes de foi pubblicato dall’editore Pillot nel 1802, che però riproponeva quasi letteralmente il testo di un’altra opera anonima davvero seicentesca, Histoire prodigieuse d’un Gentilhomme auquel le Diable est apparu, et avec lequel il a conversé sous le corps d’une femme morte, advenue à Paris le 1er Janvier 1613, apparsa a Parigi per François du Carroy nello stesso 1613, che tornava allo stesso episodio, alla donna impiccata e al demone ne aveva posseduto il corpo per sedurre un giovanotto. Poi, davanti alla gente, quel corpo era sfumato (letteralmente) e forse il giovane aveva dato di testa. Il messaggio moraleggiante dell’opera seicentesca era di non farsi accalappiare dalle sconosciute (sappiamo che fin dai tempi delle empuse l’incontro per strada era stigmatizzato come pericoloso), con tutti i rischi della promiscuità: ma soprattutto col tempo prevale il piacere del frisson narrativo.
 In questi ultimi anni alcuni studiosi hanno affrontato il tema, permettendo di recuperare elementi mancanti della filiera. In particolare Florian Balduc ha curato un preziosissimo Colliers de velours. Parcours d’un récit vampirisé (La Fresnaye-Fayel, Otrante, 2015); e Fabio Camilletti prima nello splendido contributo La Sposa, Arsène, o la Biblioteca all’antologia Jolanda & Co. Le donne pericolose (a cura di Fabrizio Foni e di chi scrive, Cut-Up, La Spezia 2017) e poi in un capitolo dell’ottimo Guida alla letteratura gotica (Odoya, Bologna 2018) ha analizzato le strutture di questa saga elusiva.
In questi ultimi anni alcuni studiosi hanno affrontato il tema, permettendo di recuperare elementi mancanti della filiera. In particolare Florian Balduc ha curato un preziosissimo Colliers de velours. Parcours d’un récit vampirisé (La Fresnaye-Fayel, Otrante, 2015); e Fabio Camilletti prima nello splendido contributo La Sposa, Arsène, o la Biblioteca all’antologia Jolanda & Co. Le donne pericolose (a cura di Fabrizio Foni e di chi scrive, Cut-Up, La Spezia 2017) e poi in un capitolo dell’ottimo Guida alla letteratura gotica (Odoya, Bologna 2018) ha analizzato le strutture di questa saga elusiva.
In questa sede non ci interessa seguire (anche se sarebbe un discorso affascinante) i giochi delle varianti tra un testo e l’altro, e un meccanismo genetico che solo con grossolana semplificazione potremmo ricondurre al plagio. L’idea del diritto d’autore come oggi concepito non esisteva, e Nodier – straordinario affabulatore, lettore coltissimo e onnivoro, bibliofilo raffinato che amava reinventare storie altrui nel segno di una scintillante originalità (e poco importa lo facesse a voce, nel corso delle celebri serate con la sua corte di ingegni, o piuttosto per scritto) – l’aveva persino teorizzato. Nel testo Questions de littérature légale, 1812 (Crimini letterari, Duepunti, Palermo 2010), parlando della scrittura, teorizza una disinvoltura negli imprestiti – diciamo pure nei plagi – purché condotti con eleganza. Pensiamo a quella straordinaria lanterna magica che è il suo Infernaliana, 1822, dove – ammiccando al successo della raccolta Fantasmagoriana su cui torneremo – pesca disinvoltamente da storie altrui, trattate con la libertà dei miti condivisi.
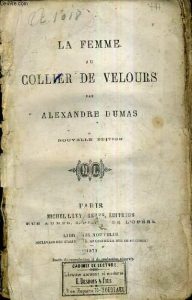 Si è detto che il protagonista della storia, nelle versioni di Irving e di Borel, è l’oscuro studente Gottfried Wolfgang; e il fatto che sia tedesco rinvia ovviamente allo stereotipo geografico gotico che fin dal Settecento vede la Germania associata ai più vari brividi orrifici. Ma Dumas – e già Nodier, se davvero è stato lui a fare da tramite – rafforza questa suggestione imputando il racconto a un giovane tedesco molto particolare, e cioè il futuro scrittore fantastico Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. In sostanza il testo, molto più ampio e ricco dei precedenti, si presenta come un delizioso pastiche in cui compaiono a livelli diversi tre campioni della letteratura – Dumas stesso in termini autobiografici, l’amico più anziano Nodier quale narratore, e Hoffmann come attonito protagonista: un tessuto che conferma la capacità di Dumas di padroneggiare allarmanti fantasie oniriche e potenti quadri storici, e insieme di sperimentare nuove strutture narrative con estrema varietà di toni ed esiti originalissimi. Varietà di toni, appunto, a partire dalla malinconia che inquadra il romanzo e un po’ tutta la raccolta Les mille et un fantômes, in cui Dumas lo incastonerà nel ’51, un periodo greve di senso di morte. Il cenacolo romantico dell’Arsenal degli anni Venti (il primo, straordinario, sorto a Parigi, e che con Dumas accoglieva Victor Hugo e Lamartine, Musset e Delacroix e tanti altri) è ormai disperso, gli amici sono scomparsi o lontani; e il ritratto affettuoso di Nodier, animatore del gruppo, introduce una narrazione che Dumas immagina confidatagli dall’amico sul letto di morte. Dove il sapore di un’antica complicità nel gioco letterario rafforza l’evocazione di un mondo amato e finito, ma insieme sembra protestare davanti a quel capezzale la dignità della fantasia e del darle voce.
Si è detto che il protagonista della storia, nelle versioni di Irving e di Borel, è l’oscuro studente Gottfried Wolfgang; e il fatto che sia tedesco rinvia ovviamente allo stereotipo geografico gotico che fin dal Settecento vede la Germania associata ai più vari brividi orrifici. Ma Dumas – e già Nodier, se davvero è stato lui a fare da tramite – rafforza questa suggestione imputando il racconto a un giovane tedesco molto particolare, e cioè il futuro scrittore fantastico Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. In sostanza il testo, molto più ampio e ricco dei precedenti, si presenta come un delizioso pastiche in cui compaiono a livelli diversi tre campioni della letteratura – Dumas stesso in termini autobiografici, l’amico più anziano Nodier quale narratore, e Hoffmann come attonito protagonista: un tessuto che conferma la capacità di Dumas di padroneggiare allarmanti fantasie oniriche e potenti quadri storici, e insieme di sperimentare nuove strutture narrative con estrema varietà di toni ed esiti originalissimi. Varietà di toni, appunto, a partire dalla malinconia che inquadra il romanzo e un po’ tutta la raccolta Les mille et un fantômes, in cui Dumas lo incastonerà nel ’51, un periodo greve di senso di morte. Il cenacolo romantico dell’Arsenal degli anni Venti (il primo, straordinario, sorto a Parigi, e che con Dumas accoglieva Victor Hugo e Lamartine, Musset e Delacroix e tanti altri) è ormai disperso, gli amici sono scomparsi o lontani; e il ritratto affettuoso di Nodier, animatore del gruppo, introduce una narrazione che Dumas immagina confidatagli dall’amico sul letto di morte. Dove il sapore di un’antica complicità nel gioco letterario rafforza l’evocazione di un mondo amato e finito, ma insieme sembra protestare davanti a quel capezzale la dignità della fantasia e del darle voce.
Con questa avvertenza ideale il lettore passa al racconto di Nodier, e ad un mutamento di registro narrativo verso il notturno hoffmanniano: figure angelicate o dai movimenti oniricamente burattineschi, sensibilità esasperate, una Germania al trapasso tra stile Pompadour e impennate romantiche quale avvio e conclusione dell’apologo. Certo la voce narrante lascia il dubbio su quanto quel clima appartenga ad allucinazione dello stesso Hoffmann – musicista, pittore, letterato, uomo dalle straordinarie ricchezze interiori e dalle travolgenti emozioni che cerca invano di ordinare a equilibrio. Ma insieme conduce sul binario (tanto caro a Dumas) dell’affresco storico innervato da una critica sferzante delle glorie rivoluzionarie di Francia.
 Vediamo dunque il giovane Hoffmann che, dopo aver giurato alla soave fidanzata Antonia di non giocare d’azzardo (una delle attività più biasimate, nella narrativa d’epoca) e di restarle fedele, se ne parte ingenuotto per una sorta di turismo artistico a Parigi. La città però – siamo nel 1793 – è nel pieno del Terrore: e l’incalzare di bozzetti sulla brutalità ottusa e grottesca dei rivoluzionari, sul disgusto del sangue e la cupezza del presunto paradiso delle virtù (una Parigi grigia d’inverno, tagliata dai convogli della Vergine Ghigliottina) pare tanto più interessante alla luce dell’attenzione e del coinvolgimento di Dumas nei turbinosi moti politici del suo tempo.
Vediamo dunque il giovane Hoffmann che, dopo aver giurato alla soave fidanzata Antonia di non giocare d’azzardo (una delle attività più biasimate, nella narrativa d’epoca) e di restarle fedele, se ne parte ingenuotto per una sorta di turismo artistico a Parigi. La città però – siamo nel 1793 – è nel pieno del Terrore: e l’incalzare di bozzetti sulla brutalità ottusa e grottesca dei rivoluzionari, sul disgusto del sangue e la cupezza del presunto paradiso delle virtù (una Parigi grigia d’inverno, tagliata dai convogli della Vergine Ghigliottina) pare tanto più interessante alla luce dell’attenzione e del coinvolgimento di Dumas nei turbinosi moti politici del suo tempo.
L’orrenda morte di Madame du Barry, cui il giovane assiste suo malgrado, sembra recare alla peculiare sensibilità di Hoffmann un’infiammazione foriera di strane conseguenze. Attraverso l’esperienza visionaria all’Opéra, dove è ammaliato dalla danzatrice Arsène amante di Danton, e poi nel tripudio notturno di nudità e gioco del Palais-Royal, Hoffmann passa come Faust lungo i Sabba, trascinato all’infedeltà da un desiderio quasi compulsivo. Nel corso di un goffo incontro con Arsène – era stato convocato per farle il ritratto, non è riuscito a trattenere un bacio ed è stato buttato fuori per l’improvviso arrivo dell’amante di lei – Hoffmann ha capito che solo col denaro può conquistare quella mantenuta d’alto bordo: e si risolve a cercarlo al tavolo da gioco. È troppo preso dalle sue ansie per far caso all’accenno dell’amico Zacharias su una donna bellissima condotta al patibolo. Ma quando, carico di denaro vinto alla bisca, cerca Arsène al suo alloggio non la trova: così rientra scorato attraverso la Parigi notturna e passa (ecco riproporre la scena fatale) per la piazza della ghigliottina. Ovviamente incontra la figura accovacciata; e ovviamente è Arsène, con tanto di collier, che racconta come il suo amante sia stato arrestato e lei sia sfuggita fortunosamente. Ma «Queste parole erano dette con uno strano accento, senza gesti, senza inflessioni; uscivano da una bocca scolorita che si apriva e si chiudeva come mossa da una molla; si sarebbe detto un automa che parlava» (p. 165). Certo Dumas sta giocando con l’immagine di certe oniriche, inquietanti donne-automi dei testi di Hoffmann: e giustamente Camilletti sottolinea i nessi con uno dei racconti più celebri della produzione hoffmanniana, L’uomo della sabbia, con il rapporto tra un altro studente tedesco, Nathanael, e la ragazza-automa Olimpia.
Nei fatti, in questo contesto, Arsène appare una sorta di zombie, o un’ombra mossa a base di istantanee, come in certi B-movie di spettri marca USA. Comunque anche in questa versione il giovane offre ospitalità, mostra anzi di avere dell’oro: allora «L’occhio della ballerina gettò un lampo» (ibidem), e visto che Hoffmann è dubitoso di ospitare la diva nella sua stanzetta è lei a condurlo a un magnifico albergo, camminando «con un passo rigido e automatico che non aveva nulla in comune con l’affascinante morbidezza che Hoffmann aveva ammirato della ballerina» (p. 166). Anzi sulle scale dell’albergo Arsène deve appoggiarsi a lui comunicandogli una sensazione di gelo, e nella stanza si avvicina al fuoco accovacciandosi in modo che «sembrava intenta a reggersi con le mani la testa sulle spalle» (p. 168). Sembra rianimarsi solo di fronte all’oro che il giovane le offre; poi accetta di bere ma non di mangiare («– Non potrei inghiottire – ella disse», p. 170), mentre lui mangia e beve soprattutto per farsi coraggio, «perché qualcosa di gelido emanava dal corpo della bella convitata» (ibidem). E anzi, quando Arsène beve, «alcune gocce rosate cadevano di sotto al nastro di velluto sul petto della ballerina» (ibidem). Hoffmann inizia ad avvertire qualcosa di terribile, e il lettore già immagina dove si voglia andare a parare: l’abilità del narratore sta però nel protrarre il gioco sul terreno dell’onirico e forse dell’allucinazione etilica. Quando il giovane prende a suonare al pianoforte, Arsène sembra trasfigurarsi e inizia a ballare: travolto dal desiderio, Hoffmann le si unisce nella danza e alla fine crollano sul letto. Al mattino, al risveglio, il giovane trova però Arsène rigida e fredda, chiama soccorso: e il medico sopraggiunto (un’inquietante figura di trickster che ricorda il bifronte Coppola/Coppelius de L’uomo della sabbia) lo loda per «aver ricomprato questo corpo affinché non marcisse nella fossa comune» (p. 173). Allo stranito Hoffmann spiega che la danzatrice è stata ghigliottinata il giorno prima; e alle obiezioni del giovane di aver cenato, ballato ed essere andato a letto con lei, il dottore apre il fermaglio del collier. Il rotolare della testa di Arsène sconvolge Hoffmann, che fugge inorridito gridando di essere pazzo, è arrestato e interrogato, cerca invano di ritrovare l’albergo per dimostrare le sue ragioni – e viene salvato dal medico che lo fa passar per folle e poi fuggire. Alla storia segue però un ultimo colpo di scena con la notizia della morte di Antonia, folgorata dal non mantenuto giuramento di fedeltà (in L’uomo della sabbia il protagonista rischiava di uccidere la fidanzata), e l’evaporazione del ritratto di lei dal medaglione tra le mani del fedifrago.
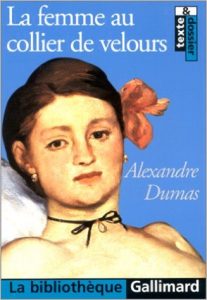 Se il Fantastico, sembra dire Dumas, non è accessibile se non al prezzo di una trasgressione, a condurvi è un insieme di circostanze tutto nel segno del Femminile. La femme fatale è sicuramente uno dei più ricorsivi fantasmi del Romanticismo nero, ad accreditare la donna come essere misterioso, attraente ma pericoloso e a volte demoniaco. Eppure il quadro è meno scontato di quanto possa sembrare di primo acchito. La contrapposizione/rifrazione tra donna fatale, Arsène, e donna angelicata, Antonia, è talmente parossistica da condurre a un paradossale scambio dei ruoli: così, mentre la larva zombizzata con cui Hoffmann si apparta suscita una sorta di greve compassione, è Antonia a imporre al fidanzato un giuramento sull’Eucarestia dal retrogusto minaccioso di inesorabilità – quasi sia lei, in qualche modo, la vera donna fatale, oppure le due si confondano in un’unica donna musicale (Antonia canta come Arsène danza) schizofrenicamente scissa nel mondo allucinato del protagonista. In fondo entrambe le teste cadono, quella di Arsène materialmente, quella di Antonia sparendo dal ritratto.
Se il Fantastico, sembra dire Dumas, non è accessibile se non al prezzo di una trasgressione, a condurvi è un insieme di circostanze tutto nel segno del Femminile. La femme fatale è sicuramente uno dei più ricorsivi fantasmi del Romanticismo nero, ad accreditare la donna come essere misterioso, attraente ma pericoloso e a volte demoniaco. Eppure il quadro è meno scontato di quanto possa sembrare di primo acchito. La contrapposizione/rifrazione tra donna fatale, Arsène, e donna angelicata, Antonia, è talmente parossistica da condurre a un paradossale scambio dei ruoli: così, mentre la larva zombizzata con cui Hoffmann si apparta suscita una sorta di greve compassione, è Antonia a imporre al fidanzato un giuramento sull’Eucarestia dal retrogusto minaccioso di inesorabilità – quasi sia lei, in qualche modo, la vera donna fatale, oppure le due si confondano in un’unica donna musicale (Antonia canta come Arsène danza) schizofrenicamente scissa nel mondo allucinato del protagonista. In fondo entrambe le teste cadono, quella di Arsène materialmente, quella di Antonia sparendo dal ritratto.
In realtà Antonia, scopriremo, è spirata in occasione del bacio che il fidanzato infedele ha dispensato ad Arsène ancora viva: da morta, la danzatrice non danneggia Hoffmann più di quanto già non faccia la sua fragilità nervosa. Ma Arsène è già uno spettro in vita, vampirizzata da una dimensione di desiderio esaurita nell’utile (un amore per la ricchezza che l’accompagna persino post mortem – se il tutto, ovviamente, non è un’allucinazione): ed è interessante che Hoffmann stesso, pur di avvicinarla, accetti l’idea di un rapporto sostanzialmente mercenario o di consumo. Cui potrà seguire, non lo esclude, il ritorno da Antonia: con un sapore provocatoriamente moderno, la tentazione sembra insomma non assumere lo statuto abissale della passione che sperde in derive lontane, quanto piuttosto la maschera immatura dell’irresponsabilità qui e ora, da cui il ritorno si pretenderebbe sempre possibile.
 La reazione un po’ stranita di Hoffmann verso Arsène-similacro (chiamiamola così) è in fondo simile – mostra Camilletti, alla cui ampia disamina naturalmente rinvio – a quella verso Olimpia di Nathanael, cui torna in mente (recita il racconto) «la leggenda della fidanzata morta». O, com’è più nota, della sposa morta, della sposa cadavere: leggenda di origine forse ashkenazita, trascritta nella raccolta Shivhei ha-Ari (XVI sec.), recuperata in chiave di apologo contemporaneo come Die Todtenbraut da Friedrich August Schulze nella raccolta Gespensterbuch curata con Johann August Apel (1811-15), di lì tradotta come La Morte fiancée da Jean-Baptiste Benoît Eyriès nell’antologia Fantasmagoriana (1812, la famosa lettura di Villa Diodati) e traghettata fino a Tim Burton. Di più: nel racconto di Schulze approdato in Fantasmagoriana si trovano gli elementi della danza forsennata, di un giuramento fatale, del collo coperto della misteriosa dama e persino di un ruolo ambiguo di sapiente (il medico-trickster). Visto che l’affabulatore Nodier conosceva Fantasmagoriana, non stupisce scoprire che lui narrasse splendidamente (attesta Victor Hugo) una storia della “morte mariée”, probabilmente il racconto di Schulze nella versione francese. E stupisce ancor meno che J.P.R. Cuisin riporti una simile storia, La morte mariée, nell’antologia Spectriana (1817, ennesima gemmazione dal successo di Fantasmagoriana) sostenendo che gli è stata narrata da «[u]n giovane Drammaturgo che pratica con successo la letteratura del nord»… Così che Arsène finisce con l’essere realmente una sorta di ipostasi dell’Arsenal, la leggendaria biblioteca di cui Nodier è a lungo bibliotecario: nel senso di avatar libresco di infinite storie sedimentate in modo sfuggente, fantasmatico (chi è il vero autore, e in quale percentuale?) in libri alla deriva del tempo.
La reazione un po’ stranita di Hoffmann verso Arsène-similacro (chiamiamola così) è in fondo simile – mostra Camilletti, alla cui ampia disamina naturalmente rinvio – a quella verso Olimpia di Nathanael, cui torna in mente (recita il racconto) «la leggenda della fidanzata morta». O, com’è più nota, della sposa morta, della sposa cadavere: leggenda di origine forse ashkenazita, trascritta nella raccolta Shivhei ha-Ari (XVI sec.), recuperata in chiave di apologo contemporaneo come Die Todtenbraut da Friedrich August Schulze nella raccolta Gespensterbuch curata con Johann August Apel (1811-15), di lì tradotta come La Morte fiancée da Jean-Baptiste Benoît Eyriès nell’antologia Fantasmagoriana (1812, la famosa lettura di Villa Diodati) e traghettata fino a Tim Burton. Di più: nel racconto di Schulze approdato in Fantasmagoriana si trovano gli elementi della danza forsennata, di un giuramento fatale, del collo coperto della misteriosa dama e persino di un ruolo ambiguo di sapiente (il medico-trickster). Visto che l’affabulatore Nodier conosceva Fantasmagoriana, non stupisce scoprire che lui narrasse splendidamente (attesta Victor Hugo) una storia della “morte mariée”, probabilmente il racconto di Schulze nella versione francese. E stupisce ancor meno che J.P.R. Cuisin riporti una simile storia, La morte mariée, nell’antologia Spectriana (1817, ennesima gemmazione dal successo di Fantasmagoriana) sostenendo che gli è stata narrata da «[u]n giovane Drammaturgo che pratica con successo la letteratura del nord»… Così che Arsène finisce con l’essere realmente una sorta di ipostasi dell’Arsenal, la leggendaria biblioteca di cui Nodier è a lungo bibliotecario: nel senso di avatar libresco di infinite storie sedimentate in modo sfuggente, fantasmatico (chi è il vero autore, e in quale percentuale?) in libri alla deriva del tempo.
 Ora, la Sposa Cadavere è – anzitutto – una mancata sposa: e dunque infelice, frustrata, a richiamare l’antica figura dell’ά̉ωρος, colui che è morto prima del tempo prescritto – compresi coloro che sono morti senza potersi sposare come avrebbero desiderato. In particolare se fidanzati, e dunque bloccati nel tempo tra due patti solenni, fidanzamento e matrimonio, entrambi modificativi d’uno status: ma se il secondo patto definisce una condizione esistenziale, il primo confina in una situazione in progress, liminare e transitoria, e una morte in quel momento espone a gravi rischi. In quei rischi è probabilmente incappata la Filinnio di Flegonte di Tralle (rinvio alla spettacolare edizione dell’opera flegontea, Il libro delle meraviglie e tutti i frammenti, a cura di Tommaso Braccini e Massimo Scorsone, Einaudi, Torino 2013), la non-morta citata a monte di tutti i repertori vampireschi e poi ripresa in nero da Goethe in La sposa di Corinto, ma che nel suo pathos originario non ha nulla di oscuro; in quei rischi è di certo incappata la figura nota come danseuse nocturne (per esempio la Wili slava, fidanzata morta prima delle nozze che con le compagne costringe il maschietto che abbia la sventura d’incontrarle a danzare fino alla morte) la cui storia folklorica precipiterà nel libretto Giselle di Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges (1841).
Ora, la Sposa Cadavere è – anzitutto – una mancata sposa: e dunque infelice, frustrata, a richiamare l’antica figura dell’ά̉ωρος, colui che è morto prima del tempo prescritto – compresi coloro che sono morti senza potersi sposare come avrebbero desiderato. In particolare se fidanzati, e dunque bloccati nel tempo tra due patti solenni, fidanzamento e matrimonio, entrambi modificativi d’uno status: ma se il secondo patto definisce una condizione esistenziale, il primo confina in una situazione in progress, liminare e transitoria, e una morte in quel momento espone a gravi rischi. In quei rischi è probabilmente incappata la Filinnio di Flegonte di Tralle (rinvio alla spettacolare edizione dell’opera flegontea, Il libro delle meraviglie e tutti i frammenti, a cura di Tommaso Braccini e Massimo Scorsone, Einaudi, Torino 2013), la non-morta citata a monte di tutti i repertori vampireschi e poi ripresa in nero da Goethe in La sposa di Corinto, ma che nel suo pathos originario non ha nulla di oscuro; in quei rischi è di certo incappata la figura nota come danseuse nocturne (per esempio la Wili slava, fidanzata morta prima delle nozze che con le compagne costringe il maschietto che abbia la sventura d’incontrarle a danzare fino alla morte) la cui storia folklorica precipiterà nel libretto Giselle di Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges (1841).
Ma in secondo luogo la Sposa è un cadavere, che cerca un contatto anche fisico – con quanto di Perturbante ciò evochi. Anche nel dubbio radicale su una qualche certezza del confine tra ciò che vive e ciò che è morto: un’ossessione del tempo dei Lumi che però poi si riproporrà ancora per tutto l’Ottocento come terrore del seppellimento prematuro. Non sembra un caso, aggiungerei, che due ritornanti come la Berenice di Poe e la Lucy Westenra del Dracula siano entrambe promesse spose.
 Al di là dunque dell’indubbio omaggio che Dumas – che amava i pastiche – fa alla memoria del vecchio amico, almeno virtualmente Nodier potrebbe aver reinventato la storia pervenutagli da chissà quali voci (Borel? Irving? Paban? gli autori anonimi precedenti?); e d’altra parte – scrivevo a suo tempo con eccessiva prudenza – “il racconto potrebbe persino rimandare, chissà, a una sorta di leggenda metropolitana dei giorni del Terrore”. Camilletti conferma, sulla base di una mappatura più ampia e del raccordo con un’intera costellazione di storie sulla Sposa Cadavere, che proprio di leggenda metropolitana si tratta, ma con radici ben più antiche: e richiama da un lato il bacino di leggende sull’autostoppista fantasma (torniamo alla Melissa di Danilo Arona) e dall’altro il filone parallelo della morta che va a ballare, che con la danza di Arsène e altre che vedremo presenta alcuni nessi. Tanto più che il meccanismo è sempre quello – classico delle leggende metropolitane – della storia che arriva dall’amico di un amico; tanto più che la storia del collier di velluto (e capi analoghi, secondo la moda delle rispettive stagioni) rimanda, fin dalle prime edizioni, a uno sfuggente contesto urbano. La città dove non ci conosce e dove chi incontriamo casualmente potrebbe ben essere un fantasma.
Al di là dunque dell’indubbio omaggio che Dumas – che amava i pastiche – fa alla memoria del vecchio amico, almeno virtualmente Nodier potrebbe aver reinventato la storia pervenutagli da chissà quali voci (Borel? Irving? Paban? gli autori anonimi precedenti?); e d’altra parte – scrivevo a suo tempo con eccessiva prudenza – “il racconto potrebbe persino rimandare, chissà, a una sorta di leggenda metropolitana dei giorni del Terrore”. Camilletti conferma, sulla base di una mappatura più ampia e del raccordo con un’intera costellazione di storie sulla Sposa Cadavere, che proprio di leggenda metropolitana si tratta, ma con radici ben più antiche: e richiama da un lato il bacino di leggende sull’autostoppista fantasma (torniamo alla Melissa di Danilo Arona) e dall’altro il filone parallelo della morta che va a ballare, che con la danza di Arsène e altre che vedremo presenta alcuni nessi. Tanto più che il meccanismo è sempre quello – classico delle leggende metropolitane – della storia che arriva dall’amico di un amico; tanto più che la storia del collier di velluto (e capi analoghi, secondo la moda delle rispettive stagioni) rimanda, fin dalle prime edizioni, a uno sfuggente contesto urbano. La città dove non ci conosce e dove chi incontriamo casualmente potrebbe ben essere un fantasma.
[2-Continua]





